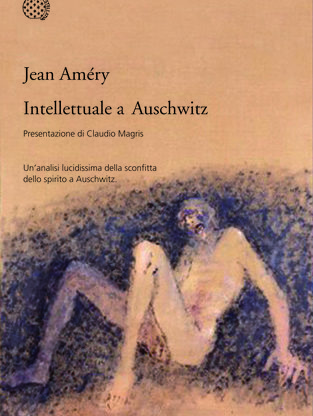Jean Améry, intellettuale a Auschwitz
Di Enna Graziella
Ne I sommersi e i salvati, la più lucida e completa disamina del fenomeno concentrazionario, Primo Levi dedica un intero capitolo al filosofo Jean Améry che riassume in sintesi i temi più importanti trattati nei cinque saggi di Intellettuale ad Auschwitz. Ciò che accomuna i due scrittori è l’aver scritto i loro testi a distanza di decenni dalla prigionia con lo scopo di comprendere e analizzare a mente fredda l’assurda e illogica degenerazione intrinseca allo sterminio nazista. Si conobbero tramite un carteggio dopo la liberazione essendosi riconosciuti nei rispettivi scritti, ma mentre Levi non ha memoria di lui nel campo, Améry sostiene di ricordarlo per un breve periodo nella stessa baracca e di non averlo dimenticato proprio perché gli italiani erano, in proporzione, in numero minore. Entrambi morirono suicidi: si potrebbero addurre migliaia di motivazioni psicoanalitiche sui motivi del loro gesto, non ultima quella della difficoltà di superare e metabolizzare i ricordi.
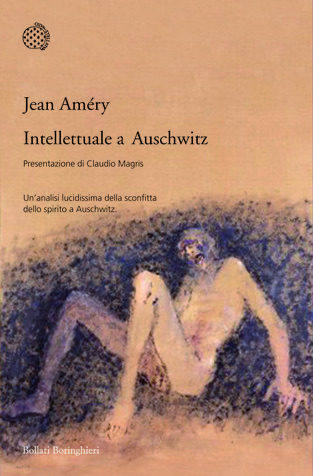
Jean Améry è lo pseudonimo di Hans Meyer che egli assume dopo la fine della guerra. Nato a Vienna nel 1912 da una famiglia di origine ebraica non praticante, aveva compiuto studi letterari e filosofici. Dopo l’annessione dell’Austria alla Germania nazista si trasferì in Belgio e partecipò alla Resistenza prima dell’arresto e dell’internamento ad Auschwitz e in altri campi. Nel 1966 pubblicò il suo eccezionale saggio capace di turbare la coscienza dei lettori con riflessioni di straordinaria profondità e ancora vive nel presente. Uno dei suoi meriti è infatti quello di attualizzare le sue vicende e corredarle di esempi relativi alla società che lo circonda. Quest’opera insieme con “I sommersi ed i salvati” si può considerare un testamento spirituale in quanto entrambi gli autori analizzano il processo di negazione dell’umanità, l’annientamento fisico e spirituale, la dignità offesa, lo sradicamento coatto, la violazione delle leggi divine e umane e di ogni forma di diritto naturale. Améry non scrive un dettagliato resoconto dell’esperienza nel lager, ritiene che esista già un’accurata documentazione che ha esposto in maniera doviziosa il tutto. Ha invece come obiettivo quello di dimostrare la sconfitta dello spirito dell’intellettuale costretto alla prigionia, portando avanti, con una prosa argomentativa di stampo filosofico, dissertazioni a volte scomode, provocatorie, ben lungi dalla sua volontà di dimenticare e perdonare. Giunge pertanto a una conclusione di amaro nichilismo perché ha assistito alla disgregazione totale non solo di un’epoca ma anche di ogni valore, perciò la sua posizione di pensatore pessimista radicale si distacca dalla saccenteria e dall’ottimismo di molti intellettuali, alcuni dei quali si mostrano frivoli negazionisti o ferventi sostenitori di ideologie politiche che possano arrecare una convenienza. Nella prefazione alla prima edizione del 1966 Améry si sofferma sulla difficoltà di scrivere un saggio con i tratti distintivi tipici del genere che al contempo possa annoverare anche una serie di meditazioni e ripensamenti. Per questo motivo i cinque saggi, che compongono i rispettivi capitoli, non si dipanano seguendo un filo logico bensì nell’ordine in cui sono stati ideati nella sua mente a seconda dell’urgenza di spiegare e trovare risposte alle contraddizioni in cui il suo spirito si sente invischiato e avviluppato. Non intende rivolgersi ai propri compagni di sventura, già tristemente edotti, bensì a quei tedeschi che non si sentono responsabili degli atti compiuti durante il Terzo Reich.
Quando poi scrive la prefazione alla seconda edizione nel 1976, Améry sostiene che a distanza di tempo il nazismo non abbia cessato di celebrare i suoi macabri trionfi postumi, come se avesse gettato legittime basi per invasioni, aggressioni, torture che hanno caratterizzato la storia del secondo Novecento. Non può razionalmente accettare motivazioni lecite dell’ascesa del fascismo e del nazismo, nulla può giustificare simili perversioni ideologiche e pertanto non intende fornire una spiegazione plausibile o una verità univoca. La sua reale preoccupazione è la recrudescenza dell’antisemitismo in diverse nazioni europee, vittime e carnefici ormai sono estinti ma sembrano rinverdire nelle nuove generazioni, seppur cresciute in libere democrazie, perciò si sente in dovere di lanciare un allarme e un monito per scongiurare questa minaccia incombente. I fatti storici avvenuti non devono divenire un mero ricordo, tantomeno devono essere archiviati come chiariti, assodati, spiegati in via definitiva. Al contrario invece è necessario ribellarsi e non accettare facili e sbrigative interpretazioni riguardo a eventi che risultano incomprensibili benché vergognosamente veri.
La prima tematica esaminata riguarda il problema del confronto tra Auschwitz e spirito. Egli parte da una definizione necessaria e indispensabile per capire la sua riflessione: intende delineare la figura dell’ “intellettuale puro”, non un professionista esperto in un determinato settore, bensì un essere umano che si muove in un ambito umanistico, artistico e filosofico e in una sfera prettamente spirituale. In questo modo classifica se stesso per far comprendere al lettore la sua posizione che si dimostra spiacevole e svantaggiosa nei campi in cui ha subito la prigionia, cioè Auschwitz-Monowitz, Buchenwald, Bergen Belsen. Chiunque nel lager fosse in grado di esercitare un lavoro manuale con una qualifica precisa o fosse un professionista in ambito tecnico o scientifico aveva maggiori possibilità di sopravvivere perché addirittura poteva lavorare al chiuso in fabbriche o officine. Chi invece esercitasse una professione dell’ingegno era destinato ai lavori più duri di manovalanza all’aperto e andava incontro a una morte quasi certa. Docenti universitari, storici, matematici, psicologi, avvocati, giusto per fare qualche esempio, divenivano i “paria” del campo, dimostravano di non essere avvezzi al lavoro fisico perciò erano eliminati dal processo produttivo e spesso finivano nelle camere a gas. Paradossale limite, nel mondo alla rovescia e straniato del campo, era anche il linguaggio dell’intellettuale, in quanto subentrava un problema di incomunicabilità con la maggior parte dei compagni di prigionia. Il lessico quotidiano si riduceva all’utilizzo di pochi vocaboli prosaici, a volte brutali, che afferivano a un gergo tipico del campo, di difficile utilizzo per un intellettuale, che si sentiva per questo ancora più isolato. Forse il lettore può trovare strano che l’uomo di spirito non si rifugiasse nei suoi ricordi, non trovasse un momento di elevazione spirituale e consolazione nella sua cultura o non cercasse di estraniarsi da tutta quella brutalità e abiezione bramando conforto in un mondo di arte e bellezza, ma, come ci dice Améry, ciò non era possibile a lui, forse ad altri e in rari momenti. Mentre moriva di freddo e di inedia, il prigioniero non era solo disumanizzato ma anche despiritualizzato, incapace di pensieri profondi, di riflessioni salvifiche. Pertanto risulta chiaro che avesse molti meno strumenti a disposizione per salvarsi rispetto agli altri. Altro punto esaminato è la differenza tra l’intellettuale puro, umanista, scettico e disilluso e il prigioniero animato e sostenuto da ideologie religiose o politiche ben radicate che fornivano un saldo punto d’appoggio e l’illusione di trovare un giorno un riscatto o una redenzione. Da questa riflessione scaturisce l’abbandono totale di ogni speranza per chi non alimentasse tali certezze e la consapevolezza di una morte onnipresente, squallida, accompagnata da violenze e patimenti e di certo priva dei connotati estetici descritti in sublimi opere letterarie, filosofiche o musicali. L’intellettuale che scampava al campo aveva perso ormai ogni entusiasmo, ogni forma di boria metafisica e diveniva cosciente della propria condizione di disorientamento e di vuoto che sancivano la sconfitta totale dello spirito.
Il secondo saggio affronta il tema della tortura. Punto di partenza è l’amara cognizione che, nonostante la sua abolizione, sia stata utilizzata su migliaia di persone e nel secondo dopoguerra ne sono palesi le prove in tanti stati. Egli fu arrestato e torturato per propaganda antinazista in Belgio e condotto dopo il preliminare interrogatorio nella fortezza di Breedonk, una sorta di campo di raccolta, dove fu imprigionato e torturato. Consapevole del significato di essere destinato a un simile luogo, la sua prima considerazione riguarda i connotati degli uomini della Gestapo: persone comuni, non visi duri o torvi, segnati da cicatrici, ma volti normali la cui regolarità gli suscita una maggiore e più inquietante preoccupazione. Burocrati o piccolo borghesi qualunque erano divenuti dispensatori di maltrattamenti. Durante l’interrogatorio subisce la prima di una serie di percosse, nulla in confronto alle indicibili torture che avrebbe subito, ma fu quel primo colpo a sancire il momento di frattura in cui da detenuto si sente abbandonato a se stesso e perduto. La violenza gratuita e ingiustificata rappresenta per il filosofo la perdita totale della fiducia nel mondo perché chi colpisce, viola i confini dell’io, la sua dignità. La sopraffazione fisica da cui non ci si può salvare o difendere diviene perciò una forma di annientamento della vita. Amèry vuole motivare la sua convinzione che la tortura sia stata l’essenza e l’apoteosi del nazionalsocialismo. Parte dal presupposto che, sebbene non sia stata inventata in seno al nazismo, tuttavia i seguaci di Hitler si basavano sull’idea di doversi abituare a torturare e a distruggere per annullare la propria capacità di provare compassione e misericordia. Questa prerogativa li avrebbe resi grandi e degni di ammirazione presso i posteri. Ritiene pertanto che sia stata una mistificazione politica quella di associare il dominio di Hitler agli altri totalitarismi del Novecento, non perché non fossero efferati o privi di abomini, ma per il fatto che alla base avevano almeno un barlume di ideologia per quanto si potesse considerare errata, mentre il nazismo era solo malvagità allo stato puro, sterminava e rendeva schiavi, trionfava beffardamente e con sadismo su coloro che destinava alla sofferenza e alla morte. Améry, da grande e profondo intellettuale, disquisisce in termini filosofici, psicoanalitici, storici e antropologici e giunge a due conclusioni: la prima è che un mondo dominato dalla morte e dalla distruzione non può esistere, ai degenerati aguzzini non importa la perpetuazione del mondo, perché la tortura ne è il rovesciamento, uno sterile e improduttivo mors tua vita mea; l’altra è un’amara riflessione che riguarda principalmente se stesso, cioè l’incapacità di dimenticare e la convinzione che non avverrà mai alcun processo di rimozione. La fiducia nel mondo crollata in lui con la prima percossa ricevuta, cessa definitivamente con la tortura e non può essere riconquistata. Gli rimangono solo angoscia e risentimento.
Nel terzo saggio, dal titolo “Di quanta terra ha bisogno l’uomo”, il filosofo affronta un altro penoso problema cioè lo sradicamento e la perdita della patria e, nel suo caso, anche dello spirito identitario. Egli si ritrova nel mondo dopo la terribile esperienza della tortura e del lager senza una Heimat, una patria, un focolare, nessuno che lo aspetti. L’unico elemento che lo lega alla sua origine è il nome tedesco a cui poi egli rinuncia quasi per gridare al mondo la sua rabbia, ma quella tanto agognata Heimat che diviene in lui sinonimo di sicurezza non esiste più ed è sostituita nella sua vita dal disorientamento e dalla dispersione. Sebbene l’esilio possa offrire una nuova patria, l’adattarsi non può essere un atto spontaneo ma richiede un notevole sforzo spirituale, non è certo quel naturale processo per cui nella propria patria si apprende spontaneamente la lingua madre pur senza conoscerne la grammatica. Una nuova patria pertanto è qualcosa di artificioso, perché solo quella dell’infanzia e della giovinezza è l’unica e vera Heimat. Altro aspetto rilevante è quello linguistico, la lingua madre decontestualizzata si riduce ad un utilizzo di mera natura burocratica e utilitaristica, perde tutta la bellezza della tradizione del suo retroterra culturale. L’esule del Terzo Reich si trova defraudato e privato non solo della sua dignità di persona ma anche del suo passato e delle sue origini, perciò il dopo Auschwitz non può essere paragonato a nessun altro esilio, la malattia del reduce con l’andar del tempo peggiora e la mancanza di una Heimat si acuisce con la vecchiaia quando ci si rende conto che non possederne una è un danno incalcolabile. Anche in questo saggio l’autore arricchisce il suo discorso con il suo retaggio culturale filosofico e letterario e argomenta in modo ineccepibile dimostrando di essere un profondo e critico conoscitore delle dinamiche storiche e sociali europee ante e post belliche.
Il quarto saggio “Risentimenti” è quello che l’autore considera più difficile da seguire, si scusa preventivamente con i lettori se le sue riflessioni appaiano polemiche, forse ostiche e, in taluni casi, prive delle consuete buone maniere che uno scrittore dovrebbe usare. Il risentimento che nasce in lui, domina la sua esistenza cresce e si alimenta negli anni. Non emerge quando, sentendosi come un ignobile insetto kafkiano o un misero mucchio di ossa, è rimesso in piedi con migliaia di altri sventurati da caritatevoli assistenti della Croce Rossa, bensì più tardi, quando il sentimento collettivo di odio per la Germania si tramuta in disprezzo. Si sdegna di fronte a certe diagnosi mediche che rendono i perseguitati casi clinici di varie patologie psichiche e si dissocia anche dall’autocommiserazione che nel prigioniero ritiene sostituita piuttosto da una tendenza a disprezzarsi e autodistruggersi. Ecco, il suo non è vittimismo, ma voglia di fare chiarezza, spiegare le motivazioni profonde del suo legittimo rancore. Anch’egli condivide la tesi della colpa collettiva dei tedeschi, ricorda bene gli sguardi indifferenti di chi aveva visto scaricare mucchi di cadaveri senza provare nessuna espressione di sdegno. Tuttavia i tedeschi nel dopoguerra si considerarono essi stessi vittime dopo i combattimenti in Russia, i bombardamenti, il processo di Norimberga e avevano voglia di risollevarsi, allontanarsi da quel periodo e dimenticare il Terzo Reich. Nella Germania occidentale, lui vivente, tuttavia erano ancora attivi personaggi che erano stati vicini ai nazisti: tutto questo non fa che rinfocolare e rintuzzare la sua acredine. La sua non è neppure sete di vendetta, in toto, tanto più che molti persecutori e omicidi del Reich avevano pagato con la vita perciò sarebbe potuta essere una forma di soddisfazione, non sufficiente certo a smorzare l’angoscia esistenziale che lo attanaglia per tutta la vita. Trova inoltre disdicevole e ritiene innaturale il perdono e l’oblio determinati dall’ignavia e dalla convenienza, o il rimarginarsi delle ferite operato dal tempo. Reputa inoltre improduttivo far ricadere le colpe dei padri sulla gioventù tedesca, che seppur decidesse di affrancarsi dalla storia non potrebbe negare quei tremendi dodici anni che costituiscono comunque parte delle sue radici. Nota con rammarico che col tempo i ruoli si siano invertiti, la colpa collettiva grava sulle persone sbagliate perché il mondo che perdona e dimentica ha condannato le vittime e non coloro che commisero i misfatti. A proposito di perdono, cito il giudizio espresso da Améry nei confronti di Primo Levi che egli definì “il perdonatore”. In realtà Levi non perdona affatto i suoi carcerieri tantomeno è disposto a farlo in tutte quelle occorrenze in cui domina l’ingiustizia, preferisce delegare le punizioni e le vendette alle leggi dello stato. Tuttavia si dimostra empatico e comprende la posizione di Améry, probabilmente anche lui avrebbe nutrito lo stesso risentimento del filosofo se fosse stato torturato, privato della sua identità nazionale e condannato a un perpetuo esilio. Alla fine anche Améry, dopo aver spiegato e disaminato le sue tesi sul risentimento giunge alla rassegnata conclusione che prima o poi il Terzo Reich diverrà un incidente della storia, un evento come tanti che sarebbe potuto accadere ovunque.
Ultimo saggio è intitolato “Obbligo e impossibilità di essere ebreo”. Amèry si sente impossibilitato ad essere un ebreo non ha mai coltivato le tradizioni e la cultura ebraiche e neppure l’aspetto religioso. Non è certo animato dal fervore che nutriva un deportato come Elie Wiesel e come lui, migliaia di altri. Apprende da adulto le origini ebree della sua famiglia e l’esistenza della lingua yiddish, ma sa bene che essere ebreo ha ben altro significato, non bastano solo le radici, ma serve la condivisione di tradizioni e riti. Quando vengono emanate le leggi di Norimberga capisce che riguardano anche lui, diventa ebreo per una decisione di carattere politico ma non cambia il suo retaggio culturale, solo il suo status sociale di futuro reietto. Presagisce con lucido terrore che quelle funeste leggi decretino la sua condanna a morte. Da quel momento si diffondono aberranti pregiudizi sulla presunta malvagità, pigrizia, bruttezza e deformità degli ebrei, esseri inadatti a integrarsi nella società del Reich, indegni di essere amati e rispettati, capaci solo di contaminare i luoghi pubblici con la loro sgradita presenza, in poche parole subumani da eliminare dal mondo. Il filosofo asserisce che non fu solo la Germania a negare la dignità agli ebrei, ma il mondo intero. Adduce come esempio che nel dopoguerra molte nazioni furono pronte ad accogliere profughi provenienti da diversi paesi a governo comunista, mentre gli ebrei non furono accolti da nessuno benché si sapesse che una terribile sorte li attendesse nel Reich. Persino l’organizzazione interna dei lager li relegò in ultima posizione in una blasfema gerarchia etnica e anche sociale dove anche il più incallito delinquente diveniva superiore a un ebreo. Perciò egli sostiene che il lager divenga una sorta di microcosmo e di proiezione del mondo esterno che aveva comunque assegnato una collocazione infima agli ebrei, nessuno del resto fu capace di opporsi quando in tutta Europa essi venivano prelevati con la violenza dalle proprie dimore. Il nazismo diviene l’istituzionalizzazione per eccellenza di ogni forma di sopraffazione e di brutalità per privare un popolo della sua rispettabilità. Amèry si convince che per preservare la sua dignità in un simile contesto possa ricorrere alla ribellione anche se non crede di rendersi un eroe. Al contrario vive nella paura, prima della deportazione per la sua attività nella Resistenza belga e, durante la prigionia, per il terrore delle violenze. Un episodio emblematico lo riporta alla consapevolezza di poter rivendicare una parvenza di rivalsa seppur il suo spirito dimorasse in un corpo macilento e incrostato di sporcizia: si ribella ai colpi di un kapò e gli sferra un pugno. Giacché la sua limitata e modesta attività nella Resistenza non aveva dato i suoi frutti, questo è l’unico momento in cui riesce a esprimere il suo dissenso in modo concreto. Dopo la liberazione Améry non si interessa alla causa ebraica perché non si sente ebreo, solo il numero tatuato nell’avambraccio ha sancito irrevocabilmente la sua condizione di ebreo. In ogni suo giorno ha ricordato Auschwitz e quel primo pugno ricevuto durante l’interrogatorio con cui ha perso la fiducia nel mondo per sempre. La sua impossibilità di essere ebreo non gli ha impedito di essere solidale con tutti gli ebrei discriminati e minacciati anche dopo il Terzo Reich, tantomeno di contrapporsi a tutte le ingiustizie e i soprusi che avvengono in ogni parte del mondo. La sua speranza si incarna così in una sorta di personale “social catena” leopardiana per dimostrare che, sebbene Auschwitz l’abbia voluto spogliare della sua dignità e abbia sconfitto il suo spirito di intellettuale, non gli ha potuto sottrarre la capacità di tornare umano.
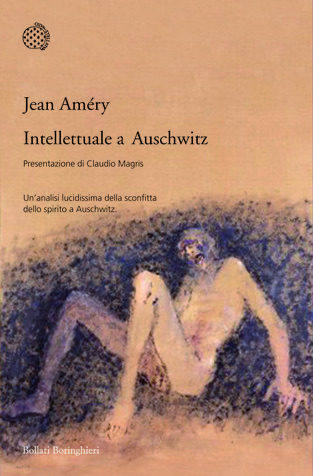 Intellettuale a Auschwitz
Intellettuale a Auschwitz
Varianti
Saggistica
Bollati Boringhieri
2011
165 p., brossura