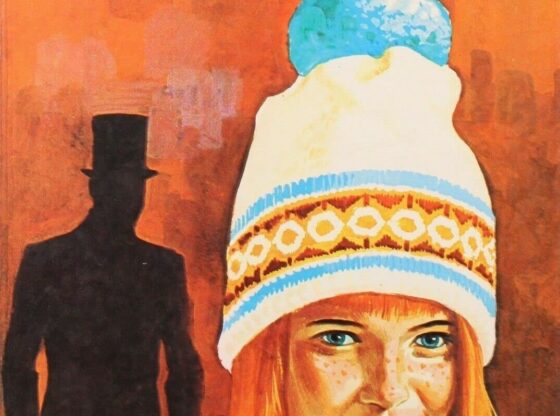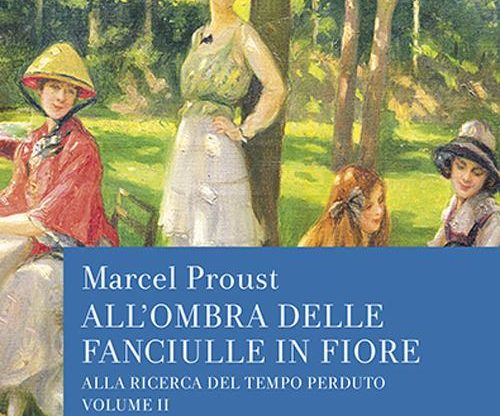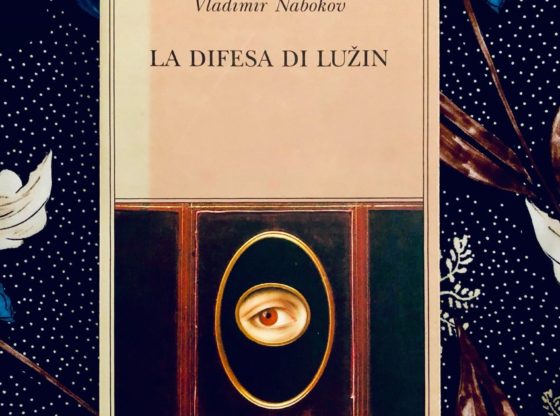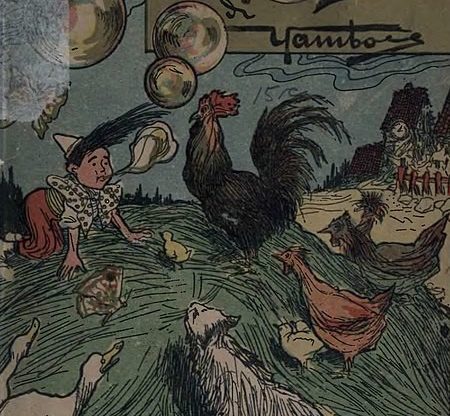Ribellione e sgretolamento dell’io di fronte alla società moderna.
Di Graziella Enna
Articolo apparso anche sulla rivista Euterpe (NdR)
Nel frontone del tempio di Apollo a Delfi era incisa la famosa scritta “γνῶθι σαυτόν”, monito alla ricerca e all’indagine rivolto all’uomo per indurlo a scoprire la propria individualità e la propria essenza. Conoscere se stessi è il primo passo per comprendere il mondo, è il principio cardine della filosofia e della letteratura classica volto a creare gli archetipi su cui si basa la cultura occidentale. Nella nostra storia letteraria si assiste a una crisi profonda dell’io nel rapportarsi alla società che lo circonda, soprattutto dall’Ottocento in poi. Già in piena età illuministica con Alfieri si configura tale conflitto che diverrà più avanti tematica dominante nella letteratura: egli lo trasmette ai personaggi delle sue tragedie facendoli ergere potenti nella loro titanica aspirazione alla ribellione estrema per affermare se stessi e superare ogni limite, generando una frattura insolubile la cui unica via d’uscita praticabile diviene la morte. Alfieri, raccontando la sua “Vita”, mirabile biografia, pur di far prevalere la propria individualità, rifiuta ogni forma di potere precostituito, definito univocamente tirannide, per imporre il suo spirito libertario, la sua passionalità sfrenata. Per questo aborre la cosiddetta “musa appigionata”, la letteratura che serve il potere, e contrappone il suo ideale di letterato, libero, sradicato da ogni imposizione, solitario e sdegnoso. E’ però dall’Ottocento che l’intellettuale si pone in deciso contrasto con la società, che, dopo la Rivoluzione Industriale, ha subito radicali cambiamenti, ha scompaginato l’equilibrio della natura e i processi produttivi legati all’economia. Il poeta si domanda quali siano il valore e il senso della poesia e dell’arte nel mondo moderno, (improntato al guadagno e al capitalismo), e che ruolo essa possa rivestire in una società frenetica e spersonalizzata dalle aride leggi del mercato. Questi, e altri insolubili interrogativi, causano la crisi di coscienza fin dalla stagione romantica, ma si acuiscono nel secondo Ottocento quando l’artista si sente completamente declassato, avulso da quell’enorme ingranaggio che soffoca l’individualismo di spiriti eletti a favore dell’omologazione. Gli intellettuali perdono il ruolo guida privilegiato detenuto nei secoli passati, si ripiegano in se stessi, nella dimensione dell’inconscio, si esprimono con un linguaggio simbolico, analogico, ai limiti dell’oscuro, rivolgendosi non più a un vasto pubblico immerso nei mediocri valori borghesi ma a una cerchia elitaria in grado comprendere la propria arte. Rappresentativa, in proposito la figura del poeta-albatros di Baudelaire, leggiadro nei suoi voli ma goffo e impacciato sulla tolda della nave e dileggiato dai marinai che lo catturano. (“L’albatros”, VV. 9-16)
Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato!
E comico e brutto, lui prima così bello!
Chi gli mette una pipa sotto il becco,
chi imita, zoppicando, lo storpio che volava!
Il Poeta è come lui, principe delle nubi
che sta con l’uragano e ride degli arcieri;
esule in terra fra gli scherni, impediscono
che cammini le sue ali di gigante.
È ben chiaro che il poeta non può accettare una situazione sociale i cui valori sono l’interesse, l’utile, la produttività, contrapposti alla bellezza dell’arte agli ideali, allo spirito che non possono essere ridotti a una merce, perciò egli appare diverso, inadatto alla vita e alla morale comune, e, quasi come un esule, vive in una condizione di marginalità, privato del suo prestigio e della sua autorevolezza, fino a essere considerato un essere improduttivo. Di questa declassazione si fanno interpreti anche i poeti decadenti italiani D’Annunzio e Pascoli che affermano la propria individualità in due modi differenti e apparentemente antitetici, creando, il primo la figura del poeta vate con il “Superuomo” e l’altro il “Fanciullino”. D’Annunzio afferma la sua individualità divenendo nazionalista, antidemocratico, interventista, superuomo tribuno, tronfio e ampolloso oratore trascinatore di folle. Egli si piega alle leggi del mercato per garantirsi un’esistenza eccezionale e lussuosa che spettacolarizza in nome di un esasperato quanto sterile estetismo. A un certo punto, però, vuole realizzare un desiderio di tregua dagli impegni pubblici e politici, per esprimere la sua dimensione soggettiva e intima nel contatto e nella fusione nella natura con tutti i sensi, identificandosi nel tutto e giungendo al panismo e alla metamorfosi. Tutto ciò si rende concreto nella raccolta “Alcyone”. Se si prende in esame la lirica “Meriggio”, è presente, come in molte altre, “ l’indiarsi” nella natura del poeta. Sorge il dubbio, a questo punto, se l’avvicinamento alla poesia pura e al panismo sia un allontanamento dall’individualismo dell’esteta e del superuomo, in realtà è una condizione non scevra da questi elementi, perché solo il “super io” come anima eletta può cogliere e penetrare l’armonia segreta della natura e vivere un’esclusiva fusione con essa. Nella terza strofa della lirica (VV.55-81), è sancito l’inizio della metamorfosi panica: il poeta avverte la maturità dell’estate, nel caldo silenzioso, come un frutto destinatogli che deve cogliere con la sua mano per poterlo assaporare con la bocca. Ogni traccia umana si disperde, ogni affanno umano lo abbandona, non ha più nome, il suo volto diventa dorato come la luce del sole pomeridiana, la barba risplende come le alghe secche, la spiaggia rigata dal minuzioso lavoro del vento e delle onde è come il suo palato, come il palmo della sua mano in cui il tatto è più sensibile.
Bonaccia, calura,
per ovunque silenzio.
L’Estate si matura
sul mio capo come un pomo
che promesso mi sia,
che cogliere io debba
con la mia mano,
che suggere io debba
con le mie labbra solo.
Perduta è ogni traccia
dell’uomo. Voce non suona,
se ascolto. Ogni duolo
umano m’abbandona.
Non ho più nome.
E sento che il mio vólto
s’indora nell’oro
meridiano,
e che la mia bionda
barba riluce
come la paglia marina;
sento che il lido rigato
con sì delicato
lavoro dall’onda
e dal vento è come
il mio palato, è come
il cavo della mia mano
ove il tatto s’affina.
Nella quarta e ultima strofa prosegue la metamorfosi: lui non ha più nome se non “Meriggio” in cui egli vive silenzioso come la morte in una vita degna di un dio. Tutto si fonde in un’unica esistenza atemporale e distopica in cui il poeta vive un’esperienza sovrumana.
Il Pascoli, con la sua poetica del “Fanciullino”, sembra nettamente distante da una posizione come quella dannunziana e invece rappresenta un modo antitetico per esprimere la sua individualità e la propria affermazione nella società capitalistica. Egli crea un nuovo rapporto tra io e mondo che esprime tramite una conoscenza intuitiva e irrazionale della natura e dei suoi simboli che solo il poeta può interpretare. E’ chiara l’aderenza pascoliana ai poeti simbolisti europei in posizione antipositivistica nel processo conoscitivo irrazionale. Il poeta-fanciullo riesce a vedere con stupore e fantasia la realtà in modo alogico penetrando nel mistero delle cose e nelle loro “corrispondenze” (come scrive Baudelaire nell’omonima lirica). Pertanto si rifugia in un mondo intimo ed esclusivo, il metaforico nido, che lo possa proteggere dalla malvagità e dalle ingiustizie del mondo. La natura pascoliana pertanto, è solo apparentemente descritta in modo oggettivo, in realtà esprime la crisi dell’io e dà voce ai fantasmi interiori del poeta e ai suoi lutti familiari. Un esempio in proposito può essere la lirica tratta dai “Canti di Castelvecchio”, “L’ora di Barga”. Pascoli, a Castelvecchio, immerso nella pace dei campi, assapora la sua quiete nel suo cantuccio, dove, in preda ad una certa voluptas dolendi, si abbandona ai suoi rimpianti, ai suoi sentimenti più intimi. Il cantuccio è il modo che il poeta usa per parlare di sé, appunto, e si rivela come negazione del mondo esterno, costituisce una di quelle barriere protettive, ricorrenti in tante sue liriche, che utilizza per creare un discrimine tra l’io e il resto del mondo. Dal paese di Barga, posto sul colle, a poca distanza da Castelvecchio, risuonano i rintocchi delle campane che scandiscono le ore con cui egli sembra quasi iniziare un dialogo surreale: la voce blanda dal cielo delle campane lo richiama alla realtà ma lui in un impeto di vita vuole restare immoto a udire il fruscio delle reste del grano, i canti degli uccelli, osservare, con gli occhi dell’anima, la natura circostante, quelle cose che possono avere un’ora di vita o un anno o possono essere vecchie di secoli e che comunque sono destinate a passare come le nubi che vanno e vengono. (vv.1-12)
Al mio cantuccio, donde non sento
se non le reste brusir del grano,
il suon dell’ore viene col vento
dal non veduto borgo montano:
suono che uguale, che blando cade,
come una voce che persuade.
Tu dici, È l’ora, tu dici, È tardi,
voce che cadi blanda dal cielo.
Ma un poco ancora lascia che guardi
l’albero, il ragno, l’ape, lo stelo,
cose ch’han molti secoli o un anno
o un’ora, e quelle nubi che vanno.
Nella lirica “Nebbia”, (da Myricae), utilizza l’immagine della nebbia, impalpabile e fitta coltre difensiva, si allontana da un significato impressionistico di elemento atmosferico e le conferisce un valore simbolico. Essa deve isolare il poeta e proteggerlo come un nido, deve nascondere tutto ciò che è ebbro di pianto, ma non ciò che può dare gioia alla cupa esistenza del poeta, le cose che pretendono che il poeta le ami ancora e che lo chiamano: come un bambino, sente la necessità di rinchiudersi nel nido per sfuggire ai pericoli della vita. (vv. 1-14)
Nascondi le cose lontane,
tu nebbia impalpabile e scialba,
tu fumo che ancora rampolli,
su l’alba,
da’ lampi notturni e da’ crolli,
d’aeree frane!
Nascondi le cose lontane,
nascondimi quello ch’è morto!
Ch’io veda soltanto la siepe
dell’orto,
la mura ch’ha piene le crepe
di valerïane.
Nascondi le cose lontane:
le cose son ebbre di pianto!
D’Annunzio e Pascoli dunque esprimono in modo diverso il proprio individualismo con lo scopo di affermarlo di fronte alla modernità. La stessa problematica sempre in ambito decadente, dopo poco tempo, è affrontata da Pirandello. Egli approda a una crisi dell’io che diviene sempre più inconsistente fino ad annullarsi completamente. Nel saggio “L’umorismo” del 1908, egli considera la vita come un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare e di fissare in forme stabili cioè delle immagini fittizie dettate dalle convenzioni sociali. Pertanto il soggetto vive cristallizzato in un’identità che è una “maschera”, costretto a rinunciare alle sue pulsioni e a immergersi nel flusso della vita autentica perché soffocato dagli obblighi e dai vincoli sociali. Per questo motivo nei personaggi pirandelliani emergono come unica via d’uscita follia, atteggiamenti visionari o fatti apparentemente insignificanti che fanno acquistare la consapevolezza dell’inconsistenza del proprio io. I personaggi iniziano a osservare la loro esistenza da fuori in modo critico, divenendo “forestieri della vita”, cioè coloro che ne hanno capito la logica perversa e vogliono sottrarsi al suo circuito alienante. Mentre alcuni personaggi, pur scissi nella loro identità, la accettano e comprendono che il loro io non si può sottrarre alle convenzioni, il protagonista del romanzo “Uno, nessuno, centomila” non è più disposto a tornare nella sua forma e decide di alienarsi completamente da se stesso in una sorta di vitalismo panico che lo immerge in un flusso inarrestabile. Ed ecco le parole di Vitangelo Moscarda dopo che rinuncia totalmente a ogni forma d’identità:
“Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace non ne parli piú. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. […] muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non piú in me, ma in ogni cosa fuori.”
L’arte umoristica di Pirandello scompone il reale riesce a svelare l’assurdità dell’esistenza, il vuoto, ne coglie il carattere multiforme. Al soggetto non resta che la riflessione amara dei paradossi della vita di cui coglie gli aspetti ridicoli ma anche la profonda sofferenza. Un analogo atteggiamento nei confronti della realtà si può riscontrare in una lirica di Montale tratta da “Ossi di seppia”in cui emergono i temi dello sdoppiamento e dell’estraneità esistenziale. Il poeta immagina che nell’atto di voltarsi, in un mattino freddo e limpido, si compia un miracolo contrario alle sue aspettative: la rivelazione del nulla, dell’illusorietà e dell’inconsistenza della realtà che generano un senso di vuoto e di vertigine simili a quelle che prova un ubriaco. E anche quando lo sguardo si posa su elementi consueti del quotidiano, essi appaiono solo come apparenze. L’esperienza dell’io però non può essere comunicata agli altri uomini che invece si fanno ingannare dai sensi, perciò non resta che al poeta tenersi il proprio segreto.
Forse un mattino andando in un’aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.
Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto
alberi case colli per l’inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
Anche in Camillo Sbarbaro, con cui Montale ha molti aspetti comuni, sono pregnanti i temi della scissione dell’io, dell’individuo ridotto a oggetto, che si guarda vivere dall’esterno, il suo estraniamento dalla realtà, l’incapacità esistenziale di aderire al mondo. Si possono addurre come esempi le liriche “Taci, anima stanca di godere” VV.15-26, oppure “Taci anima mia” VV.1-10, entrambe tratte dalla raccolta “Pianissimo”.
Invece camminiamo.
camminiamo io e te come sonnambuli.
E gli alberi son alberi, le case
sono case, le donne
che passano son donne, e tutto è quello
che è, soltanto quel che è.
La vicenda di gioia e di dolore
non ci tocca. Perduta ha la sua voce
la sirena del mondo, e il mondo è un grande
deserto.
Nel deserto
io guardo con asciutti occhi me stesso.
Il camminare come un sonnambulo riduce l’uomo a un essere incosciente che ripete gesti consueti in un mondo arido e privo di vita di cui l’io prende atto e non si abbandona a cedimenti perché deve comunque affrontare i doveri della vita
Taci anima mia. Son questi i tristi giorni in cui senza volontà si vive,
i giorni dell’attesa disperata.
Come l’albero ignudo a mezzo inverno
che s’attriste nella deserta corte
io non credo di mettere più foglie
e dubito d’averle messe mai.
Andando per la strada così solo
tra la gente che m’urta e non mi vede
mi pare d’esser da me stesso assente.
Emerge anche in questi versi l’alienazione come sentimento di estraneità da tutto, l’io ridotto a cosa e il mondo ridotto a deserto. L’io mostra la sua rassegnazione di fronte a tale condizione.
L’io che subisce un processo di cosiddetta “reificazione” è presente anche in Ungaretti, che nella raccolta “L’allegria”, si pone di fronte alla realtà della guerra in modo critico: egli ricerca la sua identità più profonda e indaga sulla condizione umana. Il suo io ricerca l’innocenza perduta, l’atrocità della guerra lo spinge a esaminare la fragilità di creatura che cerca riparo in un legame profondo col cosmo e il tutto. Se si prende in esame la lirica, “Sono una creatura”, vi è l’identità tra pietra e poeta che poi diviene similitudine dell’interiorizzazione del paesaggio carsico, brullo, desolato in cui l’io si reifica per esprimere il suo dolore e la sua impotenza di fronte alla tragedia bellica.
Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
La morte
si sconta
vivendo
Allo stesso modo nella lirica “I fiumi”, che rappresenta il percorso del proprio io dalla sua nascita, egli mentalmente rivisita i fiumi della sua vita alla ricerca della propria identità. Vi ritrova la figura simbolica del grembo materno e della vita attraverso l’acqua e il sole. Anche in questa lirica è presente la reificazione dell’io nei vv13/15 “L’Isonzo scorrendo/mi levigava/come un suo sasso”, in cui egli si riduce a un oggetto inanimato, ma poi più avanti ai VV.30-31 si riconosce “una docile fibra/dell’universo” aprendo così il suo animo a una comunione con il cosmo. Attraverso gli elementi del sasso, dell’acqua e del sole ritrova così la sua primordiale innocenza che lo sottrae alla violenza della guerra. Gli autori citati sono solo alcuni esempi dei contrasti tra io e modernità, o più in generale, con la realtà circostante. Erroneamente potrebbero indurci a pensare che nel mondo classico non esistessero tali conflitti, secondo l’immagine molto idealizzata affermatasi nei secoli, di una cultura solida e coerente improntata alla compostezza e all’armonia e depositaria di solide certezze. In realtà, è ben noto che, come nel mondo moderno, il panorama letterario classico ci presenti personaggi scissi e problematici, che hanno gettato ombre sulla sua presunta perfezione. Solo la figura dell’Ulisse omerico mostra una compattezza inusitata. Nonostante gli elementi della devianza e della pluralità cui lo spingono la sua sete di esperienze e conoscenze nel suo periglioso viaggio, non perde la sua identità, solo Itaca è la sua isola, solo sua moglie è l’unica donna, solo lui è il re; nulla e nessuno può minare le sue granitiche convinzioni. Non tutti i personaggi classici consacrati o dal mito o da opere letterarie hanno queste certezze ma sono diventati simbolo dell’impossibilità e del danno derivanti dal conoscere se stessi e di affermare la propria individualità. Si potrebbe addurre l’esempio di Edipo, condotto alla rovina per aver voluto scoprire troppo tramite l’indovino Tiresia: mentre vive il culmine della sua potenza reale, scopre di essere un uomo doppio, da una parte favorito dalla sorte, dall’altra reo, inconsapevolmente, di delitti e atti turpi e nefandi. Egli comunque dimostra coraggio e intelligenza nel riportare in luce la sua vera identità in modo ostinato, non vuole nascondere l’omicidio e l’incesto compiuti, pur consapevole dell’esclusione sociale che questa presa di coscienza comporta. Altro esempio celebre è Antigone che afferma in modo potente ed esemplare la sua individualità e le sue scelte ergendosi contro il potere e le leggi in nome dei sentimenti e della pietà umana, incarnando il conflitto ethos e nomos. In diverse e lontane epoche storiche, pertanto, il conflitto tra io e società ha alimentato opere letterarie immortali e paradossalmente, l’esortazione espressa dalla scritta del frontone del tempio di Apollo, “γνῶθι σαυτόν”, non sempre si dimostra foriera di positività, neppure nel mondo classico non ancora contaminato dalla modernità e dal capitalismo.