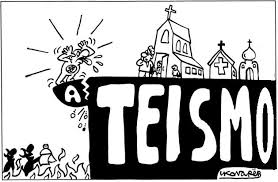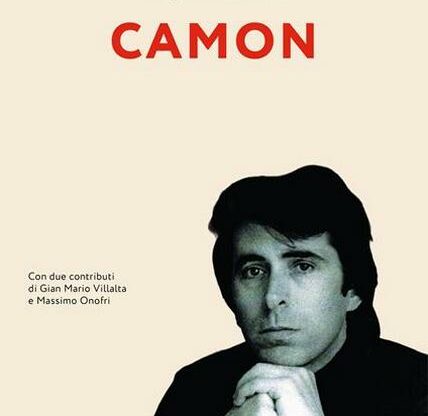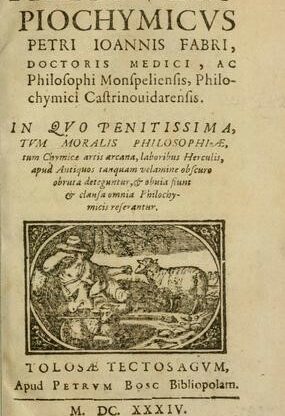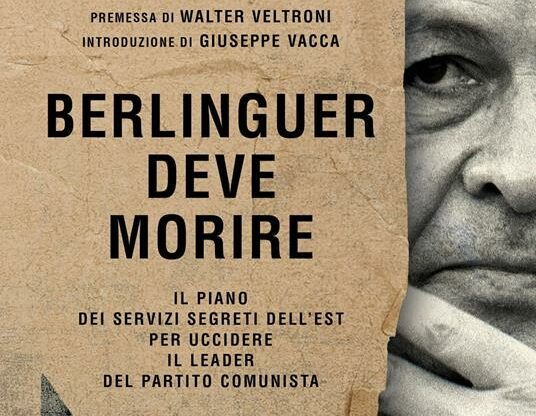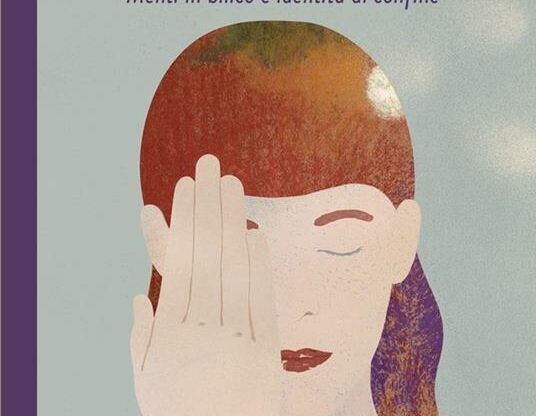La mia Napoli
Di Maria Rosaria D’Acierno
Per me il 2020 è stato un anno molto proficuo, molto più tranquillo del solito, e ho potuto pianificare i miei pomeriggi di lavoro senza molte pressioni e scadenze, per cui ho prodotto vari dipinti su tela, parecchi articoli mandati in video conferenza e due libri molto impegnativi: uno sulle tre religioni del Libro in lingua inglese e l’altro sulle fiabe e i miti. Quello sulle fiabe, che avevo già iniziato prima della pandemia, vale a dire nell’ottobre 2019, ha poi seguito un andamento un po’ diverso, facendosi influenzare dai risvolti negativi dell’ambiente naturale, condizionato anche dal COVID 19. Forse non potendo più uscire come prima, ho sentito il bisogno di ripercorrere almeno con la memoria tutti quei vicoli e quelle scalinate che dal Vomero mi portavano alle varie sedi dell’Orientale (ieri sale cinematografiche, oggi 4 Palazzi storici: Giusso, Corigliano, Santa Maria Porta Coeli, Palazzo del Mediterraneo) sia quando ero studentessa di Lingue e Letterature Straniere, sia in seguito quando sono diventata Ricercatrice. E dipingendo questa immensa tela di 3.20 x 2.70 ho ripercorso non solo tutta la città ma anche tutta la mia vita. Le scale, a volte strette altre volte larghe, si intrecciano ai vicoli in sentieri tortuosi e infidi, e ti fanno scendere con il fiato sospeso quando per la pioggia diventano scivolose, e non ti danno nemmeno il tempo di ammirare quegli squarci di cielo e mare, o quelle cupole gigantesche delle chiese che si susseguono numerose. Si, quelle cupole che sembrano sproporzionate in confronto ai palazzi neri e malandati che si intrecciano tra di loro; quelle cupole maestose di cui di tanto in tanto solo degli spicchi fanno capolino tra i palazzi alti dei vicoli dietro Piazza Mazzini.
Quei vicoli che ti portano giù ai musei erano l’unica alternativa per arrivare in tempo a lezione dopo aver sistemato i bambini, senza dover aspettare il famoso 185 che non arrivava mai. E mentre dipingevo quelle strettoie con una china nera mi ricordavo le parole del direttore del liceo artistico che aveva una regola fissa: ‘Non usate mai il nero’ diceva Brancaccio. Ma invece, per me, il nero è sempre stato il colore preferito, quello che fa risaltare ancora di più lo splendore del sole di Napoli; quel sole che pur non essendo mai velato copre Napoli con il suo velo, quel velo di cui perfino il Cristo se ne serve; quel velo che vorrebbe perlomeno adombrare i lati brutti che si alternano alle meraviglie di questa città; quel velo magicamente espresso da Ferzan Ozpetek nel suo magnifico capolavoro: Napoli velata. E forse nel mio dipinto ho ripercorso il film di Ozpetek che parte da San Martino e spacca tutta la città (Spaccanapoli) fino a Piazza Carlo III? E mi sono rivista bambina con l’unico desiderio della pittura e della scultura, io, mio padre e mio fratello Angelo a Piazza Municipio quando mi accompagnarono a malincuore a sostenere le tre prove (acquerello, geometrico e ornato) per l’ingresso al Liceo artistico. Quel cortile nell’ex Convento di San Giovanni delle Monache in Via Costantinopoli, dove l’Accademia di Belle Arti si era trasferita dal 1864, a me ragazzina di 13 anni, appariva immenso. Il Museo Archeologico, la Galleria Principe di Napoli, il Teatro Bellini e il Conservatorio di San Pietro a Majella sono gli scenari perfetti che ti spingono ad ogni tipo di arte, quell’arte che si insinua nell’animo di ogni napoletano, il quale diventa inevitabilmente e naturalmente un artista. E quelle note, suonate con l’animo, che si sprigionano dalle finestre e dai cortili del Conservatorio, diffondendosi nell’aria, ti penetrano nel cervello e ti colpiscono nell’anima, anche se stai mangiando una pizza dalla famosa e antica pizzeria nell’angolo di Piazza Bellini. E, quindi, non puoi fare a meno della musica, quelle note forti sprigionatesi da un pianoforte che non lo vedi, ma te lo immagini per forza a coda, o il flebile canto di un violino che, invece, ti sfiora il volto, la pelle e ti entra nelle vene, fino a spingerti a cercare con testardaggine Carlo Dumont, maestro di violino, che con estrema pazienza ha cercato di farmi suonare. E tutta San Sebastiano è, fortunatamente, ancora sede di negozi di strumenti musicali, che non hanno ceduto i loro locali a friggitorie o pizzerie varie.
Al contrario, il vicolo che va da Piazza Miraglia a Piazza San Domenico Maggiore (Vico San D. Maggiore), che prima ospitava, nei sottoscala dei palazzi, artigiani che lavoravano il legno per farne bare, un legno dall’odore forte e nauseante, che ancora si infila nelle narici quando passo di là, e che inevitabilmente rimandava al morto, ha cambiato i suoi ospiti; ora in quei luoghi tenebrosi e scuri, si trovano negozietti di vestiti oppure friggitorie o piccole pizzerie. Non si sente più l’odore del morto ma quello di fritture che ogni volta ti sollecitano il palato, finché non soccombi, e alla fine ti tuffi in un famoso ‘cuopph’ e ti delizi il palato a scapito della silhouette. Allo stesso modo tutta via San Biagio dei Librai e Via Mezzocannone sono diventate centri di movida, e le librerie sono state anch’esse sostituite da friggitorie.
Che malinconia non potersi più affidare a Guida che nel suo labirinto di libri riusciva a trovarti, quasi senza cercare, anche i libri più assurdi, antichi e in disuso. Quando un libro ti sembra introvabile, ‘vai da Guida’ ci dicevamo tra colleghi. A Port’Alba, la famosa “strada delle bancarelle dei libri,” anche lì si trovavano libri dimenticati, ma ora la maggior parte delle bancarelle sono scomparse. Mi consolo pensando che ancora oggi posso salutare o affidare i miei violini all’amico liutaio il cui laboratorio, pieno di strumenti musicali, nonché abitato da un immenso gatto, si trova nel Palazzo di Sangro, dopo palazzo Corigliano sede del Dipartimento di Studi Islamici dell’Orientale.
Le università sono cresciute, gli studenti aumentati, ma le librerie scarseggiano e i punti di ritrovo sono solo per ‘abbuffarsi.’ Al famoso Palazzo Giusso, sede storica dell’Orientale, con di fronte un giardino chiuso da una recinzione circolare in ferro battuto molto rara e prestigiosa, selvaggiamente eliminata per far posto a panchine in pietra dove gli studenti si riuniscono con hamburger e pizzette, sono stati aggiunti altri palazzi per accogliere tutti gli studenti delle varie facoltà, facoltà che oggi si chiamano dipartimenti. E il suo quarto piano con l’aula centrale dedicata al Professore Nando Ferrara e con una targa in ricordo della collega Maresa Sanniti sono rimaste sole perché il dipartimento di Inglese è stato trasferito in Via Duomo. Che nostalgia quelle lezioni di Nando Ferrara, il suo Shakespeare illuminava il volto non solo di noi studenti ma anche delle giovanissime docenti che lo andavano ad ascoltare, tutte sedute anche a terra in prima fila.

Grandi stimoli e grandi competizioni, lì all’Orientale. Così decisi di rimanerci anche dopo la laurea, e non mi sembrava vero quando cominciai, ancora da studentessa dell’ultimo anno, scelta, dal nostro idolo di sempre, il professore Ferrara, per delle lezioni sperimentali di inglese audio che si facevano nel vicolo al lato dell’Orientale nell’antico Palazzo Riario Sforza, che ora è diventato un albergo molto ricercato. Poi una volta laureata, fu installato un vero e proprio laboratorio linguistico nella sede del Don Orione (tra Via dei Carrozzieri e Vico Portapiccola Donnalbina) ad opera dei colleghi Ambretta Lai e Bruno Filippone, i quali fino alla fine dei loro giorni hanno dedicato all’inglese vivo, parlato, tutte le loro energie. E Lidia Curti soleva chiamarmi come sua assistente agli esami di inglese, dove dall’altro lato esaminavo delle mie ex colleghe studentesse. Ah, quelle serate in cui una giovanissima Lidia Curti ci portava in una traversa di Piazza Amedeo ad assistere agli spettacoli di avanguardia del Living Theatre, sui quali poi teneva dei seminari indimenticabili, che mi stimolarono a chiederle di fare da relatrice della mia tesi su Yeats; tesi che oggi si trova al Trinity College di Dublino, discussa insieme ad altre studentesse, quasi in sordina, dove le uniche persone che trovavamo alla fine della seduta di laurea erano Ali, che ogni tanto ci vendeva dei parei in seta del suo paese africano, e Teresa, che aveva la nostra età, ma la responsabilità di un lavoro e non la spensieratezza della gioventù.
Insomma, un cordone ombelicale, quello con l’Orientale che mi ha sempre trascinato, che non si è mai spezzato tra tutti i vicoli e le strade del centro storico, tenuto fermo e saldo dalla passione per la ricerca, arricchita soprattutto dalla scoperta di nuove lingue e, quindi, di nuovi mondi. Quei mondi che sono stati avvolti dalla ricerca antropologica attraverso gli incontri con Sergio Piro, il quale, una volta chiuso l’Ospedale psichiatrico Frullone, ci riuniva o nel Palazzo Di Sangro di Casacalenda a Piazza San Domenico Maggiore, o a Via dei Tribunali nell’antico Palazzo di Filippo d’Angiò. Quel cordone ombelicale era diventato anch’esso antico, immerso in tanta bellezza. Ecco perché non ho mai avuto il coraggio né il desiderio di volerlo o farlo recidere. La risposta veniva da tutti quegli stimoli culturali alimentati dalle sofferenze patite insieme ai cari colleghi, poi divenuti amici carissimi, e mi riferisco a Rosario Berardi e, soprattutto, a Lucia Guadagno, sofferenze, dicevo, sopportate proprio in virtù della ricerca che, comunque, ti fa soffrire. Sofferenze per essere persino negate/i nella presenza. Legame e interessi che mi hanno spinto anche alla filosofia con una tesi sui risvolti psicologici dell’emigrante con il professore Antonello Armando (Palazzo dei mutilati – Piazza Matteotti) e portato ultimamente ad aprirmi ad un mondo tanto interessante quanto per me fino ad allora sconosciuto; un mondo che mi ha fatto conseguire non solo la Laurea in Lingue e Letterature dei Paesi Islamici (Palazzo Corigliano con una tesi curata dalla prof.ssa C. Baffioni), ma soprattutto continua a spingermi verso la ricerca in quel settore.
Napoli tutta con le mie sensazioni, le mie paure, i miei ricordi, la mia vita, le mie speranze di mamma ed i progetti ambiziosi per i miei figlioletti, i quali crescendo si nutrivano delle nostre idee, perché ci seguivano anche loro in tutto il mondo con lo stesso entusiasmo ed apertura verso l’altro che anima questa città; l’altro che si trova sempre vicino a noi, di fronte, di dietro, a destra a sinistra, insomma ci circonda anche, con i suoi profumi ed i suoi odori, l’altro che ci fa comprendere che il mondo è tanto immenso quanto piccolo. L’altro, che, in questa città è accolto con amore, e non ci fa paura solo perché è diverso, anzi ci attira perché è fonte di cultura che ci ampia la mente; quell’altro che, insomma, diventa subito e facilmente nostro amico. E poi, quei pullman turistici che quasi volavano dai Campi Flegrei al Porto, a Pompei, e tutti quegli stranieri che sembravano avere un solo volto, animavano la città confondendo le loro lingue alle varie cadenze di Napoli: quello di Fuorigrotta, dei quartieri spagnoli, della Sanità, del Pallonetto, del centro storico, fino a quella cadenza particolare dei quartieri ‘alti’ e di quelli collinari, e tra un vociare amico e, al tempo stesso sconosciuto, quei pullman mi accompagnavano per tutta Napoli dall’NATO di Bagnoli fino all’Orientale. Quella Napoli, che è cambiata insieme a noi, ma che è rimasta sempre velata, tra i vicoli tortuosi e le scalinate che ti portano giù e ti riportano su, tra luci ed ombre, tra il bianco e il nero, tra le mille cupole cangianti nei loro mosaici, e i suoi palazzi storici, e i suoi palazzi cupi, tra la collina del Vomero e la lunghissima Via Posillipo, dove si respira un’altra aria, l’aria bene, ma oggi, anch’essa senza mandolino, quella Napoli, dicevo, si ritrova tutta nei tre metri della mia tela. Ho voluto chiudere in tre metri una città come Napoli, ma questo non è possibile, perché Napoli è una città aperta, e i suoi e i miei colori sono il simbolo della sua ampiezza senza confini.