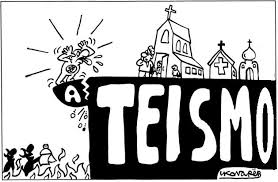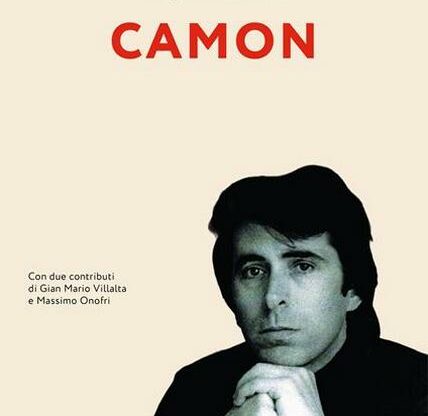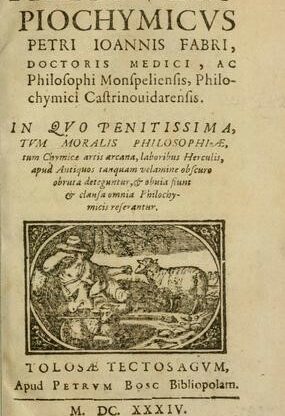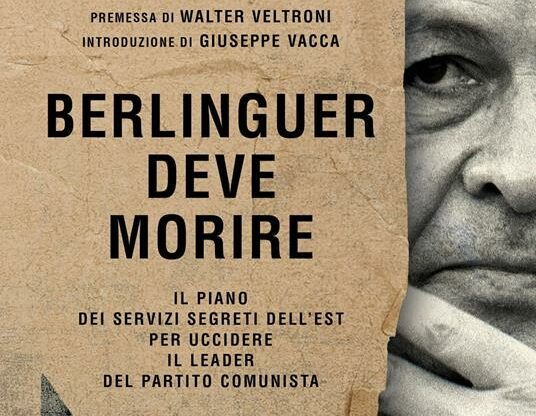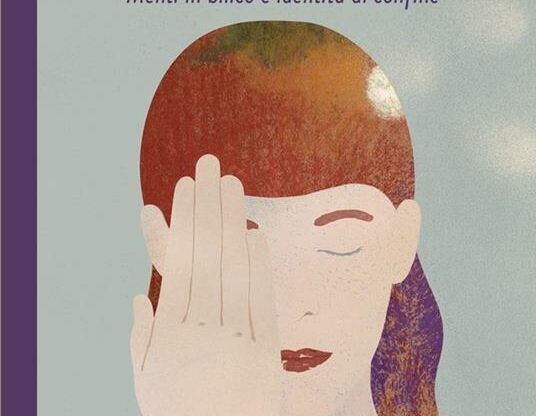Monachesimo forzato. Quanto è importante la libertà
Di Graziella Enna
«Libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta»
(Dante, Purg., I,71)
Questi versi costituiscono la cifra della vicenda esposta in questo libro e sono utilizzati dall’autrice per esprimere il suo anelito alla libertà, non come i protagonisti del canto dal peccato o da imposizioni politiche, ma quella di compiere un’autonoma scelta di vita e svincolarsi da costrizioni ingiuste. Contestualmente crea con la sua storia personale un parallelismo con l’emancipazione del popolo napoletano dal regime borbonico. Pubblicato a Firenze nel 1864, “Misteri del chiostro napoletano” non è solo dunque solo un’autobiografia ma anche un testo storico che ha un valore documentario notevole perché ci fornisce uno spaccato della realtà in un momento cruciale della storia italiana. La protagonista Enrichetta Caracciolo, (Napoli, 17 febbraio 1821 –Napoli, 17 marzo 1901) fu attivista e fervente patriota, pubblicò a Napoli un proclama in cui convinceva le donne a sostenere la causa nazionale, fondò un comitato di difesa dei diritti delle donne, fu poetessa, scrittrice e corrispondente di diverse riviste. Fu scomunicata dalla chiesa per la sua biografia tradotta comunque in molte lingue e conosciuta in tutta Europa. Non ebbe riconoscimenti ufficiali nonostante la fama che si acquistò e morì dimenticata da tutti. Discendente da un’importante famiglia napoletana, figlia di don Fabio Caracciolo e della nobildonna Teresa Cutelli. Enrichetta, a causa della decadenza economica della famiglia conseguente alla morte del padre, è costretta a prendere i voti contro la sua volontà e, giunta all’età adulta, narra attraverso una lunga analessi le sue dolorose peripezie per affrancarsi dalla monacazione coatta.
Questo è il fulcro essenziale dell’opera: Enrichetta capisce, attraverso gli anni passati richiusa nel chiostro, gli intrighi, l’asservimento, l’ipocrisia della società del tempo e matura la sua profonda avversione per un sistema politico oppressivo e inadeguato sia dal punto di vista civile che da quello religioso. Oltre al biasimo per il riprovevole e disumano costume della monacazione forzata presente in molta letteratura ottocentesca, (basti l’esempio manzoniano di Gertrude nei “Promessi Sposi”, o quello verghiano in “Storia di una capinera”), ci troviamo di fronte a un’analisi approfondita e impietosa della società napoletana che paradossalmente si mostra con chiarezza alla protagonista proprio nelle riposte e segrete mura del convento. In questa e nelle suddette opere l’aspetto che turba e sconvolge maggiormente è il travaglio spirituale delle vittime destinate al velo che devono rinunciare alla loro vita e a coltivare le loro legittime aspirazioni, in nome di un’atavica motivazione di ordine materiale cioè evitare la frammentazione del patrimonio familiare. Consapevoli che ogni forma di ribellione sarebbe stata infruttuosa e vana, sono perciò costrette a subire la violenza psicologica da parte della famiglia e poi a sottostare alle rigide e mortificanti regole del chiostro. A questo proposito si può citare un passo dello Zibaldone di Leopardi in cui egli muove una severa critica nei confronti di questa consuetudine ormai radicata che precipitava sventurati giovani di entrambi i sessi in una condizione di non esistenza .
Zibaldone (2 febbraio 1822)
“Giovanette di 15 o poco più anni che non hanno ancora incominciato a vivere, né sanno che sia vita, si chiudono in un monastero, professano un metodo, una regola di esistenza, il cui unico scopo diretto e immediato si è d’impedire la vita. E questo è ciò che si procaccia con tutti i mezzi. Clausura strettissima, fenestre disposte in modo che non se ne possa vedere persona, a costo della perdita dell’aria e della luce, che sono le sostanze più vitali all’uomo, e che servono anche, e sono necessarie alla comodità giornaliera delle sue azioni, e di cui gode liberamente tutta la natura, tutti gli animali, le piante, e i sassi. Macerazioni, perdite di sonno, digiuni, silenzio: tutte cose che unite insieme nocciono alla salute, cioè al ben essere, cioè alla perfezione dell’esistenza, cioè sono contrarie alla vita. Oltreché escludendo assolutamente l’attività, escludono la vita, poiché il moto e l’attività è ciò che distingue il vivo dal morto: e la vita consiste nell’azione; laddove lo scopo diretto della vita monastica anacoretica ec. è l’inazione, e il guardarsi dal fare, l’impedirsi di fare. Così che la monaca o il monaco quando fanno professione,dicono espressamente questo: io non ho ancora vissuto, l’infelicità non mi ha stancato né scoraggito della vita; la natura mi chiama a vivere, come fa a tutti gli esseri creati o possibili: né solo la natura mia, ma la natura generale delle cose, l’assoluta idea e forma dell’esistenza”.
Anche il recanatese si dimostra un acuto osservatore della società del tempo e ne coglie contraddizioni e anomalie in maniera estremamente lucida e precisa, indizio palese di un problema sentito e dibattuto anche da importanti intellettuali. Enrichetta Caracciolo, al contrario della Gertrude manzoniana e della Maria verghiana, che, conoscono il loro destino, sebbene non lo accettino, si ritrova in convento ex abrupto, dopo la morte del padre quando la famiglia subisce un tracollo finanziario. La madre, astuta e calcolatrice, pur di potersi risposare per ritrovare la sua condizione di agiatezza, non bada ai sentimenti della figlia, che coltivava un amore sincero nei confronti di un giovane, ma fa di tutto per ostacolarla organizzando la monacazione a sua insaputa. Trovando la complicità di anziane monache appartenenti alla famiglia, sorelle del defunto marito, congiura per togliere la giovine alla vita del secolo. Ecco le parole della madre con cui Enrichetta viene messa di fronte al fatto compiuto:
«Le tue zie» soggiunse, «sono ricche; consegnandoti a loro infino a tanto ch’io cominci a percepire le mie pensioni, sarò sgravata di un peso. Sono sicura d’altronde che la pace del Convento servirà di molto a calmare il tuo cuore, turbato da una folle passione… Ma, dopo due mesi, le amorevolezze delle monache non avranno espulso dal cuore tuo l’aborrimento pel chiostro, prometto di riprenderti meco. Per ora ritrattarmi non posso, fatto già essendo a tuo favore il Capitolo per l’ammissione […] Tuo padre non ha lasciato per te né dote né tutore: l’arbitra della tua sorte sono io sola… le leggi divine ed umane t’impongono l’ubbidienza, e, affé di Dio, tu ubbidirai».
Enrichetta si trova dunque in un breve lasso di tempo chiusa tra le mura del convento di San Gregorio Armeno. Indicibili la sua disperazione e il suo tormento. Giovane colta, amante della letteratura e della musica, è proiettata all’improvviso in un microcosmo dominato da leggi spietate, vizi, depravazioni di ogni sorta. Poco spazio resta all’autentica fede religiosa e alla pace interiore, unici valori auspicabili in quel domicilio coatto, che al contrario, ricalca alla perfezione i costumi di vita più abietti del secolo col solo discrimine della reclusione. La ragazza dal canto suo, pur essendo religiosa e timorata di Dio, dimostra sempre con sincerità la sua avversione per la vita monacale, palesandola apertamente alla badessa, ma non viene mai ascoltata e neppure la madre mantiene la promessa di riportarla a casa dopo due mesi. Fin dal suo ingresso nel convento Enrichetta si rende conto della mancanza assoluta di spessore culturale delle monache che, sebbene appartengano alle famiglie più blasonate, non hanno nulla nel loro modo di essere e nella loro istruzione che possa ricondurre al loro alto lignaggio. Riconosce la violenza che hanno subito da parte dei congiunti snaturati che le hanno cresciute privandole fin dall’infanzia non solo di ogni stimolo esterno ma soffocando anche in loro sentimenti e fisicità, immergendole nella solitudine e nelle rinunce per sottrarle ingiustamente al mondo. Senza contare che la loro istruzione non prevedeva nient’altro che non fosse fatto di leggende, storie di ascetismo attinte da dozzinali agiografie, miracoli e visioni mistiche. Sostiene inoltre che all’interno di molti conventi napoletani di clausura vigessero ancora norme e costumi risalenti a molti secoli prima, conservatisi inalterati così come i simulacri umani mummificati a Pompei dalla lava del Vesuvio. Compie una precisa disamina storica proposta in interessanti pagine relativa soprattutto al numero esorbitante dei monasteri e della loro popolazione in Italia rapportato al numero degli abitanti. L’Italia tra il XVIII e il XVIX secolo possedeva il doppio dei conventi di uno stato come la Francia più vasto e più densamente popolato senza contare che l’enorme ammontare dei beni del clero era superiore a quello degli stati più ricchi. Per tirare un po’ le somme in Italia una persona su quarantasei apparteneva a un ordine ecclesiastico. Dopo queste pertinenti e circostanziate annotazioni, Enrichetta introduce il lettore all’interno della vita quotidiana del convento e in primis opera una distinzione tra conventi maschili e femminili che si differenziavano per un particolare connotato, ovvero la pratica della confessione. Nella sua ingenuità non si capacita del fatto che le monache debbano confessarsi giornalmente sedute in piccole cabine ben protette e riservate da occhi e orecchi indiscreti. Le risulta incomprensibile la bramosia delle monache di dedicare intere ore alla pratica e scegliere il prete confessore. Costui si rivela non certo un padre spirituale puro e disinteressato ma diviene il depositario di tutti i più intimi segreti delle suore, l’intermediario tra il chiostro e il mondo, la valvola di sfogo di passioni represse, di desideri inespressi oltre a inculcare nelle giovani una forma morbosa di amore mistificato sotto la candida apparenza dell’amore paterno o materno. In realtà la ricerca del confessore ideale scatenava nel convento odi, gelosie, rancori, ognuna cercava di conquistare il prete più avvenente e disposto dispensare moine e lusinghe che nulla avevano di sacro. Addirittura alcune monache simulavano patimenti per ricevere il confessore nella loro cella. La protagonista, pur non avendo intenzione di pronunciare i voti, si comporta in modo irreprensibile e non si lascia irretire dalle turpi attenzioni di vari confessori. Dimostrandosi sincera nella sua autentica fede religiosa, prega Dio di essere liberata da quel luogo di ipocriti soprattutto quando uno dei suoi blasfemi confessori le fa credere, con ridicoli sofismi e una spiazzante dialettica, che l’amore donato a lui non sarebbe stato peccaminoso ma la materializzazione e santificazione dell’amore per Cristo. Risoluta a uscire dal convento, tenta un contatto con la famiglia ma una serie di congiunture sfavorevoli la costringono al ritorno nell’abbandonato cenobio e alla richiesta dei voti definitivi.
“La chioma cadde, e presi il velo”.
Dopo la prima professione tenta di adattarsi alla vita claustrale chiudendo il suo spirito “in un monastero dentro il monastero”, pregando con cuore sincero che le sue sofferenze siano in qualche modo alleviate, dedicandosi alla lettura e impegnandosi in varie attività che la sottraggano dal pensiero dominante di quel carcere per lei orrendo. I rapporti con le altre monache spesso sono tesi, soprattutto quando si scopre che la sua dote è esigua viene fatta traslocare con cattiveria dalla sua cella ritenuta migliore di quelle occupate da monache con una dote più cospicua. Giunge la professione definitiva quando deve pronunciare i quattro voti, castità, povertà, ubbidienza e perpetua clausura. E’ in quel frangente, che, terminata la solenne cerimonia, nell’udire i cancelli stridere sui loro cardini, prende coscienza che deve abdicare persino alla sua personalità oltre a tagliare definitivamente i ponti con famiglia, amici, affetti e beni terreni di ogni sorta. La narrazione si fa sempre più e ricca di aneddoti, storie di altri personaggi, occorrenze quotidiane, oppure di esempi riferiti ad altri contesti similari, tuttavia non annoia, non distrae il lettore, anzi lo induce a una più attenta disamina degli aspetti psicologici e dei meccanismi sociali che ne sono alla base. Il registro linguistico e lo stile adottati sono in linea con la letteratura colta ottocentesca, ma non risultano affatto complessi per il lettore. Le citazioni letterarie e storiche rendono l’opera ancora più interessante e godibile e sono il segnale di una donna che ha curato la sua formazione culturale come strumento di emancipazione in seno a una società antiquata, retrograda e codina. Solo due ruoli erano annoverati per una donna, o matrimoni di convenienza in età giovanissima con uomini molto più adulti e talvolta parenti stretti, oppure la chiusura definitiva in un chiostro che sanciva la scomparsa definitiva di un essere umano indesiderato e ritenuto inutile. L’opera dimostra anche l’atipicità di una donna combattiva che non è disposta a soffocare la sua libertà e che possiede chiara la consapevolezza della situazione politica e economica in cui versa il meridione nelle mani dei Borboni. Non ritorce il suo velenoso astio sugli altri, come la più celebre monaca manzoniana o la sua disperata lotta su se stessa, come la Maria verghiana, ma combatte con determinazione e accanimento pur di non cedere a un destino che non le appartiene. Gli aspetti che Enrichetta mette in luce nella sua realistica e spietata descrizione dei costumi del chiostro sono la mancata realizzazione nella quotidianità dei suddetti sacri voti. La povertà infatti è solo esteriore, in realtà le monache sotto il ruvido abito indossavano biancheria di finissima tela di batista adornata con delicati pizzi, dormivano su materassi di morbida lana, cuscini di soffici piume, esibivano sul saio rosari d’argento nelle feste comandate. Conservavano inoltre nei loro armadietti pregiate porcellane cinesi, altro vasellame prezioso, argenteria e addirittura usufruivano nel convento di un deposito per conservare il denaro. La semplicità e frugalità del vitto, come prevedeva la regola, non erano rispettate, al contrario ogni giorno erano servite quattro pietanze la mattina di cui almeno una di fine pasticceria, la sera si consumava una lauta cena, il pane era sopraffino, la frutta fresca era sempre presente, e seppur fosse proibita di venerdì, era sostituita con deliziose conserve. Ogni monastero napoletano era inoltre rinomato per la realizzazione di squisiti dolci e caratterizzato da una specialità. Le monache impiegavano giorni di lavoro e i destinatari delle leccornie non erano i parenti o gli amici, ma avidi preti che le convincevano di essere per loro gli unici familiari e la loro vita stessa oltre che emanazione dell’amore per Cristo. Con queste sacrileghe spiegazioni si accaparravano laute riserve di squisitezze. Dal canto loro le monache impegnate a impastare e infornare non si presentavano nemmeno alle orazioni e ai riti di importanti solennità religiose. L’umiltà non albergava nell’animo della maggior parte delle monache che ostentavano i titoli dei loro nobili progenitori aggredendosi verbalmente a vicenda per affermare la supremazia del loro casato di provenienza e ricercando eventuali pecche in quelli altrui da rinfacciare in animati e disdicevoli alterchi. In certi conventi vigeva la regola di baciare in ginocchio la superiora di nobile discendenza o, come si faceva col papa, la sua pantofola o erano riservate altre distinzioni e privilegi come assegnare alle più nobili i posti migliori in chiesa durante le celebrazioni. Altri aspetti messi in luce sono la mancanza di carità, l’assenza dell’umana pietà per gli infermi o per i bisognosi. Enrichetta, per questo motivo, chiede di ricevere l’incarico di curare le monache sofferenti nell’infermeria, compito che nessuna voleva svolgere. Assiste monache inferme e vede l’indifferenza con cui le sue consorelle trattino le malattie e le afflizioni oppure quanta ne dimostrino in caso di decesso.
Un lutto sincero, un rimpianto cordiale, il tributo di alcune lagrime sulla tomba di una defunta compagna, sono in convento fenomeni più rari di quello che nel mondo lo siano le commozioni suscitate dal teatro. L’apatia, che presso gli stoici era virtù, presso le monache è effetto di calcolo e d’egoismo.
L’autrice riferisce tanti episodi e dimostrazioni del cinismo e della crudeltà che albergava nei conventi e preferisce usare una preterizione per omettere tutte le forme di delitti, nefandezze e atti disumani. Come ultimo esempio riporta che nella cripta del convento dei Gesuiti, scoperto nel 1848, venne alla luce un ossario di neonati. Risulta sempre più evidente l’affermazione della protagonista che il monastero racchiudesse tutti le dissolutezze peggiori della città e della congerie sociale in generale, senza averne nessuna virtù, le monache pure e devote erano un numero veramente esiguo e trascurabile. Si può paragonare quest’affermazione al disdegno dello stesso Dante, quando nel celebre canto XI del Paradiso (vv.130-132), afferma che i religiosi (nel suo caso appartenenti all’ordine domenicano), realmente ligi alla regola erano talmente pochi che sarebbe bastato ben poco panno per far loro i mantelli. E purtroppo nei secoli, il processo di mondanizzazione già deplorato dal Poeta non era mai cessato, la bramosia di beni terreni istigava a compiere ruberie e reati di ogni sorta e a creare un clero corrotto e meschino. Nei conventi napoletani i furti erano all’ordine del giorno, monache rapaci erano ansiose di stendere i loro avidi artigli sui beni delle consorelle: biancheria, argenteria, tazze e tazzine e tutto ciò che avesse valore, era oggetto di cupidigia, persino il simulacro della Madonna a San Gregorio Armeno fu saccheggiato degli ex voto. Altri guadagni illeciti derivavano dal commercio clandestino di dolciumi e medicinali. In vent’anni di monacazione e reclusione la protagonista provò tanto disgusto nel vedere compiuti atti disonesti e riprovevoli troppo difficili da enumerare per la loro meschinità e gravità, perciò preferisce non approfondire l’argomento. Paradossalmente proprio lei che disdegnava e aborriva quell’abito impostole con la forza, negli anni fu monaca irreprensibile, casta e benevola, ma proprio per queste qualità positive fu sempre oggetto di scherno, raggiri, calunnie e malvagità da parte delle altre monache, in un perfido gioco di straniamento dei valori. Tutto ciò la esacerbava e le provocava indicibili sofferenze interiori a cui poi si aggiungevano quelle fisiche dovute alle inclemenze climatiche all’interno delle mura nella stagione invernale, all’aria malsana e mefitica delle celle, a convulsioni seguite da febbri altissime, tanto che persino la madre, ormai divenuta consapevole dell’errore commesso, ne provò un’immensa pietà. Si fa strada in Enrichetta la volontà di secolarizzarsi e purificarsi da quel covo di depravazione e perversione, per trovare finalmente la sua pace interiore con l’unico desiderio di condurre una vita semplice e onesta dedita a coltivare lettura, studio, amore per la natura. Nulla di più. Rivolge la domanda di secolarizzazione al pontefice ma sulla sua strada incontra Riario Sforza, arcivescovo e poi cardinale di Napoli, uomo spietato e infido persecutore che diviene il suo aguzzino che la ostacola e la perseguita come la peggiore delle donne malfamate e disoneste, assumendo un comportamento da vero inquisitore e sottoponendola a umilianti carcerazioni. Il cardinale faceva visita spesso al convento, suscitando l’ammirazione delle monache che si facevano irretire dal suo aspetto e dai suoi modi mentre Enrichetta provava un sentimento ben diverso e sicuramente più oggettivo, lontana com’era dalle immorali lascivie delle consorelle.
Provava per la sua persona una di quelle ripugnanze insuperabili che si sentono a prima vista e non si sanno giustificare. Non so perché, ma sin dal primo incontro egli mi sembrò un dandino, travestito da principe ecclesiastico.
La protagonista si cura di studiare con precisione e zelo tutte le procedure giuridiche e tutto l’iter necessario ma la sua richiesta è intercettata dal perfido cardinale e a poco a poco si affievoliscono in lei le speranze di trovare intercessione nell’animo, ritenuto liberale, di Pio IX. Arriva il 1848 e con esso le rivoluzioni, Enrichetta riesce a leggere i giornali e a apprendere con gaudio che si lotta per la libertà. E’ accusata dentro il convento di essere rivoluzionaria, settaria, aggregata a società segrete ed eretica: tutto questo accresce l’esclusione e il dileggio nei suoi confronti. Una seconda richiesta scritta rivolta al pontefice cade nel vuoto sempre per opera del cardinale, in realtà non era il pontefice a opporre il veto ma solo l’alto prelato che faceva in modo che lettere e suppliche non raggiungessero la Santa Sede. Nonostante ciò, dopo infinite e lunghe peripezie, ottiene di uscire dal convento ma col vincolo di alloggiare in un altro monastero, Il Conservatorio, da cui le era concessa un’uscita mattutina. Ritrovarsi all’aria pura e nel consorzio umano genera in Enrichetta una nuova energia e fa rinascere in lei una rinnovata fede religiosa, ma purtroppo con il verso dantesco “novi tormenti e novi tormentati”, (Inf. VI, 4), ci narra le nuove persecuzioni operate dal cardinale Riario. Finisce all’Annunziata di Capua in cui dimoravano alcune religiose nelle normali celle, ma anche le cosiddette proiette, donne a vario titolo rifiutate dalla società. Immerse nello squallore e nel sudiciume, conducevano un’esistenza di abbrutimento senza un’istruzione e neppure la parvenza di qualità femminee, ma riunite in modo coatto sotto l’egida della Chiesa che credeva così di attuare una riforma morale. A questo proposito si potrebbe citare un’altra opera che mette in luce il degrado di altri conventi del territorio napoletano adibiti a orfanotrofi o alla reclusione di donne considerate reprobe, immorali, vittime di violenze sessuali o diseredate, cioè il romanzo del patriota Antonio Ranieri “Ginevra o l’orfana della Nunziata”. Anch’egli fu perseguitato dalla chiesa per aver denunciato nel suo romanzo i soprusi e i maltrattamenti perpetrati in vari monasteri. Dopo aver dimorato all’Annunziata viene arrestata e condotta nel ritiro di Mondragone incarcerata ingiustamente come una prigioniera, con tanto di censura alle missive. Trascorre in quel terribile luogo tre anni e quattro mesi di reclusione in cui tenta di ferirsi con un coltello e di farsi morire di fame, passa mesi cupi, di angosciante prostrazione, paragona la sua prigionia a quella sofferta da Silvio Pellico. Dopo la liberazione, avvenuta grazie a una relazione medica in cui si certificano le sue infermità dovute alle crisi convulsive frequenti, si trasferisce a Napoli, spiata in continuazione da emissari del cardinale Riario, costretta perciò a cambiare continuamente il suo domicilio e a portare ancora il velo. Nel 1860 finalmente la sua libertà tanto agognata per anni sembra realizzarsi, proprio in concomitanza con l’Unità d’Italia e la cacciata dei Borboni. E quando si ritrova nella piazza di cattedrale festante per la presenza di Garibaldi compie il gesto che la libera definitivamente da ogni vincolo, ripone il suo velo nero sull’altare della chiesa dopo vent’anni.
“Votum feci, gratiam accepi”
Da quel momento si onora finalmente di acquisire il titolo di cittadina senza nutrire nessun risentimento e disprezzo per la vita claustrale anzi si dichiara sua debitrice per averle fatto conoscere le malvagie dinamiche dell’animo umano più di ogni altra condizione sociale. Il mondo è pronto ad accoglierla e finalmente può esercitare la facoltà di scegliere il suo destino, consapevole che, anche come libera cittadina e nutrendosi di ideali diversi da quelli religiosi, può aspirare al premio della misericordia di Dio.
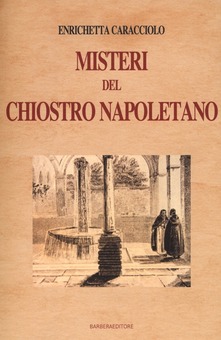 I misteri del chiostro napoletano
I misteri del chiostro napoletano
Saggistica
Barbera
2013
324 p., brossura