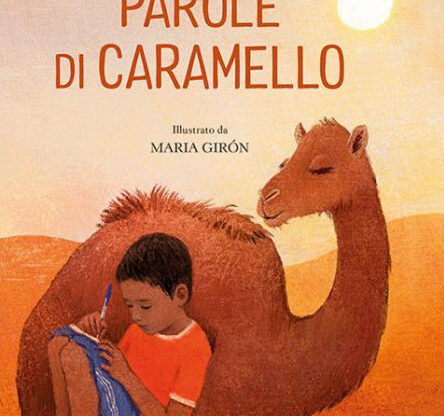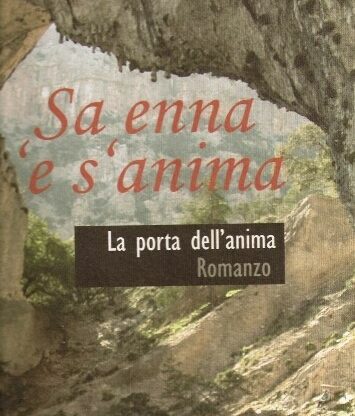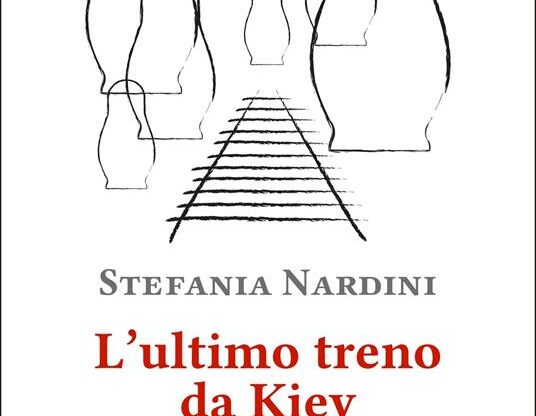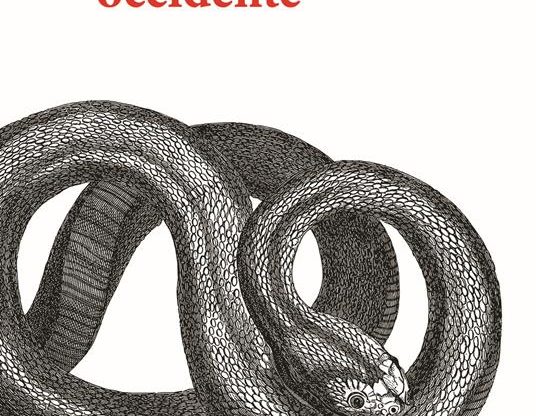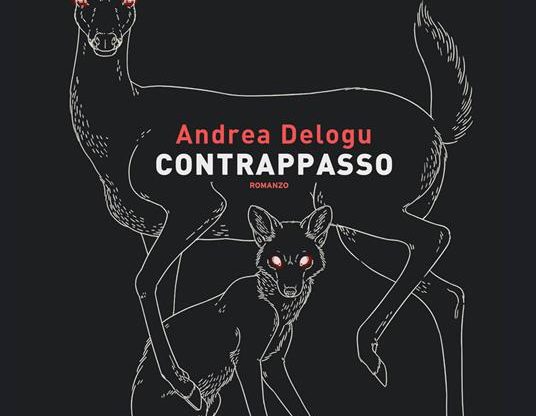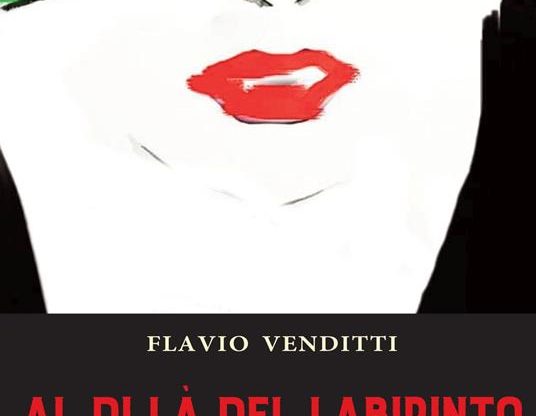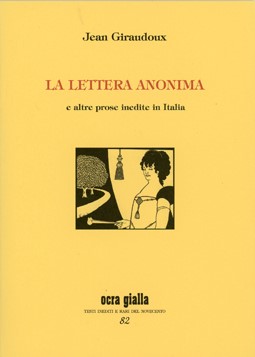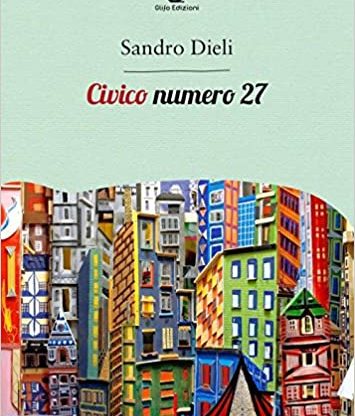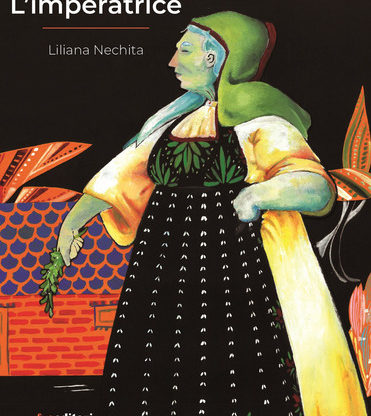L’ora di Agathe. La cognizione del dolore
Di Geraldine Meyer
L’aletta su cui è riportata la storia di questo libro parla di “tardiva educazione sentimentale”. La sempre attenta Iperborea questa volta cede a una formula forse troppo facile. Credo che L’ora di Agathe, della danese Anna Cathrine Bomann, scrittrice e psicologa, sia più una sorta di cognizione del dolore. Perché è nel riconoscimento del dolore, il proprio e degli altri, che avviene l’incontro.
In una cittadina francese, negli anni ’40 del secolo scorso, un anziano psicoanalista conta in modo ossessivo le ore e i pazienti che lo separano dalla pensione. Stanco, forse annoiato, aspetta il momento in cui chiuderà, per l’ultima volta, la porta alle spalle dell’ultimo paziente. Non ha amici, non ha una famiglia. La sua vita, da anni, si snoda tra casa e studio. Protetto da sé stesso e dagli altri fa il suo mestiere. Forse è proprio questa sorta di patina che gli consente di ascoltare le storie sfibrate, difficili, complesse, di chi si rivolge a lui per trovare un senso, il bandolo di quella matassa incomprensibile, che si complica, che si aggroviglia. Ma come può ascoltare davvero un uomo che appare difendersi dalla vita stessa?
Le cose cambiano quando una giovane paziente si rivolge a lui, quasi oltre tempo massimo. Nei progetti dell’anziano psicoanalista non dovrebbe esserci più spazio per nessun nuovo paziente. Ma la sua segretaria provoca la prima crepa, quel piano inclinato degli eventi che si mette in moto senza la nostra volontà. La giovane donna cercherà di sbrogliare il dolore che la tiene in scacco da tutta una vita. E così facendo “costringerà” lo stesso psicoanalista ad affrontare quel buco nero che lo inchioda ad una vita vissuta con il freno a mano. Seduta dopo seduta, l’anziano si accorge che avvertire l’esistenza degli altri, il loro dolore, il loro disagio è il primo, fondamentale passo per avvertire le proprie debolezze, il proprio dolore. E solo così arrendersi a quella corrente, spesso tempestosa, che è l’esistenza.
La solitudine, la morte, gli abusi diventano così la trama sottile con cui è possibile stabilire un autentico ascolto, un autentico incontro. A quel punto, e solo a quel punto, si arriva a capire che le cose hanno una conclusione ma non una fine. Che il controllo è impossibile e che l’inaspettato non chiede il permesso per entrare nel recinto così sapientemente costruito nel corso degli anni.
La Bomann costruisce una storia che non pretende di essere originale, e infatti non lo è. Ma è, semmai, originaria. E lei che nella vita è psicologa, non poteva non saperlo. È una storia che “smaschera” la presunta inavvicinabilità dello psicanalista, il gioco di specchi, di transfert e controtransfert che caratterizza il percorso tra paziente e dottore. Un mettersi in gioco, o rimettersi in gioco, ciascuna volta, reciprocamente.
Una storia, questa di L’ora di Agathe, che si regge sul bisogno, così umano, di stabilire dei legami con gli altri e l’altrettanto umana paura degli stessi. Nessuno è esente dall’infelicità, a nessuno è concesso passare indenne attraverso il dolore. Però riconoscerlo, in sé e negli altri, parlarne e non avere paura di mostrarsi indifesi, è uno dei modi con cui ricominciare quando sembra di avere, invece, imboccato una strada senza uscita.
Tra Agathe e lo psicoanalista si costruisce una sorta di gioco in equilibrio tra fascino e sfida. Un rischio. Ma, del resto, una vita iperprotetta, vissuta con una sorta di metaforico preservativo, che vita è? Dietro quella che, a conclusione del libro, sembra essere una facile speranza, una facile consolazione, c’è al contrario la consapevolezza che ciascuna cosa dipende da noi e, nello stesso tempo, nessuna cosa dipende da noi. E questa contraddizione è irrisolvibile.
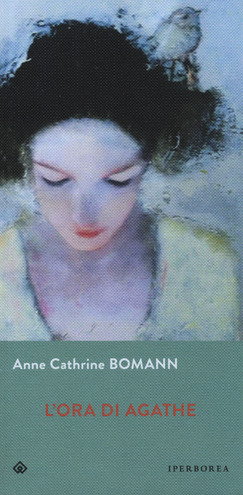 L'ora di Agathe
L'ora di Agathe
Romanzo
Iperborea
2019
153 p., brossura