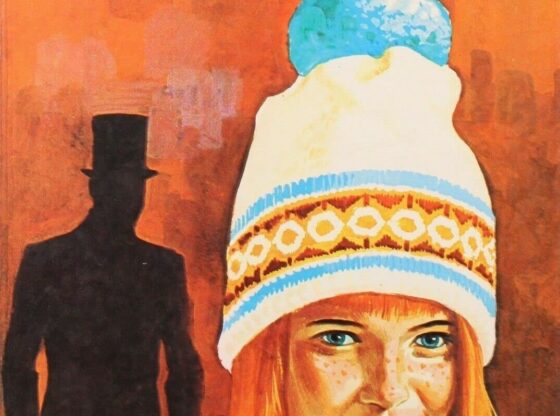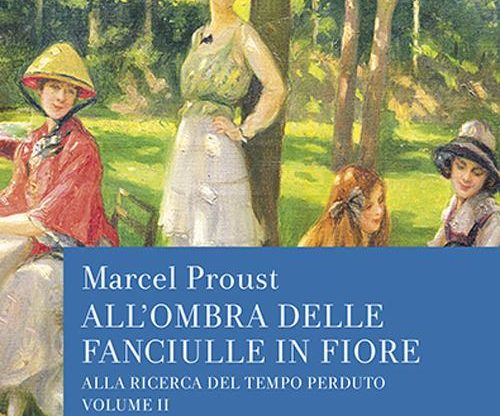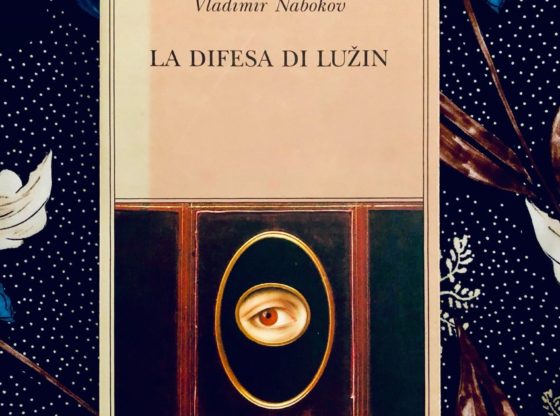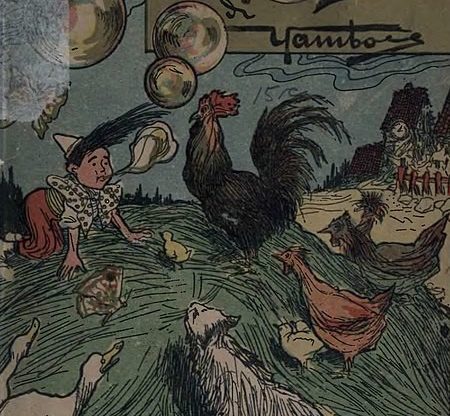Due scrittori e patrioti del Risorgimento italiano: Silvio Pellico e Antonio Ranieri
Di Graziella Enna
Due vite complesse quelle del napoletano Antonio Ranieri e del piemontese Pellico, intellettuali, scrittori poliedrici e patrioti che vissero in due situazioni differenti, ma altrettanto problematiche: uno sotto il regime borbonico, l’altro sotto il dominio austriaco. Il nome di Ranieri è ben noto quasi esclusivamente per la sua amicizia con Leopardi, ma come autore è pressoché sconosciuto, nonostante la vasta produzione. Pellico che tanta risonanza ebbe in epoca risorgimentale e nella letteratura scolastica del primo cinquantennio del Novecento, oggi è quasi caduto nell’oblio o appena menzionato tra i letterati definiti minori. In particolare mi soffermerò su due opere che costituiscono uno spaccato della realtà sociale del periodo: il romanzo “Ginevra o l’orfana della Nunziata” di Ranieri e “Le mie prigioni” di Pellico. Queste opere che furono pubblicate rispettivamente nel 1836/39 e nel 1832, furono accolte molto bene dal pubblico ed ebbero una grande risonanza. Le memorie di Pellico dopo una numerosa serie di ristampe, divennero il libro italiano più letto in Europa nella prima metà del secolo: un anno dopo la pubblicazione fu tradotto in francese e, negli anni successivi, in altre lingue europee. Il romanzo di Ranieri ebbe traversie editoriali, i primi capitoli editi nel 1936 furono sequestrati dalla censura borbonica e la pubblicazione definitiva procurò non pochi problemi all’autore. I due ebbero una vita piuttosto travagliata ma molti elementi li accomunano, primo tra tutti il sentimento patriottico ma, più di ogni cosa, la consapevolezza delle ingiustizie perpetrate dai dominatori stranieri attraverso una politica repressiva che li indusse a manifestare il loro dissenso in diversi modi. Per questo motivo Ranieri, costretto per anni ad abbandonare Napoli, perseguitato dalla polizia borbonica per la sua attività di cospirazione si recò all’estero e in molte città italiane. Pellico fu arrestato come esponente della Carboneria e incarcerato nelle prigioni più dure. Tuttavia mentre il romanzo di Ranieri nasce con l’intento di denunciare le condizioni in cui versavano carceri e orfanotrofi sotto il dominio borbonico, quello di Pellico non ha mai accenti esplicitamente accusatori nei confronti degli oppressori: egli pur nell’asperità della sua pena esprime una rassegnazione pacata. Entrambe le opere sono comunque dei documenti umani pur con i limiti evidenziati dalla critica che spesso ha riscontrato, in molta letteratura dell’Ottocento, toni patetici, lacrimevoli, tipici dei romanzi cosiddetti d’appendice, ma che a mio parere, non sono prevalenti in questi scritti. Queste stroncature categoriche e generalizzate si possono ritenere ingiuste e immotivate, anche la letteratura considerata minore, confrontata ai grandi dell’Ottocento, ha un suo valore notevole per il lettore moderno, sia dal punto di vista contenutistico che da quello linguistico. La vicenda di Ginevra, narrata da Ranieri, potrebbe apparire attualissima e paragonata a temi quanto mai attuali quali l’infanzia violata, gli abusi di ogni sorta sulle donne, il degrado sociale. Parimenti l’iniqua incarcerazione di Pellico si può equiparare alla persecuzione dei dissidenti politici dei sistemi totalitari e delle dittature del Novecento. Senza contare poi il realismo ante litteram, evidente in entrambe le opere, nelle minutissime e doviziose descrizioni di personaggi e ambienti. Nondimeno è interessante l’aspetto psicologico riguardante i tormenti interiori dei protagonisti nella consapevolezza della loro condizione e delle ingiustizie che sono costretti a subire.
Ranieri dedica il romanzo di Ginevra al suo amico e maestro Leopardi. Nella sua produzione rappresenta lo scritto più significativo che gli costò quarantacinque giorni di incarcerazione e l’ira delle istituzioni religiose e civili dello stato borbonico. A proposito delle reazioni in seno ai Gesuiti, egli nell’introduzione parla così di un prete:
Poscia, in un suo conventicolo dai Banchi Nuovi, sentenziò solennemente, ch’era bene di bruciare il libro, ma che, assai migliore e più meritorio, sarebbe stato di bruciare l’autore a dirittura.
Il romanzo si presenta come il primo esempio di denuncia sociale, tema che sarà ripreso ampiamente da Charles Dickens di cui Ranieri si può considerare un precursore ideale, perché tratta delle condizioni miserrime degli orfanotrofi quasi completamente abbandonati a se stessi, luoghi di degrado degli strati più deboli ed emarginati della società. Il libro ha un titolo che, sia per assonanza sia per struttura, sembra richiamare “La Ginestra o il fiore del deserto” del suo grande maestro. Vi è narrata la breve vita di Ginevra il cui doloroso presupposto è in prima istanza la sua esposizione. La pratica dell’abbandono dei neonati nella cosiddetta “ruota”, (meccanismo girevole collocato nelle pareti esterne dei conventi e comunicante con l’interno), consentiva alle madri, spinte spesso dalla povertà o dalle violenze di cui erano state vittima, di depositare i loro infanti e affidarli alle cure dei brefotrofi religiosi. Questa consuetudine tra Seicento e Ottocento conobbe l’esposizione di migliaia di neonati e bimbi in tenerissima età, come è emerso chiaramente dagli archivi ritrovati nella “Nunziata”. Ranieri, attraverso la vita di Ginevra, scritta sotto forma di libro di memorie e narrata in prima persona, fornisce un ritratto molto crudo e realistico della Napoli borbonica dell’Ottocento e in particolar modo narra le traversie della ragazza legate all’orfanotrofio della chiesa della Santissima Annunziata.
Io vidi, e studiai, l’ospizio de’ Trovatelli, che quivi si domanda, della Nunziata: e scrissi le carte che seguiranno. E ch’io dicessi la verità, lo mostrarono le prigioni ove fui tratto, e dove, a quei tempi, la verità s’espiava.
Sulla falsariga del patriota esule mantovano Giovanni Arrivabene che aveva redatto un saggio sugli istituti londinesi basato su notizie fornite da enti assistenziali, anche Ranieri persegue l’obiettivo di mettere in luce la reale situazione degli orfanotrofi. Come detto poc’anzi, Ranieri affrontò non pochi ostacoli per la pubblicazione di un libro così scomodo, le istituzioni religiose ne furono pesantemente accusate e vituperate, lo stato borbonico fu chiamato in causa per le condizioni in cui versavano i diseredati sottoposti a soprusi destinati a portarsi appresso per tutta la vita una taccia di emarginazione sociale indelebile. Per riscattarsi dalle accuse infamanti Ferdinando II assegnò cinquantamila ducati in più alla Nunziata e all’Albergo dei poveri ma Ranieri, dopo la pubblicazione del romanzo, fu escluso e isolato nell’ambiente culturale napoletano. Leggere oggi “Ginevra o l’orfana della Nunziata”, rappresenta un viaggio negli abissi del degrado, una discesa sia metaforica sia reale nei sotterranei bui e malsani del convento, simili a gironi infernali danteschi, popolati da donne derelitte, reprobe, rifiutate da tutti. Anche nei passaggi in cui la vicenda di Ginevra sembra assumere i connotati di un romanzo di formazione, subisce un’inversione di tendenza che riporta inesorabilmente la protagonista a una situazione più incresciosa rispetto a quella iniziale. Non ha quasi memoria della sua infanzia, Ginevra, se non legata a patimenti, freddo e stenti. I suoi ricordi iniziano a divenire distinti nel momento in cui è portata fuori per la prima volta dal convento e affidata in successione a diverse megere che la sfruttano ignobilmente, in miserabili tuguri, con lavori pesanti e umilianti, tra fame e percosse. Per altre due volte è usata e gettata via come uno scarto, finisce nella stessa ruota in cui era stata esposta neonata, addirittura a dodici anni è cosparsa di olio e fatta scivolare a forza nel pertugio del meccanismo divenuto troppo stretto persino per il suo corpicino emaciato e rifinito. Mentre si scorrono le prime pagine, è subito chiaro che le memorie siano state scritte al termine della vita della ragazza in una lunga e ininterrotta analessi, ma un interrogativo nasce nell’animo del lettore, relativo al fatto che, parlando in prima persona come narratore autodiegetico, Ginevra si esprima in un linguaggio forbito, accurato, con reminiscenze letterarie. Sarebbe risultato troppo inverosimile e avrebbe sottratto credibilità alla narrazione se la ragazza avesse rispecchiato tout court la cultura del suo autore parlando con la sua lingua. Tale dubbio è sciolto nel cuore della vicenda quando la protagonista narra il suo processo di redenzione ed emancipazione culturale grazie a una monaca francese del convento, di nome Geltrude, che la salva per ben due volte, (la prima, a dodici anni dalle ammaccature della ruota e dai maltrattamenti ricevuti, la seconda dalla reclusione nelle segrete del convento). Ginevra recupera la salute del corpo e per la prima volta in vita sua, ormai adolescente, riceve un’istruzione, è iniziata alle gioie del sapere tramite la sua lettura di moltissimi testi, diviene avida e compulsiva lettrice dei libri che appartengono alla sua benefattrice. Si appassiona di geografia, di storia antica, della Bibbia, della Divina Commedia e si pone di fronte al sapere con un atteggiamento equilibrato seguendo gli insegnamenti della monaca improntati alla moderazione delle passioni eccessive, all’acquisizione di una coscienza critica. Ecco le parole di suor Geltrude:
Cerca, se mai ti vien fatto una volta nella vita, di penetrare in una di queste grandi camere tutte a scaffali di libri, che si chiamano biblioteche. Quivi passa la tua vita a leggere dal primo insino all’ultimo volume che vi troverai. Poi raccogliti in te stessa, e pensa a tutto quello che t’hanno ragionato quei libri; e, pensando, abbi per fermo che non v’è libro al mondo tanto sublime che non contenga di molti errori, né così meschino, che non contenga una qualche verità. Ed allora, fra tutte queste cose che avrai letto, vedrai alcune attenenze, poi alcune altre che non avevi vedute prima, e poi alcune altre ancora. Persevera nel tuo raccoglimento, e vedi quante più puoi di queste attenenze, e vedi, direi quasi, le sottoattenenze che queste attenenze medesime hanno fra loro. E così di sottoattenenze in sottoattenenze perverrai a pochissime attenenze primitive, cioè a pochissimi principii oltra i quali non potrai più procedere con l’intelletto; e crederai che quelli sieno il vero sapere, e sopra quelli reggerai la tua vita.
Anche se non esiste una relazione tra le due opere, sembra quasi sorgere spontaneo un confronto tra la monaca della Nunziata con la più celebre Gertrude manzoniana, figura del tutto opposta: quanto la prima è pia, mite e devota, coltiva la filantropia con autentica fede cristiana, così l’altra è dura, proterva e blasfema, non si riscatta dal suo destino di nefandezze e di abiezione prestando aiuto, riparo e protezione a Lucia ma al contrario persegue la via del delitto. Un altro aspetto da rilevare è che sicuramente Ranieri ha attinto alla vita di Leopardi adolescente nel delineare la figura di Ginevra che si getta nello studio con ardore insopprimibile facendolo diventare la sua ragione di vita. Risvolto notevole è il fatto che Ginevra acquisti la cognizione del dolore universale e l’impossibilità di conseguire il piacere. Ecco le sue riflessioni “leopardiane”:
Né però era compiuto tutto il gran vuoto del mio cuore. E spesso i fantasmi fugaci della prima età, e le speranze, o più tosto le immaginazioni di una felicità ignota e sovrumana, della quale io non sapeva rendere a me stessa né il modo né la forma, non mancavano di affacciarmisi alla fantasia, massime nei dì di primavera. Ma la fredda persuasione in cui ero precipitata, che tutto ciò che più si desidera al mondo o è impossibile a conseguire, o non è quale appare, o conseguito non giova, uccideva subito quelle immaginazioni, e dissipava quei fantasmi. E ricredutami dell’impossibile, se non mi appagai del possibile, almeno mi v’acquetai; e cominciai a poter patire la vita.
Nonostante ottenga un riscatto culturale, l’invidia, per dirla con Dante, “meretrice con gli occhi putti”, fa cadere in disgrazia Ginevra che finisce ingiustamente in una sorta di galera napoletana, tra le “pericolate”, (delinquenti, prostitute, ladre), e poi tra le reiette del convento in orride spelonche sotterranee, per la colpa di una gravidanza frutto della violenza di un sordido sacerdote che la irretisce con false promesse. Quando, riscattata dalle pericolate, apprende di dover finire tra le reprobe del convento, ultime delle ultime per suddetta colpa, pronuncia un addio accorato alla sua camera del convento in cui aveva trascorso giorni sereni con suor Geltrude e altre tre giovinette. Anche queste parole hanno un qualcosa di foscoliano e leopardiano al contempo e l’addio sembra un antecedente del più celebre “addio monti” manzoniano.
Addio, dissi quasi fuori di me, o primo e ultimo albergo della mia innocenza e de’ miei piaceri. Chi mi ti tolse? Sette anni che ti fui sposa non t’aveano fatto mio? Questi tuoi muri non olezzano i miei fiati verginali? Perché non volesti tu accogliere il mio spirito fuggente? Ahi! se quand’egli in breve, puro ed immaculato, quale riposò gran tempo nel tuo grembo, fuggirà da questo corpo che la matrigna natura ha fatto soggetto alla violenza ed alla sozzura umana, se allora gli sarà prescritto dal fato d’aggirarsi alcun altro tempo su questo scellerato pianeta, ancora del tuo grembo, che tu non gli potrai più negare, egli farà asilo alla sua ignuda peregrinazione.
Partorisce, nelle più disperate condizioni, un neonato, che le viene sottratto e destinato alla sua stessa sorte. Attraverso una serie di eventi inaspettati e casuali sembra di nuovo potersi riscattare con l’amore, ma ancora una volta il suo cuore puro e ingenuo è calpestato, altre disgrazie la attendono ma anche un’altra benefattrice, che purtroppo non può in nessun modo cambiare il suo destino, anche se le fa vivere almeno una parentesi di serenità. Finisce nuovamente rinchiusa e non le resta che scrivere le sue memorie e affidarle al padre confessore prima di morire a soli ventiquattro anni.
Ah padre! s’io giungo al termine, e voi non mi assolvete, chi altro assolverete sulla terra? Queste sono le parole di Ginevra che stende le sue memorie e sembrano, a mio avviso, riecheggiare le parole del conte Ugolino nell’Inferno (XXXIII v.42): “e se non piangi, di che pianger suoli?” A questo proposito è doveroso un richiamo al lessico della narrazione, sempre accurato e di un registro stilistico elevato che annovera molte similitudini di chiara reminiscenza classica e innumerevoli citazioni di diversi autori. Eccone alcune, in prevalenza dantesche ma non solo: “colei che sola volgeva la chiave del suo cuore”[1] che ricorda le parole di Pier delle Vigne; “più volte strinsi le braccia dietro a quel fantasma, e altrettante mi tornai al petto con esse”[2] è una non solo citazione dantesca ma anche virgiliana e omerica; “Il quale giusto in quell’istante fu coperto e rovesciato e strascinato via dalla crescente e impetuosissima piena dell’onde, e si sommerse, e mi sommersi anch’io, e l’onde si chiusero sul mio capo”[3] ricorda Ulisse; “Il quale, novello Minosse, consideratele un istante, secondo che gli vanno o no a sangue, le manda a libito”[4] richiama Minosse giudice infernale; “un raggio di luce si fu messo per quel foro ingraticolato di ferro”[5] rimanda alle parole di Ugolino;“All’orribile ritorno de’ miei sentimenti, che l’ultime parole di quell’assassino m’avevano al tutto vinti[6]” riecheggia Dante che rinviene dopo aver udito la storia di Paolo e Francesca, così pure “Quel bacio mi vinse; e mi tolse la forza, non che di resistere, ma di ragionare”[7]; “e spesso un pensiero me ne rampolla mille altri nella mente”[8] si trova simile nelPurgatorio.“Aspri colpi, di cui sentiva dolersi per tutta la persona[9]”ricorda invece Ariosto ; nelle parole “m’era anzi un nuovo stimolo a spremermi più umore dalle due fontane che mi s’erano aperte nella fronte”[10] è presente ancora Ariosto;“i segni dell’antica zappa” sono laparodia dei versi virgiliani ma in un altro passo è usata la citazione originale: “di segni d’antica fiamma”[11]; “S’egli è lecito alcuna volta paragonare le cose piccole alle grandi”[12] è un altro verso virgiliano; “la felicità dei lunghi giorni ch’io trassi al fianco di suora Geltrude”[13] ricorda Tasso; “io che non da un solo ma da mille viaggi e da mille orribilissime tempeste mi sentiva al fianco di suora Geltrude ridotta nel più dolce e tranquillo porto che mai pellegrino sciagurato osò desiderare dalle
onde delle sue sciagure”[14] richiama ancora Tasso. Sono solo alcuni esempi che dimostrano la profonda cultura classica dello scrittore, oltre a evidenziare l’accuratezza compositiva e l’uso del labor limae. In conclusione l’opera di Ranieri ha un valore intrinseco che necessita di una piena rivalutazione. Lessico e temi meritano una posizione di rilievo come esempio di scrittura ottocentesca di registro elevato, la trama è molto ricca e forse talmente tragica da apparire forzata o inverosimile, tuttavia potrebbe essere stata enfatizzata di proposito per far risaltare maggiormente le storture e i pregiudizi nei confronti dei diseredati e degli ultimi. Molti aspetti comuni sia nella vita reale, sia nel rappresentare le ingiustizie dovute al dominio straniero presenta Silvio Pellico. Anch’egli fervente patriota, fu direttore del Conciliatore, il famoso “Foglio azzurro” che si faceva portavoce delle istanze di rinnovamento e svecchiamento della letteratura e propugnava una maggior apertura dell’Italia verso la letteratura degli stati europei. Non mancavano le idee patriottiche e politiche, naturale conseguenza delle ideologie romantiche sulla rivalutazione dell’idea di popolo e nazione. Per questo la rivista divenne subito invisa agli Austriaci e solo dopo un anno ne fu interrotta la pubblicazione. Pellico inoltre fu arrestato come cospiratore carbonaro, come è ben noto dopo aver acquistato una certa notorietà con la rappresentazione della tragedia “Francesca da Rimini”. Al termine della sua lunga e travagliata prigionia, Pellico stese le sue memorie e Metternich affermò che il libro avesse danneggiato l’Austria più di una battaglia persa. Pellico non scrive le pagine autobiografiche con un intento accusatorio, ma come diario intimo, storia di un’anima che, costretta a una detenzione durissima, vuole lasciare intatta la sua umanità, integra la sua coscienza, utilizzando come strumenti di elevazione e purificazione spirituale la filosofia, la letteratura e la religione cristiana. Questo è il ritratto edificante di Pellico che emerge dalle sue pagine, nulla quindi di artefatto o retorico, ma commoventi e sincere parole che scaturiscono direttamente dalla necessità di trovare un appiglio per salvarsi da una condizione di sofferenza e di esclusione sociale date dall’incarcerazione. Il linguaggio è tipicamente ottocentesco, il lessico curato e forbito, rivela la sua profonda cultura ed è sempre perfettamente consono ai sentimenti di mitezza e rassegnazione del protagonista. La narrazione ha inizio il 13 ottobre 1820, data dell’arresto, e ha termine con la scarcerazione nell’estate del 1830. A Parigi, nel 1932 nella Biblioteca Nazionale, furono rinvenuti dei capitoli aggiunti pubblicati dal traduttore francese Louis-Antoine del Latour unitamente alla traduzione, che descrivono la ripresa della vita di Pellico dopo il carcere, il suo ritorno a una condizione fisica accettabile e la decisione di stendere le sue memorie carcerarie. Il solerte traduttore francese allegò anche dei cenni biografici di Silvio Pellico scritti dall’amico e compagno di carcere Pietro Maroncelli che glieli fornì personalmente. Vi sono riportate vicende familiari dello scrittore, le precarie condizioni di salute fin dall’infanzia, la formazione culturale, i primi scritti, i rapporti d’amicizia con il conte Porro Lambertenghi, l’approdo al Conciliatore e al sodalizio con i suoi esponenti. Le memorie di Pellico si aprono in medias res, con l’arresto a Milano e la detenzione nel carcere di Santa Margherita dove, frequentemente sottoposto a estenuanti interrogatori, trascorre circa un mese. Sin dal principio della reclusione, il suo travaglio spirituale lo induce a profonde meditazioni sul ruolo della religione cristiana che lo portano a rinverdire sempre più la sua fede. Ottiene infine la consolazione di possedere Dante e la Bibbia, ogni giorno impara un canto della Divina Commedia a memoria e interiorizza passi del libro sacro che sanciscono il suo rinnovato ardore religioso:
mi insegnava ad amar Dio e gli uomini, a bramare sempre più il regno della giustizia, ad aborrire l’iniquità, perdonando agl’iniqui. Il Cristianesimo, invece di disfare in me ciò che la filosofia poteva avervi fatto di buono, lo confermava, lo avvalorava di ragioni più alte, più potenti.
Un episodio particolarmente toccante di questa prima parte è il legame con un piccolo sordomuto, un orfanello figlio di genitori incarcerati adottato dalla polizia, che egli vede ogni giorno sotto la sua finestra. La gioia e la dolcezza del bimbo, nonostante la sua misera condizione, infondono una serenità inusitata nell’animo del prigioniero, gli suscitano una tenerezza e un desiderio di protezione mai avvertito prima. Questo sentimento gli richiama alla mente la sua precedente attività di precettore e suscita in lui il desiderio impraticabile di salvare quella piccola anima da un siffatto luogo. Trasferito in un’altra cella, rivede il suo amico Melchiorre Gioia e riceve visite dal padre e dal conte Luigi Porro. Quando lascia Milano alla volta di Venezia, è sopraffatto dalla nostalgia:
Era una bellissima notte con lume di luna. Io guardava quelle care vie, nelle quali io aveva passeggiato tanti anni, così felice; quelle case, quelle chiese. Tutto mi rinnovava mille soavi rimembranze. Oh corsìa di Porta Orientale! Oh pubblici giardini, ov’io avea tante volte vagato con Foscolo, con Monti, con Lodovico di Breme, con Pietro Borsieri, con Porro e co’ suoi figliuoli, con tanti altri diletti mortali, conversando in sì gran pienezza di vita e di speranze! Oh come nel dirmi ch’io vi vedeva per l’ultima volta, oh come al vostro rapido fuggire a’ miei sguardi, io sentiva d’avervi amato e d’amarvi! Quando fummo usciti dalla Porta, tirai alquanto il cappello sugli occhi, e piansi, non osservato.
Seconda destinazione sono i Piombi, carceri di stato site nella parte superiore del palazzo del Doge, dove è sottoposto ad altri interrogatori. La solitudine, le afflizioni del caldo afoso e il tormento incessante degli insetti lo prostrano, ma ancora una volta trova conforto nella fede cui poi si aggiunge la scrittura che lo sottrae dai sentimenti negativi. Qui vedono la luce abbozzi di tragedie e poemetti. Neppure in un frangente così difficile tralascia di coltivare i rapporti umani con le poche persone che interagiscono con lui, cioè gli addetti alla sua sorveglianza e al suo sostentamento, con un’affezione particolare verso la figlia giovinetta del custode delle carceri che gli reca ogni tanto il caffè. Riesce a intessere un carteggio clandestino e concitato con un altro carcerato e ad avere qualche sprazzo di conversazione con altri prigionieri politici. Il 21 febbraio 1822 è letta la sua sentenza di condanna a morte che poi è commutata in quindici anni di carcere duro da scontarsi in Austria nella fortezza dello Spielberg. Accoglie la sentenza con rassegnata tranquillità, è lodato dai giudici per questo e gli è concessa la compagnia del suo amico e compagno di sventura, Pietro Maroncelli. Nonostante il dolore, la paura di non rivedere i suoi cari, le continue malattie che lo affliggono, cerca di dissimulare sopportando con coraggio le sue miserie e deplorandole in segreto con disperato pianto. Il dieci aprile 1822 Pellico e Maroncelli giungono a Brno, nei pressi della quale si trova la rocca dello Spielberg, ove si sconta il carcere duro. Celle gelide, un vitto rigido, catene ai piedi, febbri e altri patimenti fisici lo attendono ma anche qui Pellico trova il modo di intessere un rapporto amichevole con il carceriere Schiller che vorrebbe essere burbero ma di fronte alla mitezza e gentilezza del prigioniero, mostra il suo volto più umano. Altro motivo di gioia è l’amicizia con il giovane conte Oroboni, fatta di frasi sommesse pronunciate di nascosto attraverso i muri delle celle, ma destinata a finire tragicamente per la morte di malattia dello sfortunato giovine. Dopo una lunga malattia Pellico ottiene di poter dividere la cella con l’amico Maroncelli.
Ma i sentimenti religiosi e l’amicizia mia per Maroncelli alleggerivano sempre più le mie afflizioni.
Anche Maroncelli, nelle angustie dei sotterranei dello Spielberg si era dilettato a scrivere poesie. Un altro insegnamento di quest’opera, (come pure della precedente trattata), è il potere consolatorio della poesia e della letteratura.
Maroncelli nel suo sotterraneo avea composti molti versi d’una gran bellezza. Me li andava recitando, e ne componeva altri. Io pure ne componeva e li recitava.
[…] Finché avemmo libri, benché ormai tanto riletti da saperli a memoria, eran dolce pascolo alla mente, perché occasione di sempre nuovi esami, confronti, giudizii, rettificazioni, ecc. Leggevamo, ovvero meditavamo gran parte della giornata in silenzi.
Maroncelli subisce l’amputazione di una gamba a causa di un tumore ed è operato da un vecchio medico. E’ uno degli episodi più celebri e più toccanti. Queste le parole che gli rivolge dopo l’intervento:
- Ella m’ha liberato d’un nemico, e non ho modo di rimunerarnela. V’era in un bicchiere sopra la finestra una rosa. -Ti prego di portarmi quella rosa, – mi disse. Gliela portai. Ed ei l’offerse al vecchio chirurgo, dicendogli: – Non ho altro a presentarle in testimonianza della mia gratitudine. Quegli prese la rosa e pianse.
Un insegnamento che oggi lascia l’opera di Pellico, fa apparire la sua grandezza morale e la funzione edificante delle sue penose pagine è offerta da questo passo:
Oh quante cose avemmo a comunicarci, a ricordare, a ripeterci! Quanta soavità nel compianto! Quanta armonia in tutte le idee! Qual contentezza di trovarci d’accordo in fatto di religione, di odiare bensì l’uno e l’altro la ignoranza e la barbarie, ma di non odiare alcun uomo, e di commiserare gli ignoranti ed i barbari, e pregare per loro!
Nel 1830 Pellico, Maroncelli e un terzo condannato, Tonelli ricevono la grazia dall’imperatore. Queste sono le parole di Pellico al suo rientro a casa, foriere un profondo messaggio etico universalmente valido che conferiscono all’opera un alto valore educativo e sempre attuale:
Io amo appassionatamente la mia patria, ma non odio alcun’altra nazione. La civiltà, la ricchezza, la potenza, la gloria sono diverse nelle diverse nazioni; ma in tutte havvi anime obbedienti alla gran vocazione dell’uomo, di amare e compiangere e giovare.
In conclusione, visti anche gli esempi addotti, le opere di Pellico e Ranieri estremamente ricche di avvenimenti e situazioni, offrono al lettore spunti di meditazione e una profonda lezione di umanità. I protagonisti delle due vicende, uno reale e l’altra verosimile, si presentano come vittime d’ingiusti soprusi che tuttavia non danno luogo a odio e rancore, ma sono vissuti nell’accettazione del dolore e nella ricerca di valori superiori in cui rifugiarsi. Entrambi gli autori, insieme con tanti definiti ingiustamente minori, esprimono il disagio di un periodo travagliato come il Risorgimento italiano in cui intellettuali, scrittori, politici ma anche i comuni cittadini, avvertono la necessità di un’organizzazione sociale che garantisca equità sotto l’egida di uno stato libero e unito. Anche la letteratura pertanto ha combattuto la causa dell’Unità d’Italia e Pellico e Ranieri con le loro narrazioni intrise di sofferenza non intendevano suscitare pietismo e compassione ma scuotere le coscienze e lanciare un monito a tutti gli Italiani.
[1] Inferno, XIII vv.58 e seg.
[2] Purgatorio, II vv.80 e seg.
[3] Inferno XXVI vv139 3 seg.
[4] Inferno, V vv. 7 e seg
[5] Inferno XXXIII v 55 e seg
[6] Inferno VI vv1 e seg.
[7] Inferno V vv 132 e seg
[8] Purgatorio, V, vv 16 e seg
[9] Ariosto, Orlando Furioso I ottava XXII
[10] Orlando Furioso, XXIII ottava CXXV
[11] Virgilio, Aen. IV v 23
[12] Virgilio, Bucoliche I v..24
[13] Tasso, Gerusalemme Liberata VII ottave XIII-XV
[14] Tasso, Gerusalemme Liberata I vv 25 e seg
Questo articolo è apparso anche sulla rivista Euterpe
L’immagine di copertina riproduce Silvio Pellico ed è presa da wikipedia