Procida, il romanzo che scardina il romanzo
Di Geraldine Meyer
Che libro è questo Procida di Franco Cordelli? Sicuramente un libro di non agevole lettura. Una sorta di libro-sfida. Sia per l’autore sia per il lettore. Raccontare il nulla come altrimenti potrebbe definirsi? Uno scrittore (l’io narrante) lascia Roma per trascorrere alcune settimane nella sua casa di Procida. Una casa disagevole, con formiche e una colonia di topi. O forse solo il sospetto di una colonia di topi. Un cane, Witold, una moglie, un’amante, una figlia che appaiono solo come fantasmi evocati dalla scrittura. Quasi tutti figli e figlie di un padre infecondo (il narratore stesso), vivi solo nelle parole della sua voce, voce che dice io.
E allora si ripete, per forza, la domanda iniziale: che libro è Procida? Un libro con cui Cordelli stesso ha avuto un rapporto non semplice, viste le diverse versioni del testo. Un “finto” diario a cui, prima vengono tolte le date e successivamente rimesse. Un atto che, di per sé, fa comprendere come in gioco ci sia l’idea stessa di romanzo. Il romanzo è morto (lo era già quando Procida fu scritto e pubblicato la prima volta) viva il romanzo. Ma in che forma?
Andrea Caterini, nella dotta e articolata postfazione, scrive: “Procida, il primo romanzo di Cordelli […] è un luogo comune. Difficile trovare un’isola più letteraria di Procida. Quella di Arturo.” Suggerendo così come questo libro sia un “cavallo di Troia” per scardinare l’idea stessa di romanzo.
Un diario dunque, la forma in cui la vita viene immediatamente trasposta in scrittura. E qui la vita non sono gli avvenimenti ma gli stati mentali. Un ondeggiare tra ricordi, fantasie, paure, visioni. Ma chi racconta e scrive chi è? Scrive Cordelli nel capitolo Ritorno a Procida che si tratta di “un uomo-romanzo, della sua carenza di identità e della sua vita solitaria, di un uomo in lotta con il suo rifiuto della paternità ovvero con il suo desiderio di paternità.”
Paternità, segno, simbolo e significante che torna per tutto il libro. E che non riguarda solo il rapporto padre-figlia ma, anche e soprattutto, il rapporto tra l’autore e le sue pagine. Che raccontando il nulla, scarnificandosi, si fanno segno tra segni. Rapporto che sembra suggerire l’idea di una grammatica mentale che non può non diventare una grammatica letteraria, una semantica e, dunque, un giudizio. Lacan docet?
L’autore, non raccontando eventi (l’assenza dei quali era ciò che l’io narrante andava cercando) ne narra però l’assenza e l’essenza che è, in definitiva, la mente nuda del narratore stesso. Da qui le immagini di rapporti sessuali consumati o no, soprattutto orali (non a caso, la sessualità come parola), falli, erezioni abortite o precoci. Ancora dunque una paternità mascherata e, alla fine, infeconda, che autodistrugge sé stessa. Come la sfida di scrivere un romanzo scardinandolo. Come non è a caso che il fantasma di Gombrowicz aleggi per tutto il libro. Caterini ricorda Pornografia a me invece viene in mente Cosmo, con il computare cose e oggetti quasi a dare un senso al caos ma qui, in più, ad aumentare le domande. Procida dunque quasi come un romanzo che divora sé stesso. Emblematica, o simbolica, la scena in cui il narratore trova il cadavere del topo e lo avvolge proprio con una pagina del suo quaderno e gli da fuoco. Come scrive Caterini:” Il copro del topo è un’offerta di sacrificio all’isola. Un corpo morto adagiato sui fogli del diario, che poi significa il sacrificio – un atto desacralizzante; ancora una contraddizione, un ossimoro.” Il romanzo che va scrivendosi negandosi
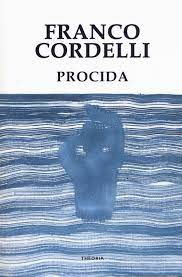 Procida
Procida
Letteratura
Theoria
2018
233 p., brossura















