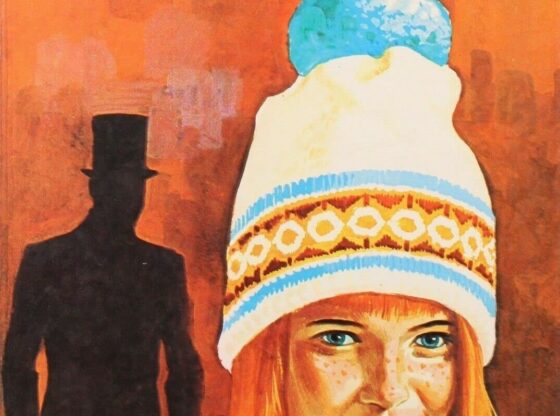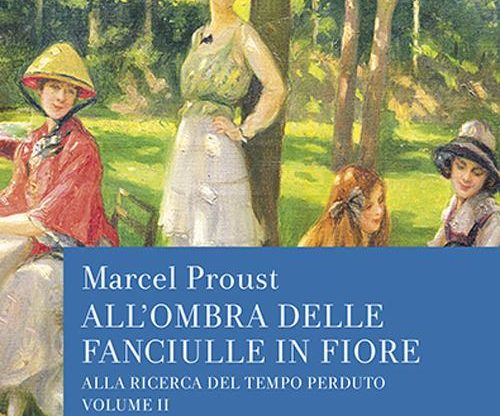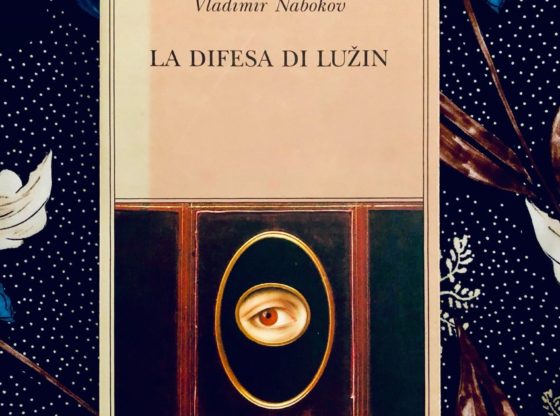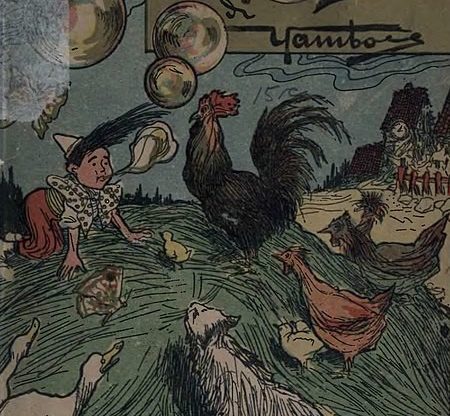Un capolavoro dimenticato
Di Marianna Inserra
“Guardava un po’ scoraggiato anche lui quelle campagne dove non si scorgeva un fil d’erba, quel cielo che, da mesi e mesi, non mostrava agli occhi ansiosi l’ombra di una nuvoletta all’orizzonte. Soltanto l’Etna fumava, quasi volesse ingannare la gente facendo scambiare per nuvole le dense ondate di fumo del suo cratere, che il vento disperdeva lontano”.
Il marchese di Roccaverdina si inserisce, non senza fare qualche forzatura, nella corrente letteraria del Verismo, di cui Luigi Capuana, insieme a Giovanni Verga, è uno dei principali esponenti, se non addirittura il teorico. Il romanzo uscì nel 1901 per l’editore Treves di Torino, lo stesso che aveva pubblicato I Malavoglia (1881), Mastro-don Gesualdo (1889) di Verga e anche Il piacere (1889) di D’Annunzio.
Un’opera complessa, per le tematiche trattate, gli spunti di riflessione e per la figura prismatica del protagonista, nonché per lo stile lineare, con qualche flashback, che caratterizza la penna di Capuana.
Un capolavoro quasi dimenticato, forse perché oscurato dalle opere dell’amico fraterno Giovanni Verga, con cui condivideva non solo la passione per la scrittura -vicina ai dettami del Naturalismo francese, adattato alla realtà del Sud Italia – ma anche per la fotografia, di cui il Capuana fu un vero maestro.
L’opera si apre con Mamma Grazia, la nutrice del marchese, che si affaccia all’uscio dello studio per annunciargli la visita dell’avvocato Aquilante, per discutere del triste affare riguardante l’omicidio di Rocco Criscione, fedele servitore del marchese.
Da subito il lettore è inserito in uno spazio chiuso, lo stato d’animo del Roccaverdina è in sintonia col tempo fuori: è una notte cupa, lampi e tuoni fanno sobbalzare i più impressionabili e la figura stessa dell’avvocato fa ghiacciare per un istante il sangue del marchese.
“Latinista, grecista, filosofo, teologo, giureconsulto, egli era tenuto meritatamente in grandissima stima anche nei paesi vicini. «Peccato che sia ammattito per gli Spiriti!», dicevano tutti. Il marchese non era giunto ancora ad esclamare così; ma quelle magherie, come le chiamava, lo impensierivano per l’avvenire”.
Il romanzo è ambientato nei luoghi in cui è nato e cresciuto l’autore, tra Rabbato e Margitello, nel catanese. Non si tratta di un giallo: al lettore verrà svelato nei primi capitoli che il marchese è l’autore di quel delitto.
La vittima, Rocco Criscione, servitore devoto, al punto di essere conosciuto col nome di “Rocco del marchese”, era stato costretto a sposare la donna che per dieci anni il marchese si era tenuto in casa come schiava e
concubina, Agrippina Solmo, giurando che non l’avrebbe mai toccata, che sarebbero stati nella stessa casa come fratello e sorella.
Questa strana trovata del marchese era stata dettata dalla necessità di mettere a tacere lo scandalo che la sua condotta peccaminosa gettava sul buon nome della famiglia.
Purtroppo però, roso dalla gelosia e dal sospetto che i due fossero venuti meno al giuramento, il marchese in preda ad un terribile raptus con una “fiammata” del fucile uccide il servitore e non fa nulla per scagionare l’innocente, un certo Neli Casaccio, condannato per omicidio al posto suo.
Il focus del romanzo è il rimorso della coscienza del marchese, una sorta di Delitto e castigo verista e ciò non deve meravigliare il lettore, poiché a quel tempo in Italia giravano le opere d’oltralpe, tra cui i romanzi russi e sicuramente l’opera del Dostoevskij aveva influenzato Capuana e anche la stessa Deledda di Canne al vento, seppur ognuno di loro abbia inserito nelle proprie opere caratteri originali e riconoscibili.
Antonio, marchese di Roccaverdina, per tutta la durata della narrazione, cercherà in tutti i modi di mettere a tacere la voce della sua coscienza che gli rende la vita impossibile. I suoi nervi sono ipersensibili e si alterano per un nonnulla: le stesse “magherie” dell’amico Aquilante che lui tanto derideva prima del fattaccio, gli mettono addosso strani brividi e paure sconosciute, come quella di ritrovarsi da solo nel salone di casa. Ad un certo punto dona il grande crocifisso di legno a grandezza naturale ai frati della vicina parrocchia, perché non riesce più a passare per lo stanzino in cui era sistemato da decenni, senza tremare:
“egli rivedeva il gran Crocifisso che lo guardava, lo guardava con gli occhi velati dallo spasimo dell’agonia, agitando le labbra tumide e pavonazze per pronunziare parole che non prendevano suono (…)”
Per alleggerire la coscienza rivela in confessione il delitto allo smilzo don Silvio, che di là a poco morirà col suo segreto. Ma ciò non basterà a calmare i suoi nervi. Le stesse dottrine positivistiche, di cui si fa portavoce suo cugino, il cavaliere Pergola, riusciranno solo per poco a far respirare il nostro marchese.
«Avete gli occhi chiusi, caro cugino. Se credete di guadagnarvi il paradiso!… Il paradiso è quaggiù, mentre respiriamo e viviamo. Dopo, si diventa un pugno di cenere e tutto è finito.»
«E l’anima?»
«Ma che anima! L’anima è il corpo che funziona; morto il corpo, morta l’anima. Chi ha mai visto un’anima? Soltanto don Aquilante e i pochi pazzi
suoi pari si illudono di parlare con gli Spiriti.» «Che ci assicura che sia come dite voi?» «La scienza, l’esperienza. Nessuno è mai tornato dall’altro mondo… (…)
Un romanzo interessante, ligio ai dettami del Verismo, che cala le vicende in luoghi reali, in epoca post-unitaria. Le credenze religiose vengono attaccate su un doppio fronte: dalla scienza positivista e dalle idee evoluzionistiche (il cugino) e dallo spiritismo (don Aquilante). Questi personaggi sono assolutamente pittoreschi e contraddittori: l’uno, ateo e scettico, credutosi moribondo si fa riempire la casa di reliquie di santi, tutte provenienti dalle vicine chiese, e sposa la donna con cui ha convissuto in peccato tanti anni e l’altro, l’avvocato, uomo di legge colto, che cede alle lusinghe dello spiritismo e delle scienze occulte.
I paradossi si ripetono spesso:
“Ti sei data… a tuo marito, come una sgualdrina! Non era, non doveva essere marito di apparenza soltanto?…”
Il marchese, sempre allo scopo di mettere a tacere la propria coscienza, sposa la signorina Mugnos, suo amore adolescenziale, caduto in disgrazia a causa della prodigalità del padre, ma l’unione servirà solamente a rendere infelici entrambi, perchè la nuova marchesa avvertirà il fantasma dell’antica amante frapporsi tra lei e il marito e aggirarsi per la sua nuova casa.
Da segnalare l’uso di proverbi del luogo, proprio come nei romanzi di Verga, lo spaccato di vita contadina, di cui la fa parte lo stesso Antonio dei Roccaverdina, “il marchese contadino”. I braccianti e i lavoratori conducono una vita dedita al sacrificio, legata al ritmo e al capriccio delle stagioni, dove il raccolto non è all’altezza delle grandi culture intensive del Nord Italia e del Nord Europa.
Nodo cruciale della questione meridionale:
“Noi abbiamo quel che ci meritiamo», aveva soggiunto il marchese. «Non ci curiamo di associarci, di riunire le nostre forze. Io vorrei mettermi avanti, ma mi sento cascare le braccia! Diffidiamo l’uno dell’altro! Non vogliamo scomodarci per affrontare le difficoltà, né correre i pericoli di una speculazione. Siamo tanti bambini che attendono di essere imboccati col cucchiaino… Vogliamo la pappa bell’e preparata!»
Un capolavoro (quasi) dimenticato da recuperare, sia per la ricchezza delle tematiche, sia per la complessità psicologica del protagonista.