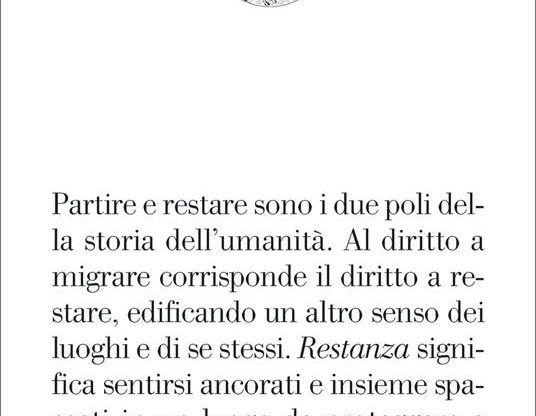La restanza, una resistenza
Di Geraldine Meyer
Non so se il discorso accademico preveda o ipotizzi una stretta di mano tra antropologia e poesia. Ma qui, da sponde molto lontane dall’accademia, viaggiamo forse seguendo altre carte geografiche. E la stretta di mano, tra questi due metodi di restituzione di sguardo e ascolto, li vediamo, li avvertiamo. Più come intuizione che come metodo. La restanza, il nuovo libro di Vito Teti, ci accompagna con una bussola che tiene insieme il rigore scientifico dell’antropologia e una parola dal ritmo, cadenza e suggestione poetica, nel senso etimologico del termine. Un fare che è ascolto, sguardo, accoglienza della complessità e problematizzazione di un umano che mal si adatta alle banalizzazioni degli schemi.
Che senso hanno i luoghi? Ne hanno uno granitico ad uso politico (nel senso più ampio e ahimé deteriore del termine) o hanno il senso che gli donano, di volta in volta, nel tempo e con il tempo, le vicende umane e l’umano radicarsi e sradicarsi? Perché restanza non è restare e non è nemmeno in netta contrapposizione con il partire, con la viandanza fisica o metafisica. Restanza è un fenomeno, più che un concetto, su cui indagare e interrogarsi ha, oggi, un’urgenza semantica, filosofica, poetica e, appunto, antropologica. È un nuovo senso dei luoghi che ha, possiamo dire, due estremi: migrare e restare. Andarsene o rimanere nei luoghi in cui si è nati, annusarli, camminarli, guardarli e ascoltarli. Non lasciandosi pervadere da una paralizzante nostalgia ma, al contrario, assumendo su di sé una scommessa, che è quella dell’inevitabile e ineludibile mutamento. Restanza, in questo senso, non è una radice immobile, non è impedimento al muoversi. È un altro modo di farlo, un viaggio da fermi o meglio, un viaggio da apparentemente fermi.
Un libro che è una riflessione che nasce dagli eventi che l’umanità ha vissuto e sta vivendo in questa tempestosa epoca, tra pandemie, guerre e cambiamenti climatici. Rivolgimenti che impongono, senza rimandi, domande e progetti per un nuovo modo di abitare per chi resta. Che, inevitabilmente, diventa anche un nuovo modo di pensare e costruire una comunità.
Un libro che ha il suo nucleo in ciò che vuol dire abitare i piccoli paesi fuori dalla retorica del borgo, idealizzato e venduto/svenduto nella parola stessa: borgo. No, si tratta di paesi, strati di storie, difficoltà, silenzi, abbandoni che hanno bisogno di “pratiche di memoria” per chi resta ma (lo si comprende bene leggendo queste meravigliose pagine) anche per chi è andato via. In un continuo gioco di specchi e rimandi, voci e echi, racconti passati e nuovi riti fondanti di un altrove.
Restanza però non è solo dei paesi e nei paesi. È ormai una scommessa che riguarda anche le città, una sfida forse, un problema e, talvolta, un conflitto. Da cui però può arrivare un nuovo, vivificante e rigenerativo modo di abitare e di vivere, sia per i luoghi sia per chi li vive. Mettendo anche in discussione il concetto stesso di abbandono e, quindi, di comunità. Un paese in cui sono rimaste solo tre persone è un paese abbandonato? Non sono, quelle tre persone, abitanti e “custodi” non di un passato ma, al contrario, di una resistenza che è restanza certo ma anche, in qualche modo, un passo verso il futuro. Quindi in avanti, quindi comunque un proseguire.
Lo dicono bene le parole riportate sulla copertina: “Restanza significa sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente.” E in fondo non è azzardato spostare, semanticamente, la restanza, dai luoghi alle dinamiche umane. Perché lo spaesamento non deve fare paura. È quel senso subitaneo di vuoto, di terreno che viene a mancare sotto i piedi ma che può costringerci a cambiare passo inciampando
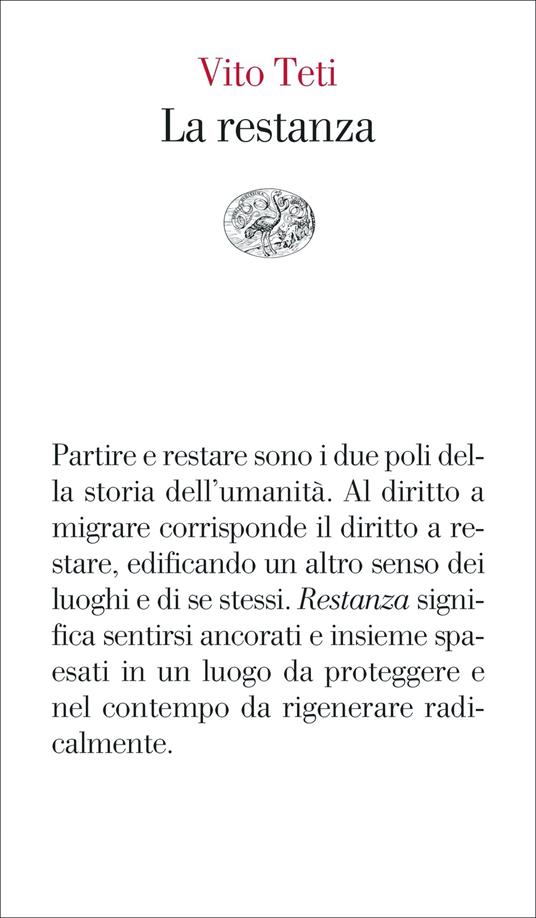 La restanza
La restanza
Vele
Antropologia
Einaudi
2022
142 p., brossura