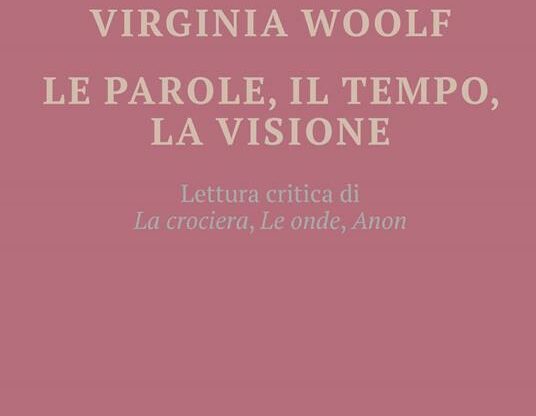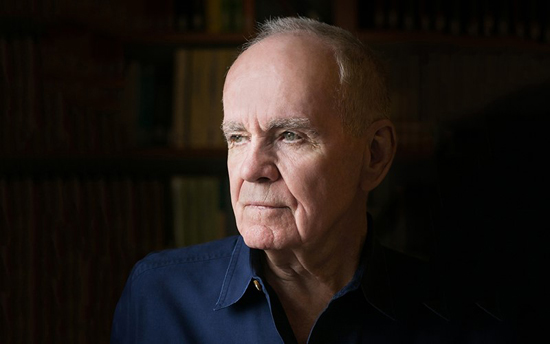Lord degli imbarazzi
Di Piero Dal Bon
Lord degli imbarazzi, lirico dell’insicurezza e della perplessità esistenziale, borghese scettico, cortesemente a disagio nel proprio tempo (“non lo amo il mio tempo, proprio non lo amo”) di accelerazioni tardocapitalisitche, poeta plurale dell’ascolto di sé e delle voci della tenerezza e della sconfitta, impietoso giudice di sé e del proprio spazio sociale, discreto nel radicalismo emotivo ed etico, sempre urbano nel decoro, ma con accessi utopici e rivoluzionari, versificatore della lancinante presenza della gioia, del ritardo e del rimorso, Vittorio Sereni era, è, il maggior lirico della generazione postmontaliana.
La sua poetica dialogica, antiorfica, esistenziale ma anche metafisica, vuole saldare i conti con l’esperienza, restituire la poesia, dopo gli eccessi dissolventi della tradizione mallarmeana, in un discorso quotidiano e umano, che, con umiltà ferita e orgoglio, mira, con parole sue, a raccogliere altri, e se stessi con altri, attorno a qualcosa”.
Intimista, storico delle proprie emozioni, e insieme cronista iroso e deluso di un quarantennio di storia italiana ed europea, Sereni è il testimone ferito della corrosione dei possibili, storici ed esistenziali, la voce che, amara e risentita, ha, per lampi di invettive, detto l’involuzione e l’espropriazione della storia contemporanea, la profonda assenza di finalità collettive, che mutila ed accieca le esistenze individuali, con la scomparsa d’ogni prospettiva dell’uomo su se medesimo, sino ad approdi di un tetro nichilismo perentorio, atroce e feroce, in una linea che ha in Leopardi un suo maestro diretto. “Nulla nessuno in nessun luogo mai”
Lirico parco, autore di appena quattro volumi di liriche, nei suoi timidi esordi della trepidante raccolta Frontiera, (il titolo è polivalente, 1941) coniuga e contamina le rarefazioni astratizzanti e superbamente ascetiche dell’ermetismo ungarettiano, allora in voga, con una narratività, dai modi diaristici, che è fedeltà alla propria esperienza e ai propri luoghi: è una sorta di elegiaco, e conradiano, requiem alla giovinezza, sussurrato con eleganza e riserbo da una voce che, timorata e presaga, avverte e registra i sinistri segnali, anche storici, che minacciano e incrinano un presente e un paesaggio d’idillio, opponendovi il lieve esorcismo di una evocatività sognante e immobilizzante.
Ma dovette accadere che gli eventi di una storia temuta ed elusa irrompessero nella biografia squisita di un umanista atterrito e reclinato nell’auscultazione di se e del paesaggio: dall’esperienza di prigionia in Africa duramente patita, nasce il diario di guerra e cattività, Diario d’Algeria (1947), profonda, penetrante, claustrofilia cronaca che registra la mortificazione coatta dell’individuo, nei suoi tentativi di simulare una vitalità lontana e impossibile (“non sanno d’esser morti i morti come noi”), corrosa da una potente pulsione a celebrare quella prigionia come simbolica della condizione umana, a suo modo, masochisticamente, autosufficiente e perfetta (“ora ogni fronda è muta/compatto il guscio d’oblio/perfetto il cerchio”). Nasce da qui, quel senso di sfasamento di Sereni rispetto al reale, la constatazione straniante più volte dolorosamente ribadita di un ritardo rispetto al corso storico, di un’incongruenza perplessa, gnoseologicamente smarrita.
Questa mal sicurezza ed esitazione, una radicale insicurezza di sé, il corrosivo e ghignante dubbio sistematico sul proprio ruolo, e la propria identità, la messa in discussione della liceità della genere lirico in tempi di mercificazione universale sono le costanti tematiche che attraversano uno dei libri di poesia più decisivi, densi ed impegnativi del secondo Novecento europeo, lo splendidamente fosco Gli strumenti umani (1963), evento inaugurale della nuova lirica italiana, per la sua capacità di assimilare all’interno del discorso poetico segmenti foschi di storia italiana ed europea, visioni kafkiana, parabole, sogni di visitazioni di morti, abile nel coniugare e saldare biografia e storia, interpretando la prima come metafora del secondo, immergendosi, con acre irritazione e con smarrito orrore nelle le forme del “segregato squallore dentro le forme del vuoto” e “gli asettici inferni” dell’industria: con prospezioni retrospettive di raccapriccio e fascinazione per gli orrori nazisti. In effetti non è facile trovare un libro come questo che contenga tanta storia privata e collettiva. Si tratta di un lirismo tentacolare, polifonico e plurilinguistico che alterna verticalizzazioni liriche, e discese nella prosa, sincopatamente romanzesche, di una narratività che sbozza stralci di biografia ingorgate, requisitorie contro pretenziose mode culturali e ricatti ideologici, la cui violenza viene esaltata, dialetticamente, dal contemporaneo elogio, oraziano, dell’amore e dell’amicizia come forme di protezione nei confronti della ferocia utilitaristica della nuove belve generate dal miracolo economico degli anni sessanta. Insieme tenero e rabbioso Sereni ausculta e da voce agli umiliati e offesi, agli sconfitti della storia, a coloro che non sono mai vissuti. Ai morti, secondo modalità conoscitive premoderne, è affidata la voce dell’autenticità, del riscatto, essi, apparendo, in visitazioni extrarealistiche e shakesperiane, sono le possibilità irrealizzate dell’esistenza, che, con la loro presenza, smussano le punte egotisitiche dei viventi, promettendo, utopicamente un ritorno di vita movimento e luce, dentro il purgatorio borghese della contemporaneità. Renitente a prendere forme politiche riconoscibili, per un invincibile senso della complessità del reale, nonostante ciò la poesia di Sereni è risentita interprete di alcuni decenni di vita della borghesia italiana nel suo trapasso e dissoluzione nelle forme dell’ultimo capitalismo, di qui il tono alto dei suoi appelli, delle sue indignazioni deprecative, appena lontano da quello di Pasolini per un di più di ritegno stilistico e morale. Contro la deludente realtà del presente scaglia la passione della gioia, come audacia vitale e pienezza futura, ad essa è dedicata una delle liriche più struggenti del volume. A livello formale l’innovatività è forte: imperversa una scrittura a più strati, mistilingue, screziata e ricca di escursione, che travolge lo squisito monologo lirico delle due raccolte anteriori, sussumendolo in una compagine che contamina tutti i registri, dalla concentrazione gnomica e lirica alle cadenze formali di un parlato che imita, tra sarcasmo e ironia, i codici dell’intellettualità del suo tempo: l’io stesso contemplato e irriso, si sdoppia in giudice e imputato, ora soccombendo ai vociferii della condanna, ora inarbolandosi di forza e fermezza verso un apertura e un movimento: domina nel corso di tutto il libro un forte senso di occlusione vitale, di circolarità viziosa, di stallo perplesso e soffocato, come se il personaggio lirico che lo attraversa fosse stato espropriato di una vitalità, che rimpiange e invidia nei numerosi alterego sportivi che lo fronteggiano, con burla tenera ironia perfidia o sarcasmo: specchio l’io di una storia sfilacciata e involuta, di una paralisi storica. Ma il verbo conclusivo della splendida lirica finale, La spiaggia, qui accolta, è al futuro, tempo di una pienezza augurata, appello alla trasformazione radicale, alla rinascita di quelle parti di noi e della realtà che “qui n’ont jamais vecu”.
L’ultima raccolta, Stella variabile (1981) pone la sordina ad ogni positività, e radicalizza la negatività, in partiture testuali ritmicamente più smorzate ed essenziali, a forma di gomitolo o spirale, che guardano con spietata chiaroveggenza il colore del vuoto: dominano le immagini dell’essere come sperpero, dispersione ed emorragia, i bilanci fallimentari che constatano ristagno e falso movimento, nella constatata impossibilità del proprio tempo a tradursi in storia. Dalla vischiosa partecipazione del soggetto all’onnipresente male (“parte del male tu stesso”) nasce il congedo da sé, il desiderio di essere altro, con un narcisismo di segno negativo. La poesia stessa, il linguaggio che la dice ha un potere solamente nullificante, mortificante, privando di esistenza l’oggetto o quanto nomina. Inappartenenza e rinuncia ad ogni principio di identificazione contrassegnano un io ridotto a spettro, vivo in una sua premorte. Dal primitivo esistenzialismo postmontaliano, con la sua concretezza di scenari e persone, la sua fedeltà al tempo, Sereni, “attonito/di tempo pietrificato in spazio/ di mutismo/, approda ad una metafisica del nulla, in una rappresentazione scorporata di cui di “tutti i colori il più forte il più indelebile è il colore del nulla”. Ma è un nichilismo ricco, dai toni variati: pur dal no sale un vitalistico sommesso inno a virtù umane che gli si oppongono, abnegazione ed innocenza, dedizione e magnanimità cortese nell’ignavo sfasciarsi di ogni forma civile nella barbarie dell’oggi.
In copertina immagine di Vittorio Sereni, foto presa da wikipedia