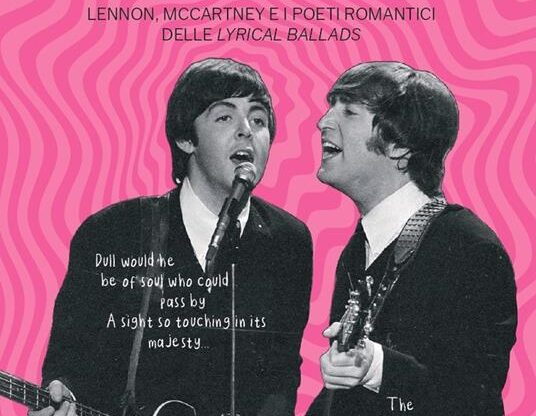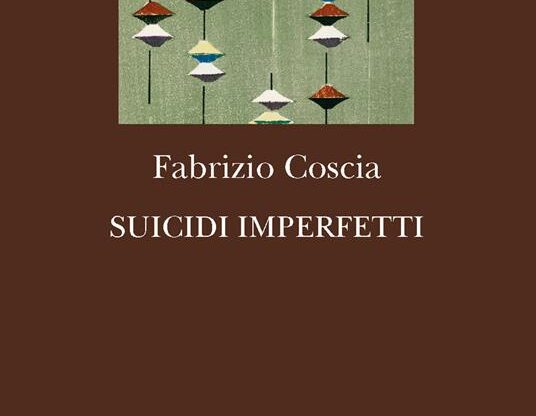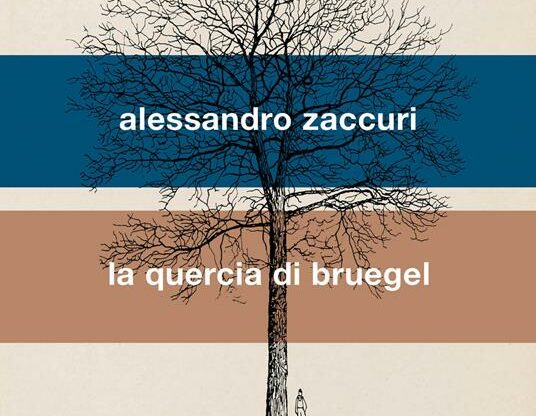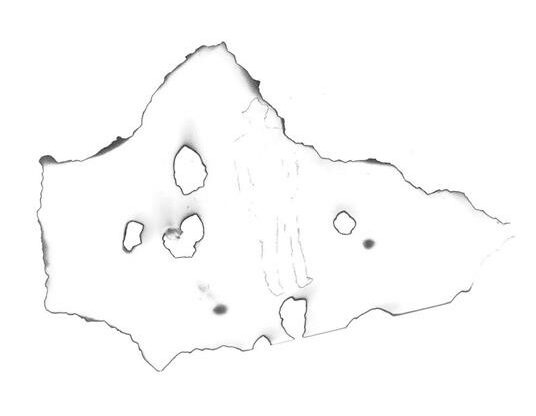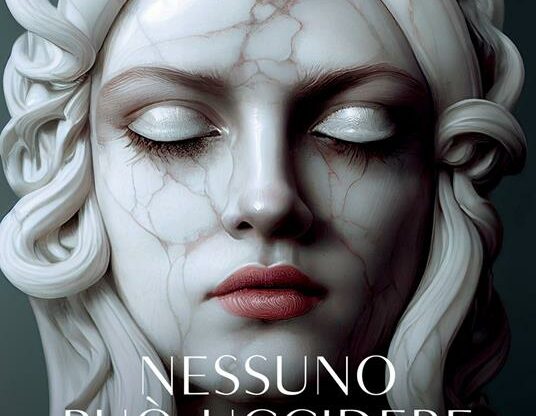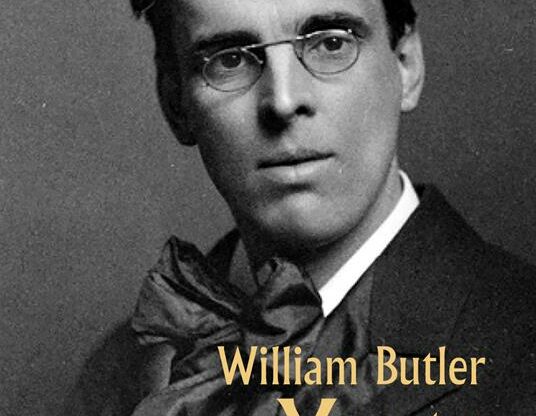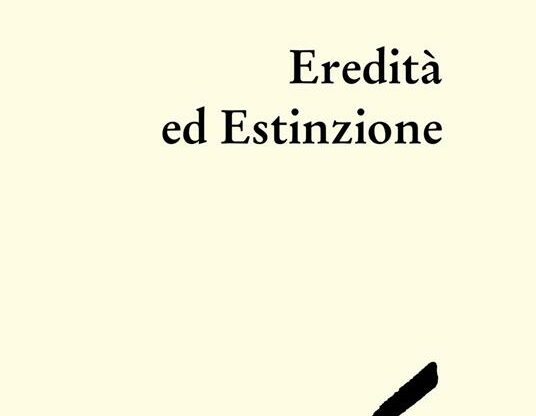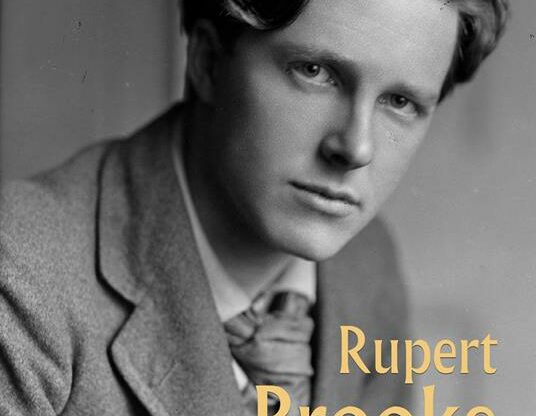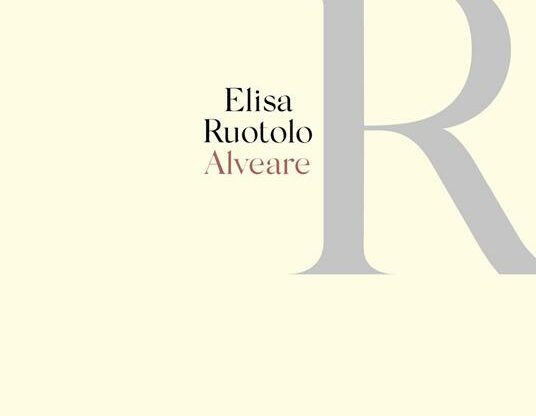I cigni neri di Enrico Fraccacreta
Di Rossella Pretto
In definitiva sì, te li sei sempre trovati attorno. I cigni neri, intendi, quelli di cui scrive Enrico Fraccacreta in un bellissimo libro uscito per Passigli nel 2021. Ma tu non li chiami così. I tuoi sono altri, così diversi quelli che hai visto sulle creste del Circeo, i lunghi colli scuri e l’andatura zoppa, ombre di un’estate in cui il sole non faceva altro che inabissarsi per far spazio ai morti.
Quelli che Enrico Fraccacreta inizialmente chiama cigni neri tu invece li chiami “matti”. Ma il poeta dice meglio, sempre. Anche piegandoli ad assumere significati diversi, piume che svariano nei toni del nero. E dunque nel proseguo del libro, nelle altre due sezioni, i cigni mutano e tramutano.
“I Matti”, a casa tua invece, erano quelli che ti abitavano sopra la testa: lui, lei e la madre di lei – che era “normale”. Anche se probabilmente subiva delle sevizie da quei due che… normali no, proprio non lo erano. Prima di tutto perché erano fuori tempo, come scollati dal presente e catapultati da un passato non lontanissimo ma giusto quel poco che fa distorcere lo sguardo e la linea coerente del tempo. E poi erano in qualche modo ubiqui, oltre che ambigui. Lui, soprattutto. Te lo ritrovavi sempre dove meno te lo aspettavi. Magari come una presenza inquietante che spia da una finestra. Calzoni di un marrone vecchio e spento, canottiera bianca e bretelle buone a tenere su i vestiti su quella sua impalcatura sifilitica e fibrosa. Sempre così lo vedi, quasi fosse indenne dall’inverno. Saranno tuoi ricordi falsati. Lei invece aveva i capelli rossi, tinti, e gli occhi verdi tagliati. Con una punta di cattiveria fredda. Te ne sei resa conto quando ha litigato con la mamma, un’aggressione in piena regola. Di punto in bianco. Vipera dai capelli di fuoco. Ecco, sì, occhi da rettile. Eppure ci passavi del tempo, avevi il permesso di frequentarli e di andare a casa loro. Gran coraggio, i tuoi.
Hai ricordi che non metti troppo a fuoco. E i due fungono da veicoli per un rimosso che parla attraverso di loro. Non necessariamente nella forma della corrispondenza più fedele. Quanti significati si nascondono in una risposta apparentemente scontata. Come nei sogni. L’inconscio parla per dislocazioni. La tua fragilità ha avuto inizio con un ricordo improvviso, un’immagine: quella del Matto, che ti ha terrorizzato. Forse perché l’eccesso ha scatenato la paura. Mani sulle orecchie per non sentire (sentire cosa?), ti sei raggomitolata su te stessa e sei crollata a terra, un pianto senza freni. Matti sono quelli che perdono il controllo. E il controllo tu te lo sei sempre tenuto stretto, insieme alla consapevolezza del confine, necessario a sopravvivere all’evaporazione dell’indistinto.
E poi c’era quello più divertente, di matto, che veniva fuori dalla scuola e cantava a squarciagola, un grido altissimo e l’espressione più singolare che tu abbia mai visto. Vi faceva ridere un sacco. Ma in fondo ne avevate timore. Non si sapeva mai come potesse reagire.
Quello di Roma, infine, quello che ha sferrato un calcio all’indietro e non ti ha preso per un pelo è stato un’altra cosa. Quella volta sei entrata volontariamente nel suo campo visivo all’interno di uno specchio, hai cercato i suoi occhi, volevi farlo uscire da quell’ossessione, riportarlo fuori. Ma lui ha reagito in maniera repentina e violenta. Non hai potuto fare niente. E l’hai lasciato lì, dietro San Pietro, in quella sua lotta ostinata e furiosa combattuta dentro lo specchio, tra occhio e riflesso.
Ne hai altri, di matti, ma non è ora il momento di parlarne, basti sapere che ti sono molto vicini.
Ora però li ritrovi anche nel libro di Enrico Fraccacreta, quei cigni neri. Tre movimenti, tre migrazioni, accompagnate da epigrafi dantesche, dal Purgatorio e dal Paradiso. Perché qui si tratta sempre di volare, di stare a terra solo per poter poi compiere quel volo che inizia con la corsa dei ragazzi sul lungolago di Lesina, quando Graziellina, non ancora partita per la gara, si aggiusta i capelli «convinta di doversi ancora sposare» mentre le nuvole le fanno un applauso scatenando il frullo d’ali di quei «navigatori del sortilegio» che sono i cigni neri di Fraccacreta. Due anni passati con i ragazzi del Centro di igiene mentale in provincia di Foggia, di cui il poeta ci racconta nel prologo “Prima del canto”, ruvido e autentico. Due anni trascorsi tra passeggiate e lezioni di vivaismo che Fraccacreta era tenuto a imbastire per loro imparandone al contempo la meraviglia, gli sguardi tremuli e qualche mancanza o defezione, alla fine – «Dove siete ora tutti quanti». Come Anna, che «di solito pesca la giovinezza della menta / prima di diventare un incantesimo, / lei è sorella degli stati d’animo / insieme corrono, s’inseguono a vicenda / giocando nel paesaggio, / poi si accordano per cercare l’ultima sorella / quella ribelle che sparisce e fatichi a ritrovarla / perché si nasconde, potrebbe essere ovunque / anche qui, mimetizzata nel verde delle piante / la speranza». Esseri fragili e annaspanti, molto simili, per rimanere in tema di volatili, all’Albatro di Baudelaire, così goffo sulla terra, maldestro e fuori posto, le «prince des nuées» con quelle sue magnifiche ali che trascina pietosamente sulla tolda della nave come fossero diventate enormi remi marci. Eppure parlano dell’animo del poeta, che sa trasformare quel marciume in splendidi motori di volo intuendo la complessità del tutto. «E tutti si fermano con le forbici in mano / vicino al pozzo che stilla stupefatto / in mezzo ai tralci aperti della vigna / i rami attaccati nella nebbia / e un falò di contadini nel podere vicino / che si voltano per guardare curiosi / le lucciole scoccare inaudite / a illuminare tutta la campagna». Il che assomiglia a quel palato di stelle heaneiano, quando il poeta mangia deliberatamente il giorno perché lo possa risvegliare al puro verbo. Suggestioni mie. Forse destate da un verbo di Fraccacreta, “scoccare”, che in Heaney è invece uno “schioccare” di gusci d’ostriche che si aprono sui piatti, la lingua del poeta un estuario in piena. Ma è così che succede a leggere Fraccacreta, qualcosa lampeggia nel buio finché una visione si apre dirompente, luminosissima, scatenando un sentimento puro del sacro, stupore e terrore dell’Altro che si manifesta venerabile pur nell’infamia che il sacer richiama. Sono figure che in qualche modo si immolano e non vorrebbero, spiriti delle vigne, creature di terra a cui per respirare sono necessarie le ali, giovani dèi «confusi nella mente», con una dotazione di piume e spine, grandi bocche come abissi che inglobano costellazioni e miserie, le mani tremanti per il soffio magico che hanno tra le dita mangiate dalle serpi.
Andando avanti, ecco poi che si svela una verità, si affaccia l’amore largo, Beatrice, che nell’epigrafe alla seconda sezione/migrazione (Paradiso, canto terzo) prelude all’entrata di altre figure dalle parvenze umane ma già contaminate da un sole più luminoso e divino. L’«evidenza dei miracoli». Un canto che diventa «altissimo». Ed è tutto un sussurro, un parlottio che si sfrangia e si impenna in una natura che diventa porto sicuro. Una leggera malinconia, un riverbero e una bellezza che sfolgora nell’inchino al Cristo, anche quello del «piccolo popolo / del cielo terrestre»: «Se la Scrittura non avesse dovuto compiersi / a caro prezzo, si sarebbero rivoltati contro / scendendo come nebbia tra gli ulivi, / a migliaia sarebbero accorsi fremendo nelle ali / per alleggerirti la croce, toglierti col becco le spine, / l’intero creato più del resto degli uomini / si sarebbe ribellato». Così la malia che scroscia ad ogni angolo di queste pagine commuove e innamora: «Ci facevamo le tende lì sotto / nel prato dei peri secolari / a maggio le lucciole entravano e uscivano / più luminose dopo aver respirato / l’aria dei nostri sogni». È possibile parlar meglio d’amore, quello grande e diffuso a pioggia come da un nebulizzatore che affina l’aria che friccica dileguando?
Dileguando… come la vita che si spegne, un «viver ch’è un correre a la morte», dice Dante che si riaffaccia (dall’alto del 33° canto del Purgatorio) nell’epigrafe che dà inizio all’ultima sezione/migrazione, con la «sontuosa ritirata dell’inverno» che svela le ombre dei morti che si alzano, guardano, sostano prima di tornare tutti nella terra, la voglia di ripensare ancora una volta alla propria storia, un cicaleccio di ragazze che stempera, con il tempo che nuota a ritroso verso l’inizio: «Guarda come corrono inseparabili / i lampi di tutti i morti giovani / canti degli amori nel flusso luminoso / chiare radiazioni emerse dalla terra / semplici saluti prima di sparire, / credendo di rientrare a casa domattina». Cigni neri anche loro, spiriti che nascondono ferite tra le piume e dicono d’essere morti giovani tatuandosi lo stigma di una sacralità di natura che svaria tra candore e follia.
Ecco, allora, che il poeta ti insegna ad intonare l’occhio col tremore del cuore, perché i tuoi matti, anche quelli di cui non hai detto, riemergano ripuliti dal dolore che non dà tregua. E torna quel Matto che cantava portando l’annuncio del dissesto del mondo, la rottura dell’equilibrio, l’andatura sghemba, sì, forse quella goffa dell’albatro, all’uscita della scuola posizionata in quella che un tempo era la Piarda di Vicenza, oggi Piarda Fanton, una zona golenale che descrive il reticolo dei fiumi di una città e ne denuda un passato che sfasa lo sguardo. Era proprio lì, vicino alle acque, che trascorrevi anche tu, lì che indossando una giovinezza pungente hai ascoltato le prime avvisaglie di una parola che vibra stridendo, che è la follia inclusa nel verbo del poeta, puro come quello heaneiano o quello di Enrico Fraccacreta.