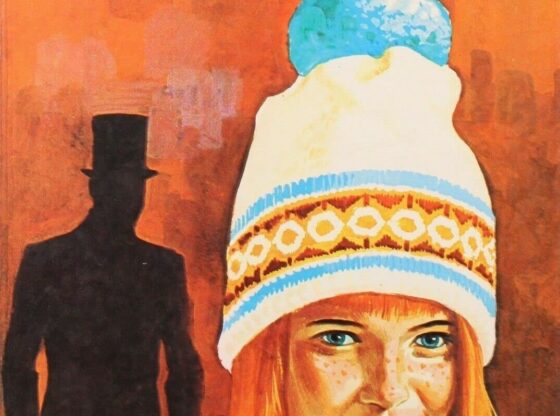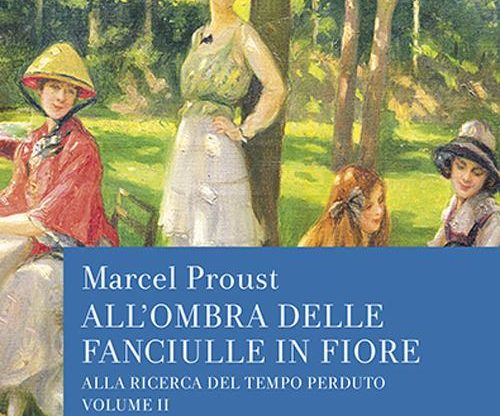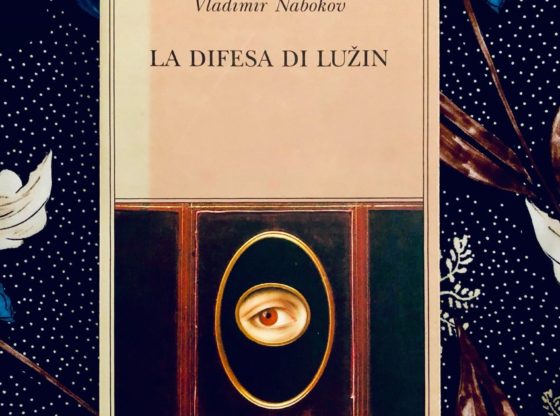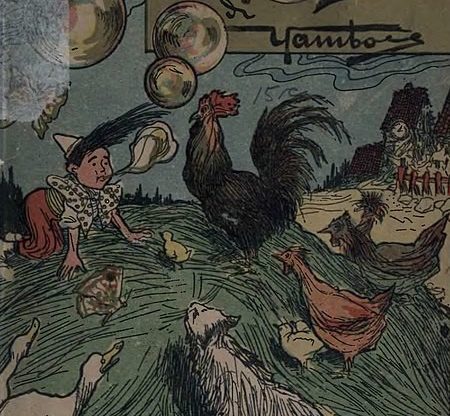Libera nos a Malo e il valore del dialetto come qualcosa di più di una lingua
Di Geraldine Meyer
Il valore della memoria, dei ricordi di luoghi e persone. Ma, soprattutto, ricordi di parole. Memoire, romanzo, saggio, tessitura di immagini che, a legame reciproco, hanno la relazione con il tempo che conserva e che muta, in quella che sembra una letteraria forma di preghiera che si snoda in un recinto di vocaboli. Preghiera che pare lode e imprecazione al contempo. Offrendo dunque, e forse, un significato al titolo stesso. Quel Libera nos a Malo che ricalca il Padre Nostro con cui, appunto, si chiede a Dio di liberarci da ogni male.
Ma quali sono i mali di Malo? E perché questo libro, uscito nel 1963, offre una lettura che può accompagnarci anche di questi tempi, suggerendo evocazioni e riflessioni feconde? Forse per ciò che mette in luce proprio insistendo sul dialetto e su come questo costruisca un legame inscindibile tra parole e cose. Tra cose che ci sembrano non potere essere dette in altro modo. Una elegia del tempo, dunque, che resiste a quelle inevitabili omologazioni (per quanto culturali e unificanti) di una lingua nazionale.
Scrive Cesare Segre nella prefazione dal titolo Libera nos a Malo. L’ora del dialetto: “Il dialetto, per Manganelli, s’identifica con la prima lingua che ha parlato; è insomma, la lingua. […] il dialetto è dunque la lingua naturale, quella della mamma, dei compagni di giochi; l’italiano è la lingua dei maestri e del potere. Ogni parola del dialetto vibra di sensazioni e ricordi, è qualcosa che si lega alla natura, alla vita, alla personalità, ai sentimenti.”
E lo stesso Manganelli, nelle note a conclusione, scrive: “Questo libro è scritto dall’interno di un mondo dove si parla una lingua che non si scrive, sono ragguagli di uno di Malo a quegli italiani che volessero sentirli; sono scritti, per forza, in italiano.”
Una centralità, dunque, data a qualcosa che viene scritto pur non potendosi scrivere. E si scrive non perché venga letta ma perché venga ascoltata. Ci sarebbe materiale per scrivere non uno ma più saggi solo su questo, invece ciò che qui si può, molto più modestamente fare, è riflettere su come tutto ciò abbia a che fare con quello che accade quando si perdono le parole, quando non si coltivano, siano esse in dialetto o in italiano: accade che si perdono le cose.
Se il dialetto è una sorta di identità, singola e sociale, personale e di comunità, anche ciò da esse evocato sarà legato all’identità. Ma non come un recinto chiuso, quanto, semmai, come una protezione, uno scrigno però da aprirsi e da cui attingere. Per questo Manganelli compie un’operazione di “trasporto” dal dialetto all’italiano; trasporto e non traduzione o riproduzione del dialetto stesso. E lo fa per poter raccontare ciò che, altrimenti, non potrebbe essere raccontato. Perché la sua lingua e la lingua di Malo “non si scrivono”.
E allora dove i motivi di interesse ancora oggi per questo libro? Proprio in questo partire da una parola-cosa per arrivare a un racconto che possa essere ascoltato da tutti. E che aiuti a comprendere come anche e soprattutto nelle parole, a partire da quelle, vi possa essere un gioco di potere: insegnanti su alunni, politici su cittadini, religione ridotta a catechismo sulle anime.
Il dialetto dunque, anche quando trasportato, come dice Manganelli, come possibilità di raccontare episodi e persone che, proprio grazie ad esso, diventano personaggi ma mai stereotipi. Raccontare luoghi di una provincia che diventano palcoscenico e non elogio di un esotismo inutile. Per non cadere nell’esotismo nemmeno quando Manganelli ricorda, e ci ricorda, come cose, persone e relazioni abbiano avuto un tempo in cui a contare era la durata, non la fretta e la frammentarietà. Ecco l’importanza di questo libro
 Libera nos a Malo
Libera nos a Malo
BUR Contemporanea
Letteratura
Rizzoli
2020
281 p., brossura