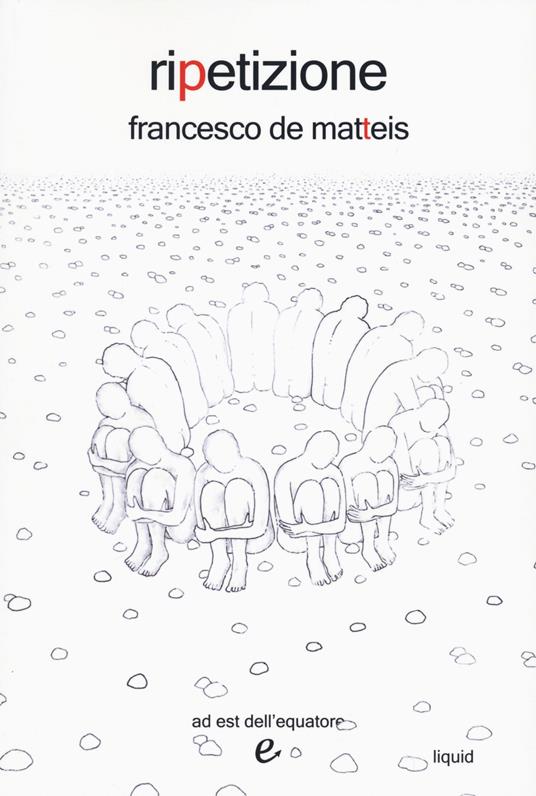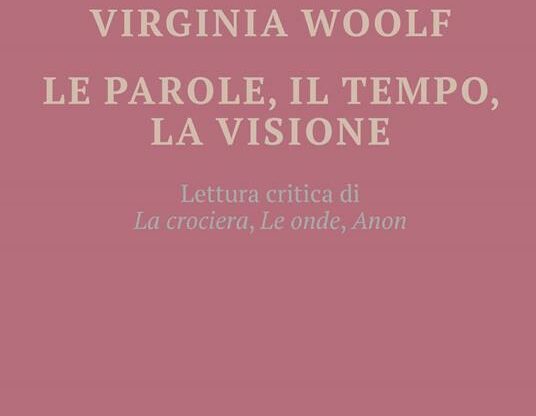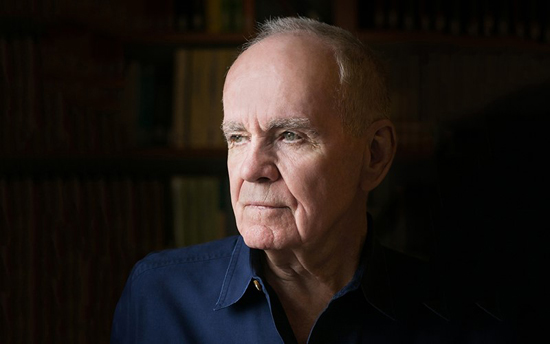Una Pan-oramica per Ripetizione
Di Rossella Pretto
È un invito a una critica letteraria brillante, leggera e serissima, penso guardando il Mercurio di Bertel Thorvaldsen al Museo di Copenhagen – un giovane dio colto nel doppio, paradossale movimento di vincere (e uccidere) il mostro dai mille occhi, Argo, incantandolo con la siringa. Sotto mano ho il libro di Paolo Lagazzi, ascoltato quest’estate alla villa Floridiana di Napoli in un incontro dell’elegante e briosa rassegna di Silvio Perrella. La raccolta di saggi e memorie di Lagazzi declina I volti di Hermes (Moretti e Vitali, 2023, pp. 192, euro 24) e quell’arte del sortilegio praticata nella scrittura e nella lettura per preservare la magia connaturata alla poesia e all’arte – in mente il saggio di Anita Seppilli, ma anche il librino di Roberto Mussapi. Spostando lo sguardo dal dio dell’alterità e delle soglie dello scultore danese, si incontra una lunetta che sbalza Pan nell’atto di insegnare a un bimbo dalle orecchie a punta a suonare quello stesso strumento, la siringa o flauto di Pan, che passa di padre in figlio, essendo Hermes genitore di Pan, dio che quest’anno campeggia per la terza volta sugli scaffali delle librerie.
Anche nel caso de Il grido di Pan di Matteo Nucci (Einaudi, 2023, pp. 192, euro 14,50), interessante è lo stimolo sotteso a una lettura diversa. Nucci ci guida nell’«orrido, ossia l’abisso», che è ciò «che è alle origini del vivente che noi siamo», doppiando una sfida per la sapienza che è una questione di vita o di morte, come sa Edipo di fronte alla Sfinge e come insegna il Minotauro gettato nel labirinto: «È necessario perdersi nel labirinto del nostro logos per scoprire il racconto, il mito, che in esso, dedalico e tortuoso, ci imprigiona per liberarci» scrive Nucci. Ma la liberazione si attende anche dall’atto di morire prima della morte, compiendo cioè un percorso di iniziazione a cui siamo guidati enigmaticamente dalla parola oscura e incantatoria del dio.
La morte è centrale.
Lo è l’esperienza della morte, così come la si prova, tutta aspettativa e proiezione tragica. A differenza degli animali, secondo Nucci che mira a evidenziare un sostrato che riemerge da un grido, quello di Pan e quello della terra devastata. Devastazione a cui hanno contribuito le scoperte mirabili e sconvolgenti del XX secolo che ci hanno introdotto al tramonto dell’uomo e del suo sistema di valori e credenze. Ma il paradigma del progresso infinito è alle corde.
Lo dimostra Benjamìn Labatut in Maniac (Adelphi, 2023, pp. 361, euro 20). Nel libro, c’è chi si suicida avendo intuito il baratro in cui le sue ricerche stanno gettando l’umanità (Paul Ehrenfest); chi soggiace alla sua mente geniale e senza requie non capendo che a un certo punto bisogna fermarsi, seppure ci si trovi davanti a sperimentazioni straordinarie, perché queste possono trasformarsi in strumenti di distruzione di massa (la parabola del progetto Manhattan che porta alla bomba atomica raccontata anche dal film di Nolan, Oppenheimer) e perché prima o poi arriverà la morte, anche per quella mente iper-lucida che tutto può (von Neumann). Il progresso infinito che descrive Labatut è poi quello che spinge un uomo al cospetto della macchina e dell’AI, una lotta senza quartiere che vede l’uomo sconfitto (Lee Sedol versus AlphaGo). Siamo agli sgoccioli.
E allora, per tornare a Nucci, bisogna abbandonarsi all’ora di Pan e destituire il mito moderno della produttività illimitata e del consumismo che fanno urlare il dio. «Se il grido del dio del tutto è il grido della natura» scrive Nucci «i sapienti antichi replicarono quel grido partorendo parole oscure, ma anche dirette nella loro allusività». Ma ecco che Nucci giunge a ciò che interessa: «Poiché la letteratura usa come strumenti sommi le parole, noi crediamo che sia l’arte meno capace di creare la possibilità di un’esperienza trasformativa e sapienziale. Ma la grande letteratura, da sempre, punta a omettere il centro del racconto perché le parole che usa sono strumenti per accompagnare di fronte a quel buio e lasciare che sia il lettore a immergervisi».
L’appello di Nucci e di Lagazzi a una letteratura ardita che accasi l’inquisizione del buio (o nietzschianamente l’abisso che ci interroga) sembra perciò perfetta per il libro di Francesco De Matteis, Ripetizione (Ad Est dell’Equatore, 2021, pp. 188, euro 14), non una novità editoriale ma una sorpresa, un piccolo capolavoro, una indagine tutta umana ai limiti dell’impossibile, dove la parola cade e l’uomo rimane in balia della propria impotenza, anche davanti al prodigio e a quello del nulla, così come accade nell’imponderabile meraviglia che si potrebbe creare stando sul bordo dell’orizzonte degli eventi. Conta il tentativo, comunque, insegna T.S. Eliot.
Ma partiamo dallo spirito da cui prende le mosse quest’opera, come risulta dalle intenzioni dell’autore: «Andare prima del pensiero, risalire all’impensato del proprio pensiero e, allo stesso tempo, oltrepassare il pensiero, nel tentativo, che fallisce, di rispondere a ciò che chiama da lì dove il pensato non può giungere. Nella ripetizione le parole smettono di essere le depositarie dell’esperienza e si manifesta ciò la cui natura più essenziale si rivela nell’impossibilità stessa del dire, nell’assenza della parola».
Diceva Lord Chandos che le parole si sfarinano in bocca come funghi marci. Non che siano abbandonate, certo. Il protagonista dell’opera di De Matteis le porta sempre con sé, porta cioè il libro di Sartre intitolato appunto Les Mots (molti sono i numi tutelari dell’autore, e Sartre è certamente tra questi), autobiografia in cui lo scrittore francese traccia il tempo dell’infanzia e la radice del futuro e dove il libro è universo e possibilità. Le parole di De Matteis servono quindi per strappare la rete che ci invischia e tornare all’origine, nel ventre caldo di una potenza. Viene in mente la statua del Disinganno di Francesco Queirolo nella Cappella Sansevero di Napoli, tempio di virtù e dimora filosofale concepito dalla straordinaria personalità di Raimondo di Sangro che, tra l’altro, dedicava la statua al padre, con il suo evidente significato iniziatico massonico.Le parole di De Matteis, al pari del percorso esoterico ordito dal Principe di Sansevero, sono chiavi, comunicano in superficie ma forzano una soglia che si occulta, grazie allo loro combinazione straniante e al cortocircuito tra modalità ‘iperraziocinante’ – quale quella del romanzo beckettiano, secondo Genette, che porta a un interrogarsi indefesso man mano che la scrittura procede – e attitudine da veggente con coloritura sapienziale – sfociante in alcuni virgolettati che giungono da un territorio di confine, quale quello sondato dal protagonista del libro. La trama è presto detta; conoscerla non toglierà nulla allo sbigottimento che De Matteis architetta per il lettore.
Protagonista è un ragazzo ormai uomo che giunge a una fortezza ai limiti del nulla, a proposito della quale il padre (un generale) ha sempre ascoltato avidamente i resoconti di quegli uomini (soldati semplici, ‘disperati e fortunati’) che, avendola raggiunta ed essendone tornati, sono stati in grado di sporgersi sull’indicibile e sull’impensabile traendone un racconto. Una formula. È, come dire, guardare in un pozzo, tra limo e radici, rimare per vedersi e rendere il buio echeggiante, parafrasando Seamus Heaney. Il ragazzo ormai uomo, però, non è mai stato ammesso nello studio del padre ad ascoltare quei racconti. La fortezza diventa quindi il destino scelto, luogo da cui riportare (nel movimento del tornare e dunque ripetere) un racconto che sia luce per illuminare il volto del padre e scongelare il rapporto aprendo l’azzurro di un abbraccio.
Leggiamo le prime righe:
Avevo lo sguardo rivolto al confine.
Al mattino, appena giunto alla fortezza dopo un viaggio durato un giorno e una notte interi, non ci avevo fatto caso. Poi fu sera, iniziai il mio primo turno di guardia ed ero lì e la fissavo.
Una sottile striscia di terra.
Un’invenzione tracciata a separare un deserto da un nulla.
Pensai di non essere pronto ad osservare ciò che mancava su entrambi i lati del confine. Fui certo, sin dal primo momento, di non conoscere parole in grado di dire quell’immobilità che mi invadeva gli occhi.
Il confine che osservavo attraverso la merlatura percorrendo, con passi che cadevano ad un ritmo privo di qualsiasi regolarità, il cammino di ronda, quel confine che osservavo era un pericolo. Un silenzio nudo.
Pensai “anche gli angeli perderebbero le ali in un luogo come questo.
Sentii l’attesa di quella prima notte come il mancare di ali perdute. Mi arrotolai una sigaretta e mi accovacciai. Una notte è lunga quando fuori da sé manca qualcosa da guardare.
Pensai “non c’è compagnia quando si è al limite”.
Non c’è compagnia in uno scavo tanto insidioso e inconsulto, se non due presenze altrettanto interroganti che condividono la ‘stanzacripta’ e qualche lemure, come questo che gli consegna un foglio: «Hai in mano una possibile irrealtà, disse il vecchio con voce stentata, come se stesse facendo uno sforzo o come se parlasse da lontano, da tanto lontano da non essere quasi più vivo». Un foglio che lumeggia un luogo-paradigma: «Come se fosse un luogo di un ritorno. Abbandonato da secoli si torna a calpestare. Tappeto di fiori rosso sangue, petali bianchi sporchi di vita. Come se fosse un luogo di una nascita mai avvenuta. Abortito dal mondo, perso in un universo di nulla. Mancano le possibilità che rendono la vita tale. Neppure la morte è all’orizzonte. Nessuna fine a fondare il tempo presente, a render possibile un futuro, reale un passato. Nessun termine per un tempo inesistente. Ciò che è già era, ciò che sarà è adesso».

La mente viene messa in scacco, come fu il processore di AlphaGo nell’unica partita di Go vinta da Lee Sedol, il quale improvvisò una mossa creativa e improbabile mandando in tilt la mente sintetica della macchina, o come ci riconosciamo leggendo certi passaggi di Cosmo di Gombrowicz, dove un linguaggio estraneo fatto di simboli e segni perturbanti trafigge noi e i protagonisti.
Al centro di Ripetizione, quindi, c’è l’oltre-pensiero, così come la morte. La morte del padre dell’io che compie l’indagine e che non arriva ad ascoltare il racconto per cui il figlio si è prodigato, e c’è il mistero inaggirabile che siamo. Vuoto immobile. Siamo gli uomini vuoti, ancora con Eliot. Perse le coordinate spazio-temporali, che l’autore continuamente shakera, consumate nella ripetizione che avviene tra la casa paterna e la fortezza, De Matteis mette in scena il tentativo di un uomo di rintracciare il senso – dell’esistere e del lutto nella sua infinita elaborazione – usando una parola appuntita nello sforzo tutto razionale di far luce sullo sprofondo, una parola che però diventa allucinatoria ed estremamente potente nel suo dirupo tellurico. Appunto «un’invenzione tracciata a separare un deserto da un nulla». Ed è così che Francesco De Matteis vince la sfida che il suo romanzo coraggiosissimo e mai convenzionale pone. Le parole di Nucci sulla grande letteratura che porta sull’orlo del buio diventano carne nella carne aspra di questo libro così autentico.