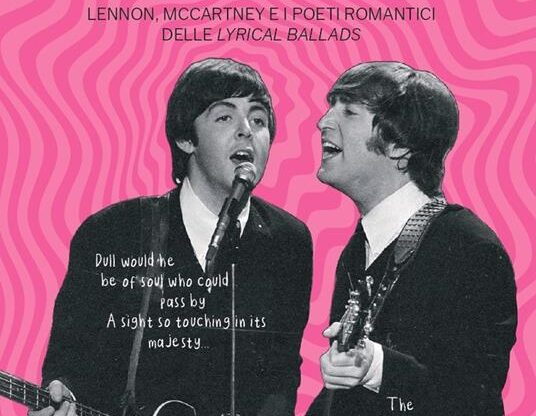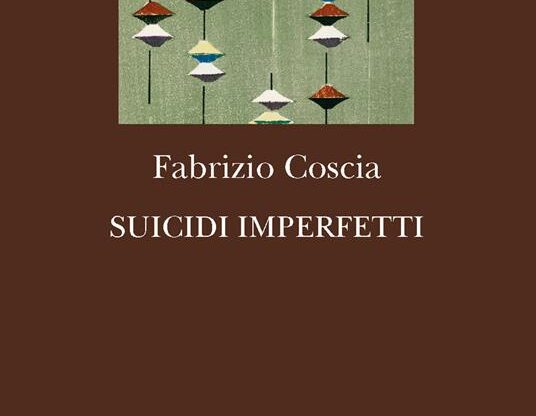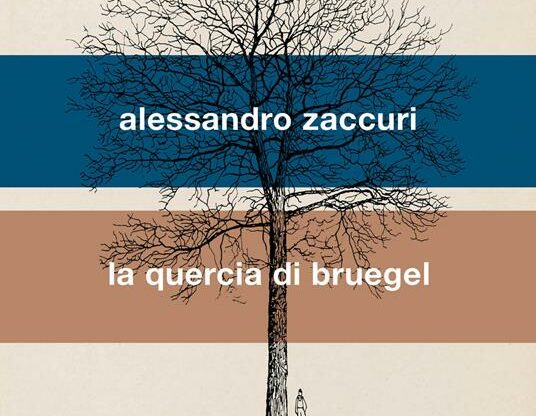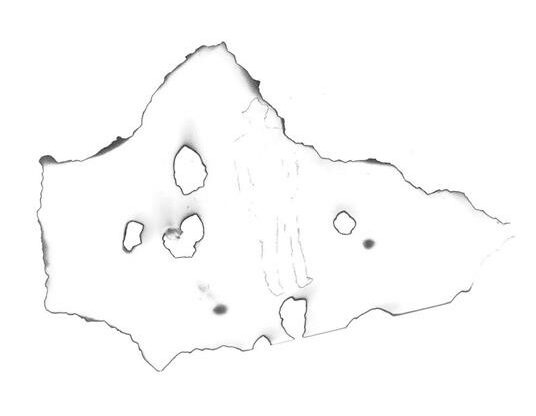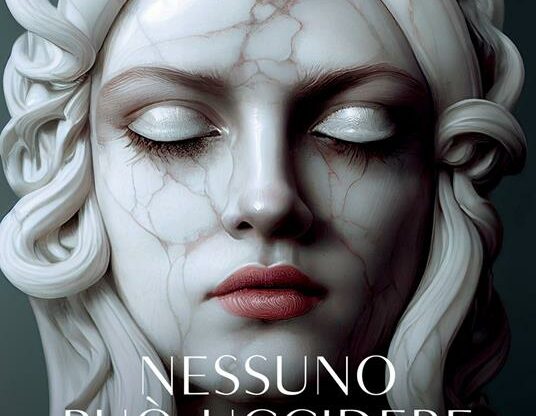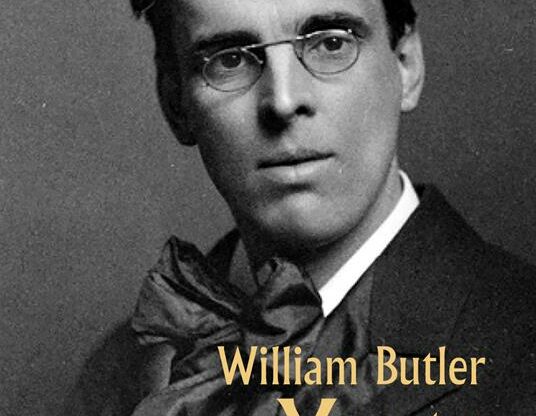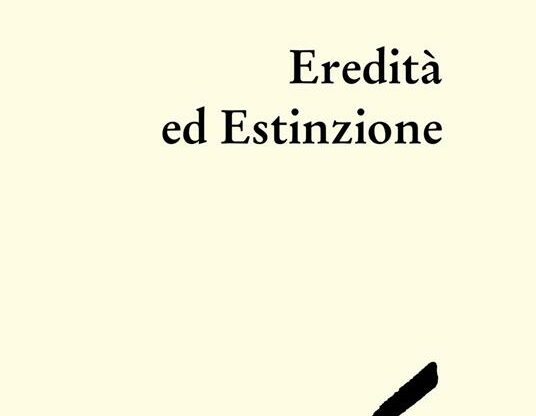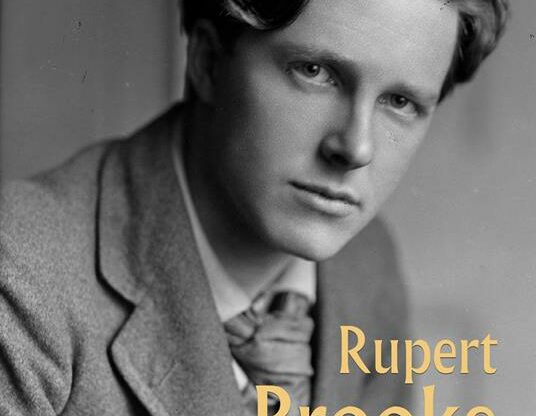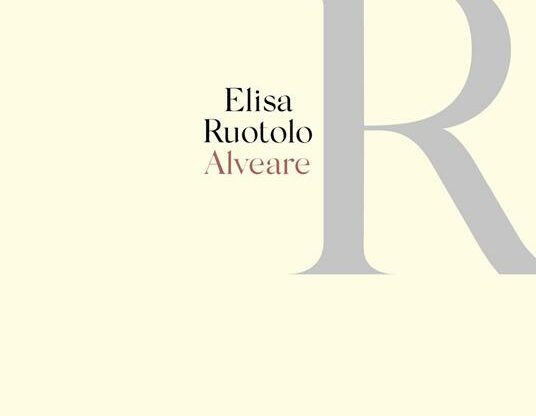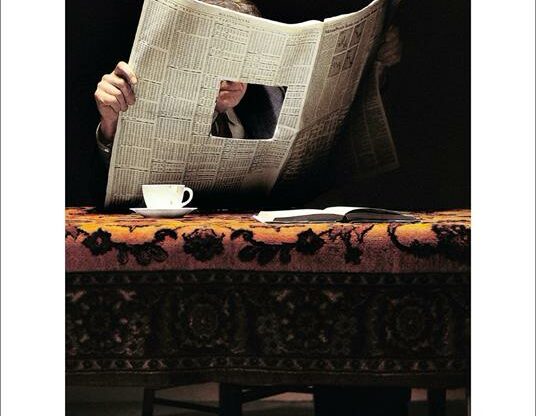I paradossi della campagna
Di Rossella Pretto
Avere un cane.
Non è solo la compagnia, non è, solo e soltanto, la lealtà che ti immagini.
È l’alieno che ti porti in casa, la bellezza di quell’estraneità. Bellezza nera, che ami da quando c’era il nero principe delle appartenenze. Ma ora devi ricostruire tutto daccapo perché tutto è nuovo con questo canino marziano dalle sette bellezze. Devi sbagliare e aprirti alle sfuriate del non capirci nulla. E all’avvilimento per ciò che non riesci, per quella comprensione che manca e mancando umilia.
Avere un cane, avere un animale implica farsi possedere e mortificare dal linguaggio. Che non basta, lo sai e lo sanno tutti. Quei soliti e famosi funghi che si sfarinano in bocca. Accedere alla comunicazione che si svincola e sfugge da tutte le parti. Anguillare. Come prenderla, è la domanda che continui a porti. Ed è da imbecilli. Ovvio. Perché non te ne accorgi? Eppure l’avevi detto così:
Ritrovare parole e giochi,
a volte solo giochi
che le parole non servono a nulla
se il linguaggio è difetto,
la forza stanca, gli occhi
opachi, il braccio inerte e la pazienza
non oltre il richiamo della
solitudine che invecchia
I giochi più non funzionano,
sei corda esausta
tesa allo spasimo e muto arco
Potessi essere stracci
di nuvole che passano, si potesse
continuare a rincorrersi per l’aria
quando invece devi mettere radici
Annusa foglia per sentiero,
il naso a terra, alto l’orecchio
come antenna che capta: impone mano,
la tua non più secca ma pronta
Solamente di’ ti ho trovato,
chiunque tu sia, combaciante e diverso
Ecco l’alieno che accompagna nei giri. Il tuo cane che ti mette sempre di fronte alla zoppia dei rapporti, asimmetrici e scombinati. Vedere attraverso le cose. Cercare i maestri dell’esperienza. Che in questo caso non sono i sodali e i simili. Al contrario. Sono i difformi. I nemici del quieto vivere e del dato certo. Vedere attraverso, una naturalità che specchia e spaura perché non ha quinta e perché non sarà mai comoda, piuttosto, metterà in scena o in causa il perturbante.
Ne ha pieni i polmoni, Eolo, dei petali dell’autunno
te li sbruffa addosso mentre passi accanto
alle muraglie di san Bastiano con cieli che forzano
gli occhi intorpiditi dai bianchi anticipatori
del gelo dei giorni scorsi
Turbini di foglie e un cane al fianco, o quasi, che tenti
di disciplinare ma ti insegna la trasparenza
dello sguardo e il tripudio per l’odore molesto:
una pista che fiuta Impara, dice,
e tu non ci fai caso ma dovresti perché
mentre gli urli qualcosa che non ascolta
le stagioni ti sgroppano addosso
E qui finisci con le tue parole e vedi attraverso. Vedere attraverso come fa Stefano Dal Bianco nel suo splendido Paradiso (Garzanti, 2024, 160 pp., euro 19) dove Tito, il cane Tito, fa proprio questo.
Mette in filigrana il meccanismo dell’esistere e lo testimonia, ne fa ragionamento o riflessione – proprio riflessione – e sostanza, materia sperimentata con l’adesione di chi vuole “Riconoscere il figlio”, formula dedicataria di una delle prime poesie della sezione ‘Paradiso’: è così, il cane Tito chiede che gli si tiri il sasso ma non se ne fa niente e continua a chiederlo a chi ha il braccio che gli duole e lo sguardo sempre addosso, e lo implora, lo implora di non guardarlo più così, di non ripore la sua fiducia cieca che lo inchioda a un ruolo tanto difficile da sopportare. Il punto è che Paradiso impone il mistero e insieme lo sguardo che indaga e delimita il campo dell’indagine, come la scena di un crimine inconcepibile perché non si riesce a ricostruire (in Twin Peaks, ricordi, non importa chi abbia ucciso Laura Palmer ma quale sia il meccanismo perturbante che innesca). E allora leggi dalla prima sezione ‘Appuntamento al buio’:
Agli occhi di nessuno manifesto
un segreto si è raccolto nel tramonto
che oggi in questo chiaro giorno
dispiega le sue nebbie di vendetta.
Ed è questo il paradosso nel bisogno assoluto di conoscere e nell’assoluto bisogno di andare per radici e sorgenti:
Ma di quale
accadimento si ragiona
se tutto ciò che accade da che mondo
è mondo accade all’ombra di un giardino
che nessuno di noi vorrà vedere mai?
Ciò che trascende rimane refrattario a farsi conoscere. L’azzardo, si sa, è sempre e solo quello, di provare quello: cercare per non trovare. Avere una falla nella chiglia, essere recipiente in perdita.
Sembra, poi, che nell’immobilità, che è lo stato contrario al movimento della vita, alla sua natura, si compia l’evento del linguaggio: «chi è fermo» scrive Dal Bianco «fonda un alfabeto / di buio e lampi, brevi nel silenzio», e allude all’apparenza delle stelle la cui luce, per la distanza, ci arriva in ritardo e dunque anche se morte. «C’è qualcosa in natura che si oppone / a tutto quanto scorre» afferma il poeta. E la vita è appunto questo arcano, la sua assurdità che gli viene alla mente in una «mattina quasi astratta» in cui pensa all’idea «di un nostro posto, qui,» come «un dolore calato dal cielo di piombo / che ci atterra e ci libera del tutto». Essere vivi, essere presenti nell’indistinto della natura o nel suo profumo – perché l’olfatto, per Dal Bianco, è debordante (come per il cane Tito, d’altronde) – in quel profumo di indistinto che intacca la memoria e, anche qui, la restituisce e la corrompe, con il duplice paradossale movimento che il poeta mette continuamente in causa. Perché la raccolta è costruita tutta, si regge su colonne di contrapposizioni (luce/buio, permanenza/caducità, moto/stasi, velocità/lentezza, silenzio/rumore…) e in quella frattura tra l’una e l’altra si accasa lo spazio di mistero da indagare per andare al fondo delle cose, alla loro inconoscibilità che si rende e si arrende e quindi diventa pienamente nel loro nascondimento. «Capire cosa filtra in mezzo ai tronchi delle querce / insieme col respiro naturale del vento / è come interpretare il sogno rotto / dei bambini immaginati dietro i tronchi / che dormono senza motivo / e forse neanche sanno di sognare». E torni per direttissima all’alieno, al volto nero di un’estraneità familiare che si rivela nella sua apparenza opaca. Quell’aria ferma è uno stare nel silenzio, luogo generativo del tutto, il «folle permanere», forse non «canto per intero», scrive Stefano Dal Bianco, ma la sua esistenza. E ricordi «l’eterna presenza dell’assenza» di Charles Wright, che non a caso è «dove tutto è immobile». Gli strumenti percettivi di Dal Bianco sono fondamentali (anche se il pensiero, la coscienza dominano) e i loro canali continuamente ripuliti perché c’è un attimo, arriva quel tempo in cui tutto parla la stessa lingua «e obbedisce alla maestà / del giorno che finisce / e non conosce ombra», quell’attimo che è «sospensione nell’insidia». E porta con sé anche il dubbio sull’illusione che deriva dai sensi. Ma la natura «inferocita e onnisciente» viene in soccorso (Dal Bianco parla apertamente di animismo), rispecchia (ma è sempre un movimento di scambio, dall’uno all’altro), permette «alla scossa di durare» e di mostrarsi per allusioni, allude all’anima del mondo. E il cane Tito ha il vantaggio di essere alla giusta altezza per essere ancora parte del respiro di quell’anima (tutto dipende dal punto di vista), mentre il suo padrone la domina «dall’alto della sua incostante umanità». Forse perché l’uomo ha paura della bellezza (come il poeta che non può aprire la finestra perché la rondine vuol fare il suo nido dentro casa e scrive che la bellezza «è una cosa che si guarda / ma non si può tenere dentro, perché sporca»). Oppure perché pensi, con McCarthy e la sua penultima fondamentale opera, Il passeggero, che «la bellezza ha il potere di suscitare un dolore inaccessibile ad altre tragedie. La perdita di una grande bellezza può mettere in ginocchio un’intera nazione». E sì, comprendi, che non è solo paura della bellezza, allora, è l’indistinzione a cui chiama – si è detto – il profumo dell’indistinzione che apre la memoria e la sprofonda. E dove finisce l’identificazione della pelle? Bisogna risalire, andare a ritroso, sfogliare gli strati del tempo senza farsi incastrare dalla posizione in cui si è implicati tra cielo e terra. Ecco allora ciò che urge – «Recuperare il contatto è affrancarsi dall’umano / perché non c’è niente di umano nell’umanità / o di tuo nel rumore del mondo che non sa». Recuperare il sacro, aprirsi all’incontro, entrare nel profumo, nel vento, nella pioggia, nel sole, nella luna e nel cielo, nel giorno che sorge o nella notte che cala accendendo le lucciole, nell’erba mossa dall’aria, nell’acqua che scorre, nella terra morbida e dura a seconda delle stagioni, nella storia delle foglie che è storia dell’uomo, si sa, nell’enigma allogato tra scapola e spina, «abitati dall’ombra».
Trasfórmati in parole luna piena rossa di gennaio
e includi nel racconto il rombo della superstrada
così che tutto sia completo
ma non risponda dei significati
così che quando uno arriva
a congiungere i punti delle luci nella valle
la figura sia libera
di assomigliare a chi la traccia
e il silenzio di dentro sia tale
da sovrastare ogni mania del mondo.
È questo che scrive Stefano Dal Bianco. Perché, forse, la verità – pensi – quella sua traccia delebile, si nasconde in ciò che residua, nel resto, in quell’abbandono di cose inservibili, nella resa o nella minutaglia. E allora approfitti per ricordare Giuseppe Marcenaro, da poco scomparso, e i suoi scarti che sono solo frammenti e non dunque il canto per intero di Dal Bianco, ma il suo alfabeto costruito per intermittenze, di buio e lampi appesi sul vuoto dissolutore.
 Paradiso
Paradiso
La biblioteca della spiga
Poesia
Garzanti
2024
160 p., brossura