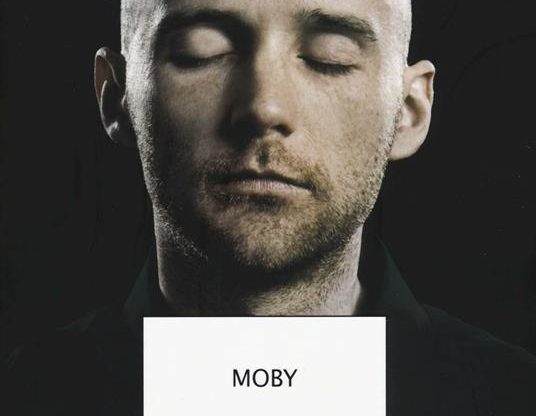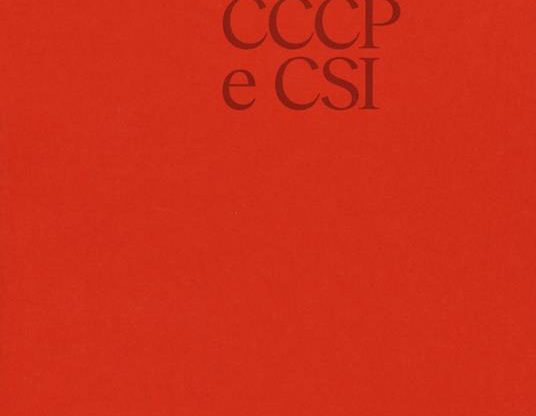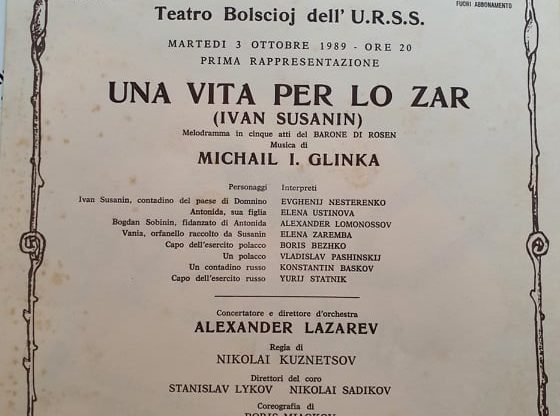A conferma del fatto che il 1979, e ci torneremo spesso, è stato sicuramente il miglior anno discografico per quantità e qualità, insieme al periodo 1966 – 1974 ed agli anni dal 1980 al 1988, soffermiamo la nostra attenzione su un album veramente scomodo, perché fortemente provocatorio e dissonante, “Y” del Pop Group, band inglese di Bristol fondata dal cantante Mark Stewart nel 1977. Fecero un altro album nel 1980 poi si sciolsero e, nel 2015, sono tornati col terzo album mentre nel 2016, ad ottobre, è uscito il loro quarto disco. Come si vede, una vita assai tribolata e fatta di una pausa che sembrava definitiva.
Facciamo subito una debita premessa che deve aiutare l’ascoltatore di quest’opera difficile ed arcigna: il disco è stato indicato come “pietra miliare” da tutte le riviste specializzate di rock ed altri suoni al mondo e tra i 600 dischi più importanti del secolo scorso. Intanto la band risultava maggiormente coinvolta dai suoni della scena black più radicale che dalle ultime vampate del punk, già trasformatosi in new wave. Quelli del Pop Group vanno ad incendiare letteralmente la musica del periodo con un fuoco “greco” divorante che abbrustolisce tutto quello che gli si avvicina nel periodo e non. Prodotto da Dennis Bovell, il disco è davvero pazzesco.
Si mette in narrazione musicale la tragedia umana, servendosi del free, del jazz, del free-jazz, dell’avanguardia ed anche del rock. L’alterità del disco è marchiata a fuoco dal funk mentre, tutti gli altri cercavano percorsi alternativi al rock. Sbuffo considerevole ad un approccio veramente tribale (come la copertina del disco indica chiaramente) ad una sorta di rivoluzione dell’impossibile che, vuole essere al tempo stesso modernissima ma contro la modernità intesa nei suoi aspetti più sterili e scontati. Il suono scardina qualsiasi cosa uno abbia in testa prima di far partire il lettore o la puntina del giradischi. Le chitarre sono unghie affilatissime che tagliano come rasoi senza compassione, i fiati hanno in sé il seme del jazz e del modo di suonare il sax che fu di Ornette Coleman, Albert Ayler ed Archie Shepp, quindi, iconoclastia allo stato puro, provocazione ed intelligenza ad oltranza e senza compromessi. Squarci, ferite aperte che danno da pensare a lungo. Essendo opera di musicisti, a quei tempi giovanissimi, non fa prigionieri, nel senso che è un disco più che ossessivo e feroce ma benedetto da una purezza che solo dal fuoco, come giustamente sostenevano i filosofi greci, può derivare. Non può essere immune da qualche ingenuità pseudo adolescenziale che gli si perdona facilmente per la qualità della proposta, unica pure ai giorni nostri, anzi, soprattutto nei giorni odierni fatti di scarso coraggio, inventiva ed immaginazione. Formazione: Gareth Sager chitarra ritmica e sassofoni, Bruce Smith batteria (pure coi PIL), Mark Stewart voce, John Waddington chitarra e Simon Underwood basso. Questo disco può essere configurato come una ferita per l’eternità, un allarme prolungato che non ha mai cessato di risuonare, un grido che esplode dalla cassa toracica con forza belluina in contrapposizione proprio alla violenza più belluina. 10 le selezioni del disco. Una in più sul cd, se lo trovate. La cosa impressionante è che, il disco, pur nella sua asprezza, riesce oggi molto più commestibile e quindi ancora più consigliabile. Il funk, col basso slappato (nel 1979 gli altri erano i PIL, col dub di Jah Wobble!) ti ubriaca in “She is beyond good and evil”, la ritmica gommosa ti schiaffeggia il cervello in “Thief of fire”, il pianismo folle e sconnesso di “Snowgirl” (splendida) resta a lungo in testa e li conferma grandissimi. La batteria di Smith è prodigiosa nella stralunata “Blood money” fatta di barbagli di suoni metallici. “We are time” (splendido titolo), parte con un basso pulsante ed innesta un qualcosa di vagamente rock vicino ad alcune cose che saranno dei Virgin Prunes. Molto bella nel suono delle chitarre. Voce sempre più pazzoide. “Savage sea” parte con un piano liquido ed una voce che è un sussurro, quasi paranoico, è di ghiaccio la prospettiva sonora così come gli intenti. “Words disobey me” è ancora funk come solo loro sapevano suonarlo, con basso e batteria splendidi. C’è quasi irrisione del prossimo in questo pezzo e ci sta tutta! “Don’t call me pain” parte sul suono del sax tenore e poi la voce la sovrasta. Bella, pulsante, unica nel suo sviluppo. Jazz della Madonna! “The boys from Brazil” è primordiale come i selvaggi della Papua Nuova Guinea in copertina. Primordiale orrore tribale e sconnesso. Bella nella sua voglia di avventura. Mi piace moltissimo. Infine, “Don’t sell your dreams” e loro non lo hanno mai fatto, chiude alla grande un disco che ci dimostra che “il vizio atavico” è dentro di noi e che incazzati così si può essere solo una volta nella vita. EPOCALE.
 Y
Y
Rock
1979