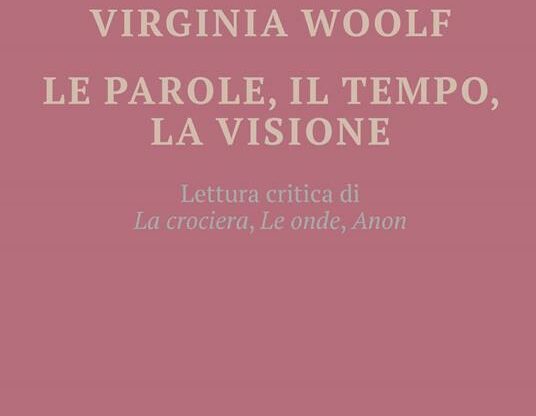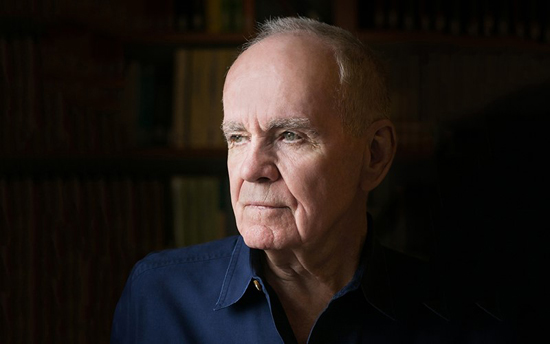Malerba, parole che resistono alla prova del fuoco
Di Simone Gambacorta
Luigi Malerba ha detto cose concrete pure quando ha dato voce ai sogni. È uno dei meriti di uno scrittore spericolato e sommo. Spericolato perché le sue storie toccano la campagna emiliana, la corte di Bisanzio, l’antica Cina, la Roma rinascimentale, l’Itaca di Ulisse e l’Italia repubblicana. Sommo perché quelle storie hanno immesso nella nostra letteratura un inconfondibile timbro stilistico, un modo di raccontare tanto più riconoscibile quanto più diversificato in una varietà di forme e registri.
Alla voce “cose concrete” vanno annoverate anche quelle osservazioni sulla scrittura che Malerba (nato a Berceto l’11 novembre 1927 e morto a Roma l’8 maggio 2008) ha disseminato in varie sedi e che potremmo definire “nascoste” o “poco evidenti”, cioè non dichiarate come quelle di Che vergogna scrivere. Ma che certi incisi e certi spunti siano stati proposti “sotto copertura” non deve indurre a supporne una minore utilità (Malerba conosceva bene i “consigli inutili” e si guardava dall’incapparvi).
I suoi sogni Malerba li ha registrati nel Diario di un sognatore (dal 30-31 dicembre del ’78 al 30-31 dicembre del ’79) e l’ha fatto riorganizzando l’opalescenza onirica in racconti brevissimi, secondo un principio (per nulla finnegansiano) di nitore formale improntato a una piena intelligibilità (il libro, pubblicato da Einaudi nel 2002, è stato di recente riproposto negli Oscar Mondadori in tandem con La composizione del sogno).
Nel leggere quei resoconti succede qualcosa che avviene puntualmente quando ci si confronta con le pagine di Malerba, siano esse romanzi, racconti o qualsiasi altra cosa abbia scritto: s’innesca un gioco sulla fascia, come in una partita di calcio. La cosa è vera in una duplicità di significati: sia perché quelle pagine le si empie a margine (con note, rimandi, appunti: Malerba è una continua sollecitazione), sia perché è dalla fascia che spesso partono quegli affondi malerbiani che sembrano nascere e finire lì e che invece sono parte integrante di uno schema di gioco sottile come i fili di seta di cui si parla all’inizio di un romanzo memorabile qual è Il fuoco greco.
Vediamo qualche caso concreto.
Nella trascrizione del sogno del 19-20 gennaio del ’79, Malerba parla delle «parole gonfiate dall’umidità» che «rischiano di andare a male». Sono parole che fanno pensare a quelle gonfiate dalle lacrime di certi romanzi caricati a suon di “dolore” e “commozione”, quelli struggenti, stipati di sentimenti e altamente tossici per via dell’ovvietà di cui sono vettori. È come se Malerba dicesse: fate attenzione, il dolore e la commozione, così facili da smerciare, sono la bassa macelleria del patetico e possono scatenare lacrimoni che finiscono per allagare una storia sino a renderne inservibili le parole.
Anche il racconto “Bakarak” (“Linus”, ottobre 1987) si muove sulla stessa linea e mette in guardia dallo scrivere troppe volte in un romanzo un sostantivo iperglicemico come “amore” e (per estensione) un verbo altrettanto diabetico come “amare”. Anche qui Malerba usa il sorriso come fosse un aereo di carta: sembra che il suo volo non dica nulla, ma non appena quell’aeroplanino lo si prende in mano, ci si accorge che il foglio dal quale è stato ricavato contiene informazioni come fosse il bugiardino di una medicina. Nel caso di “Bakarak”, il bugiardino recita qualcosa di semplice ed essenziale, a beneficio e profilassi degli aspiranti scrittori non meno che dei lettori desiderosi di non perdere tempo: non eccedete con il cuore, è dolce, fa ingrassare e – quel che è peggio – porta a involgarire una storia con le facili retoriche di un sentire obeso.
Per la verità, nel Diario di un sognatore le “parole” tornano spesso. Sono per esempio quelle che volano felici come «farfalle di colori diversi» (sogno del 27-28 ottobre) oppure quelle che «si reggono in aria per qualche secondo e poi si scompongono e cadono a terra» (29-30 dicembre; Malerba scrive anche: «Il sogno assomiglia alla pagina di un mio libro»).
Ma vi sono anche le parole infiammabili, le parole esplosive e le parole che non bruciano, un trittico racchiuso nel sogno della notte tra il 17 e il 18 ottobre 1979. «Avvicino un fiammifero acceso a una pagina sulla quale ho scritto con la macchina un certo numero di parole. Quelle infiammabili prendono fuoco subito e scompaiono in una nuvoletta di fumo. Altre parole esplodono con un colpo secco e anch’esse scompaiono. Altre non reagiscono al fuoco del fiammifero. (Non riesco a ricordare né le parole «infiammabili» né le altre scritte sulla pagina)».
Riecco una finta con cui Malerba apre improvvisamente sulla fascia. Resta da capire quale sia la sua manovra. Proviamo, allora, a fare i conti.
Quelle ignifughe sono le sole parole a non scomparire, dice il sogno, che confuta anche un luogo comune, perché né quelle di fuoco (incluse quelle di D’Annunzio, presente nel Diario come Carducci) né quelle che infiammano sono destinate a rivelare una forza interna. Come mai, allora, solo ad alcune parole è data la possibilità di sopravvivere alla “prova del fuoco”?
La risposta sta in un’idea di letteratura (siamo a un allargamento rispetto ai discorsi riferibili alla scrittura) che riassume in sé tutto Malerba: le parole che non bruciano sono quelle che resistono alla realtà, quelle che le disobbediscono. Sono quelle che non recitano il credo pedagogico della Storia e che non si muovono lungo le direttrici certe delle prospettive assiologiche.