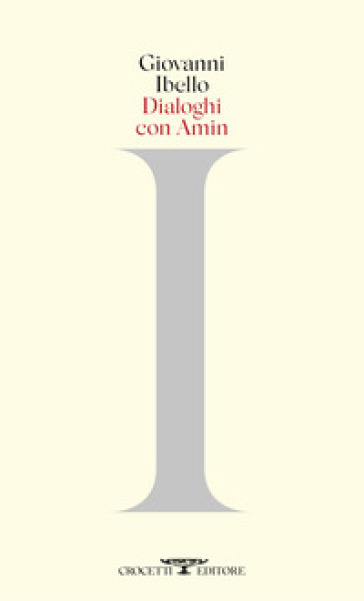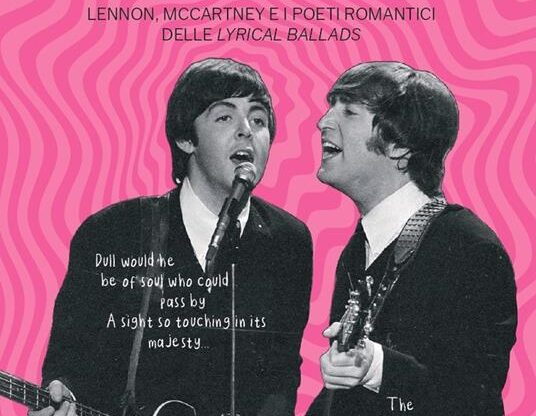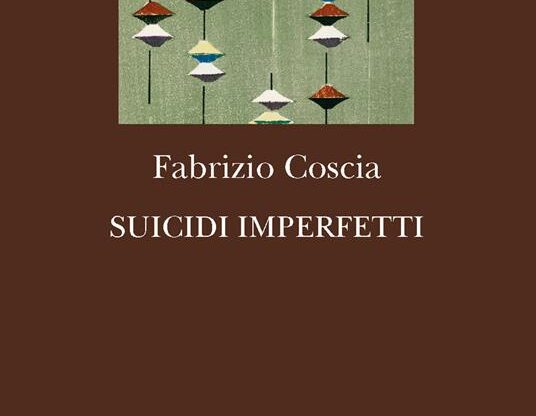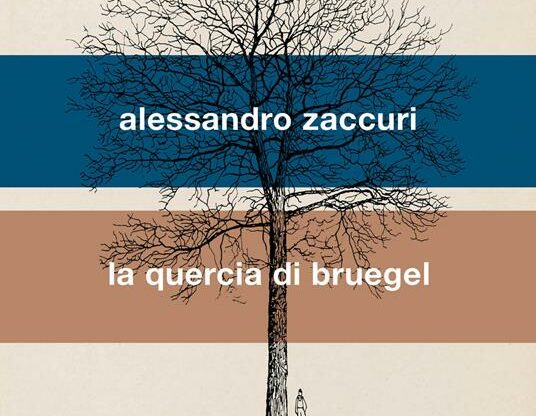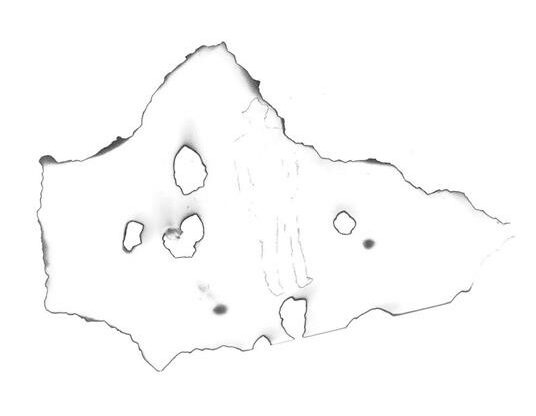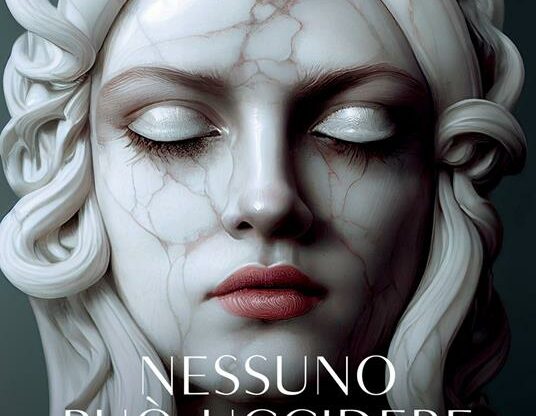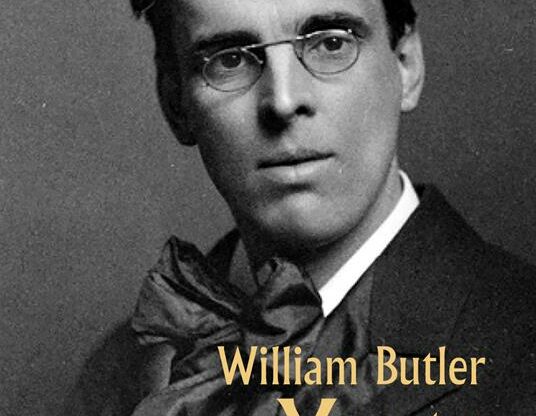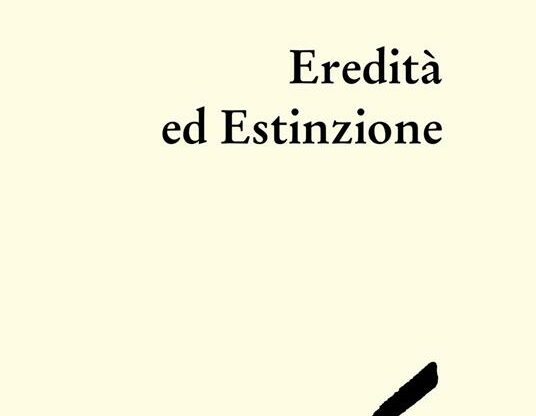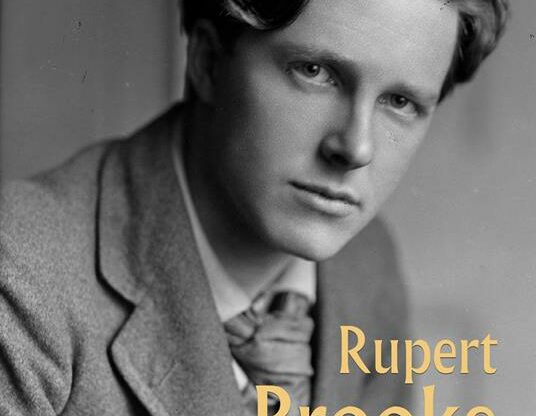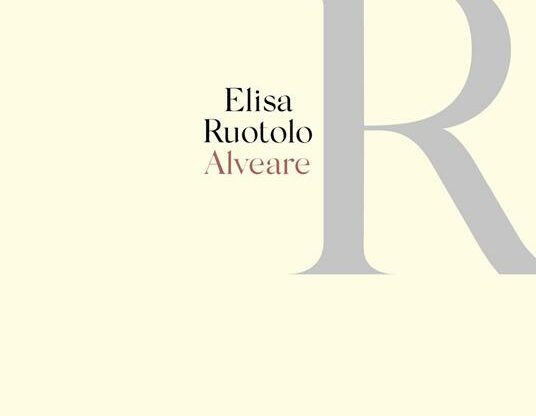Recalcitrante, lo confessi.
Di Rossella Pretto
Recalcitrante, lo confessi.
Perché dire di Giovanni Ibello pensando di dirlo in una rubrica intitolata alla bellezza associata a Vicenza, dove la speranza che quasi s’affacciava è già sfiorita nel tentativo di fare della cittadina turibolo di effluvio poetico (che sarebbe meglio dire preambolo a una terra scorbutica): ecco il rito che dovevi consumare, stiracchiato su un’alba pallida a mo’ di cellophane in trasparente asfissia sullo sfilacciamento delle ossa, il mugugno di Campo Marzo pompato da cartacce e siringhe (di eroina neanche l’ombra, semmai tracce di alluminio bruciacchiato o ciucciate fette di limone) – e non ci puoi fare niente (se non sotto elezioni, ça va sans dire).
Lanci anatemi che non scalfiscono la cappa smorta della città, tra slombati veneti ghirigori o il nitore delle infinite fughe prospettiche sollevate in un’allegria di pastelli, come piccioni lanciati sulla piazza, il velo di guano un verde prato e bancarelle ovunque. E via di giostre e street food. Fossero almeno carovane del deserto forse avresti cominciato prima a dire di un libro denso e straordinario come i Dialoghi con Amin (Crocetti 2022)… ma no, nessuna carovana del deserto, qui dove sei, solo decoro e zingaraggio a braccetto su una ininterrotta distesa di banchi come panem et circenses a intrattenere il vicentino (e che metta mano al portafoglio, mi raccomando, dandogli di replay come non ci fosse un domani). Repetita iuvant, dicevano i latini, talvolta di cose piacevoli, altre come ammonimento.
Ma qui si tratta di piegare la testa, così come a Vicienzo Gemito il maestro Caggiano faceva ripetere sempre ‘e ‘rrecchie e non gli ‘mparava mai a fare i lioni, in quel romanzo ardente, purosangue, di Wanda Marasco, Il genio dell’abbandono. Ma l’intento, lì, era altro. E certo, lo sai anche tu che Napoli può ferirti a morte, ma che c’entra, lo scrive pure Perrella di quella sua vocazione alla maschera, la grande recita, l’uscita dalla Storia, che egli, sulla scorta di La Capria, imputa alla fallita rivoluzione del 1799, quando la piccola borghesia con fare pitonesco iniziò la lunga digestione della plebe napoletana suonando il flauto suadente del dialetto e recitando ciò che non era più, culminante nel punto di non ritorno del ’45… città ammalata di malussìa, «una sorta di saudade, dove il naufragio e la bellezza si mescolano e il tempo prende una forma tutta sua», leggi tra le righe di Giùnapoli.
Ma comunque cominci a pensare che Napoli è anche questa di Ibello (che finalmente si affaccia):
C’era l’immagine di Maradona
sopra un muro di cemento
ma l’arco degli occhi era sporcato
da brandelli di manifesti mortuari:
oscillavano nel vento
mentre un odore di marijuana
si diramava oltre le case popolari.
Maradona era solo contro gli inglesi,
l’anatema del numero dieci.
Con una mano cercava la palla
con l’altra stringeva nel pugno
una radice di gramigna
che sporgeva da una crepa,
fino a quando una donna
decise di estirparla
con un gesto solo, risoluto, che diceva:
“L’amore perduto non ritorna”.
E il punto è che, per via di suggestioni e associazioni, da Napoli a Perrella arrivi fino a Parise, e dunque di nuovo a Vicenza (solo per qualche altra parola), perché più volte hai sentito dire a Perrella che Goffredo era nato a Vicenza ma rinato a Venezia. Si capisce perché. E di ritorno si chiude il cerchio. Tu il ritorno laddove tutto è accaduto e continua ad accadere, alla De Angelis (che di Ibello ha grande stima e si capisce), quel ritorno l’hai fatto, per te è come un mantra che rintrona lo stomaco attorcigliato a dire: no, ho dato e ridato… e allora facciamo che ritorno è dove tutto prende il largo, che si possa tornare ad andarsene e accettare di essere stranieri. Esserlo a Vicenza, prima di tutto, dove, tolto il pavé, l’hanno sostituito con una colata rossa di asfalto – proprio rossa come la critica alle luci natalizie di quel tale colpevole di gaiezza e stravaganza – un tappeto steso fino ad arrivare a san Paolo da cui puoi ammirare il ponte di pietra, la bella vista di san Michele, di fianco al quale Neri Pozza era di casa, ma della casa editrice, oggi, non è rimasto nulla (a esclusione di una rappresentanza fake), ora che il declino qui è certo a confermare la vocazione alla fuga, ad andarsene per campi (e sarebbe meglio in camporella) fino a giungere in un luogo qualsiasi purché non qui, a spopolarla delle cose migliori, la città. E comunque, sempre in Giùnapoli leggi, cosa che ti sembra calzare alla perfezione: «Quando la storia di una città si blocca, ne viene coinvolto anche il destino dei singoli individui. […] La città deve essere connessa nella mente degli individui; bisogna saper trovare i tronconi e metterli insieme. Poche città richiedono un tale lavoro mentale e immaginativo. E solo se si è disposti a compierlo ogni giorno è possibile provare a salvarsi dai vicoli ciechi».
Pensi a questo mentre stai ebete a guardare verso san Michele, e se ti volti di spalle e in direzione contraria scovi invece il retro di Palazzo Pigafetta, che in facciata reca la scritta non c’è rosa senza spina (e l’abbiamo capito)… il palazzo, la casa di chi andava, che non ti smuove più dall’idea che vuoi solo farti uccello che sa l’emigrazione, tracciare la rotta per scoprire altro e altrove, e smetterla, finalmente, con l’ombelico – questo vogliono: storia o storiella e sapere se sei fratello o marito o figlia e raccontare quello, proprio la storiella e possibilmente senza stile perché nel piattume ci si riconosce tutti uguali – e tutti rimbecilliti e bestie, uomo/donna-bestia che non si eleva-per-carità per restare nel ventre della folla che rumina e tutto appoltiglia, scrivere per dire di essersi impadroniti di tutto, fagocitandolo, anche le lettere e l’ordinato o caotico ma titanico dispiegarsi delle parole sul pentagramma del senso tentato, scrivere la propria storiella non per dire altro e universale ma proprio l’ombelico con chinata di capa condita di inchino finale e tenchiù. Ecco perché nessuna genuflessione è dovuta, ma il grazie sì, e per Amin (e qui si allarga il polmone, era quasi in apnea), il grazie per il genio di Amin che risacralizza la disappartenenza, quella sacca o budello vibrante che sa di selvatico di uno straniero che storce l’occhio e rifiuta la connivenza, ma tutto piomba nell’attesa, come scrive De Angelis nella sua introduzione al libro. Il poema dell’imminenza, lo chiama, che sobilla ciò che nella tenebra aspetta pronto a lanciare il suo artiglio all’attacco di una visione di superficie che cela l’occhio sbarrato. Domani nella battaglia pensa a me, è lo spettro che inquieta, quello che parla d’altro e disloca i ginocchi di chi non trema e sa farsi beffe della bellezza di natura o di chi può trovarsi intimo tra le lenzuola con una sconosciuta che muore. In Shakespeare e Marias. Tanto per dire dell’ombra che tenta il giorno o scuce l’alba. E si fa eccesso che custodisce il cuore nero delle cose, perché dove è eccesso vi è visione e ustione, stigmate, e il sacro brucia orizzonti cercando le vene. La calma, allora, sa di benzodiazepine, che sono la materia del sole, mentre il silenzio dello zenit si installa in un paesaggio di incendi e deserti, dove le arance esplodono come fiotti di sangue e le notti vengono accerchiate da canicole e antenne.
Ci lega la parola feroce,
una giostra di penombre.
L’incanto di una teleferica,
l’esatto perimetro di un grido.
In questo perimetro surreale, tra la distorsione dell’incubo, il suppurare dell’universo collidente e in perenne mutazione, la Napoli di Maradona-il-mai-redento e il miraggio gassoso delle ziqqurat, ci si può scornare con l’assoluto, quel dio anatema il cui cifrario è fatto di fiori di tarassaco sulle rotaie, abbandono e arsura, forse una lacrima corrosiva, lì dove a fiumi scorrono millimetri di oblii, addii, acquavite e sangue: un tributo, quando l’unico possibile rito è lo smisurato addio – questo addio lunghissimo, forse perché le cose stentano ad assentarsi ma non ne possono fare a meno. Ecco perché dovevi puntare i piedi, renitente. Perché per calpestare la soglia e oltrepassarla urge l’addio, con tutto il tremore e l’urlo. Non avviarti docile in quella buonanotte, diceva Dylan Thomas, lo sai, non puoi dimenticarlo. Bisogna dichiarare guerra al creato, a tutto il troppo che infarta e fatale:
Dichiaro guerra al cielo:
dove sei, dove sei…
dio del fiore nero.
Troppo, troppo davvero. E l’amore?
Credi seriamente che questa di Ibello sia un’indagine sull’amore, nonostante le apparenze contrarie: «Io sono Amin / e non ho mai conosciuto l’amore», oppure «Io sono Giovanni / e non ho mai chiesto di essere amato». E contrarie perché non è l’amore a cuoricini di cui si parla né quello rassicurante e morbido, ma la misura del tremendo:
Non so cosa amo,
ma so cosa feconda il mio verso:
fare del corpo la misura del tremendo.
Non mancare
questo appuntamento/ con l’osceno,
l’uomo che si dispera sopra i seni.
Dunque, non un amore (una vita, una morte/rinascita) in particolare, o personale, come scrive anche De Angelis, ma quello il cui ordito permette la tramatura del tutto, il desiderio atroce della testimonianza che arde su un picco calvo mentre cielo e suolo si amano a schifìo o l’orizzonte si infoia di crolli. «“Ogni cosa rivela/ quel nulla che siamo già stati”. Qui non si parla solo di noi», scrive De Angelis, «non si parla solo della nostra brama di amore e di felicità. C’è in gioco in questi versi un mutamento sterminato, un dialogo amoroso tra le potenze della natura, qualcosa di remoto che non ci ha mai sfiorati e insieme qualcosa di vicinissimo che abita nel nostro seme».
L’amore è il residuo scandaloso, il conto che non torna, la carcassa di un corpo che ancora anela alla penetrazione, il putrefarsi della bellezza e lo schianto di un mondo che ammala, tanto è stordente e occultato nello scolo dell’esistenza che implode.
Di quello che sognavi veramente
non resta che un silenzio siderale
una lenta recessione delle stelle
in pozzanghere e filamenti d’oro.
E il riverbero delle sirene accese
sui muri crepati delle case.
Così dormi, non vedi e manchi
il teatro spaziale delle ombre.
Il desiderio è l’ultimo discanto.
Ma quanti gatti si amano di notte
mentre l’acqua scanala nelle fogne.
L’amore è anche tutto il coraggio necessario a compiere il gesto assoluto, ogni istante trafitto:
Amin, avrai una sola occasione,
una sola freccia da scagliare controsole.
Seleziona con cura
l’abisso entro cui implodere.
Solo così, forse…
Verrà la vergine dei falò
verrà la vergine dai seni ulcerati,
un altrove di baci
al kerosene
un altrove di spine e diademi.
Ma noi
dimenticati relitti
ci amiamo nel buio degli hangar
e ripetiamo giaculatorie
dinanzi a un dio demente
che scalcia
nel grembo della cancellazione.
Ecco, allora, l’amore è la misura del fallimento, la smorfia che possiamo trarne, lo sgomento, ma senza arretrare e anzi spalancando il petto come a dimostrare quanto sia fondo quello stupore che incendia i pori e gela la vita che tenta di sottrarsi alla luce sbranata dal buio dei miracoli (interdetti o forse no).
perché ogni
cosa si annuncia solo mentre si sfigura.
E vorresti pensare a tanta di questa incandescenza evidente solo per via di estinzione, installata nel chiodo del silenzio, perché bisogna essere tangenti al silenzio, mentre la parola di Amin è l’inganno (sapienziale e originario) che in qualche modo assomiglia alla Loggia Nera di Twin Peaks dove, non a caso, la parola è straniera e incomprendibile: lì si incontrano mostri e deformi, è il regno della paura da cui partorire l’impossibile e tutta intera la materia dei sogni, basta perdersi.
Se vuoi arrivare alla lacerazione
non dire una parola
che sia una.
C’è un piccolo spiraglio di umano che sa di latrato, di quella lotta da storditi, delle amnesie lunari, delle corse a perdifiato e dello sciupìo del crollo ma nessuna consolazione, nessuna remissione, tantomeno dei peccati:
Poi il respiro si risolve
in un orgasmo neuronale,
è come un’implosione di pianeti nella mente
una turbativa siderale
del corpo che ritorna seme.
Tornare seme, vagando su e giù per il viale della creazione, dall’origine alla fine e viceversa, per sondare il mistero fondo, come i poeti bravi e coraggiosi che non temono di rimettere a noi la visione (non la pace ma la spada) e non cercano l’unghia incarnita del presente affondando le mani e gli snodi dei polsi nell’acquaio dei piatti da rigovernare; una linea di giovani (di varie età) che innervano il panorama italiano, tra cui Alessandro Rivali, Alessandro Bellasio e Mattia Tarantino, per non dire di Laura Di Corcia e Giorgiomaria Cornelio – e fai solo alcuni nomi tanto per attirarti gli strali degli uni che si vedono accostati e degli altri che non si vedono e basta. Ma amen. Almeno ci sarà qualcosa da fare mentre qui tutto sembra affogato nel suo immobilismo beota e neanche un ago tra l’erba incolta può mostrare la scala per le regioni infernali, tutto rimane appeso nella condanna siderale all’occhio che vede solo appena al di là delle tendine di tulle. Ecco perché ci vuole aria da respirare, non la cappa limbica anticamera della lobotomia, aria e mare a cavalloni per squinternare il pensiero al mentolo che si è fatto ingioiare al drago e tornare santi a farsi trafiggere nella terra del fuoco.