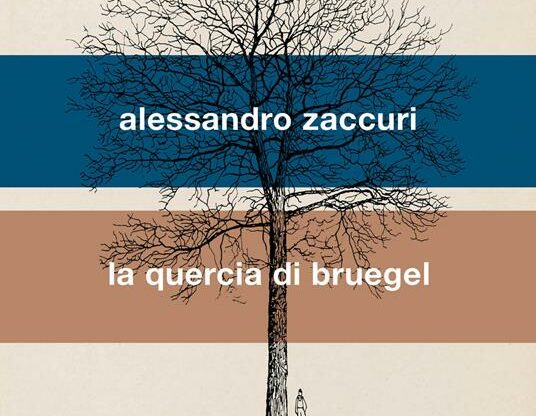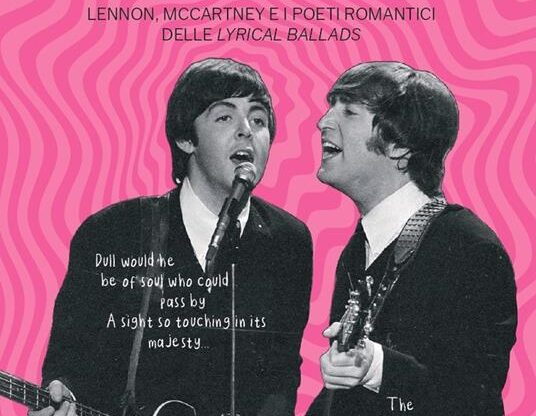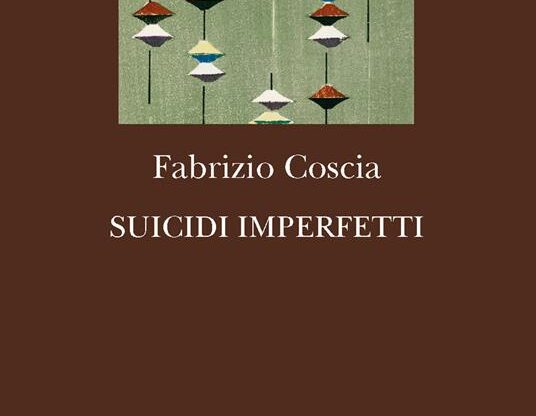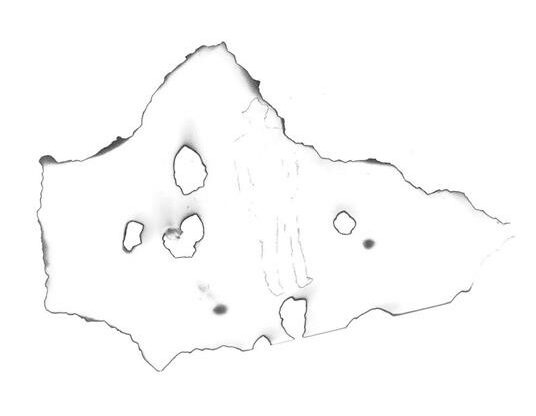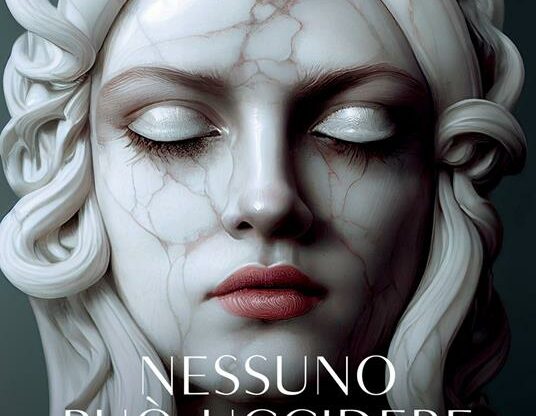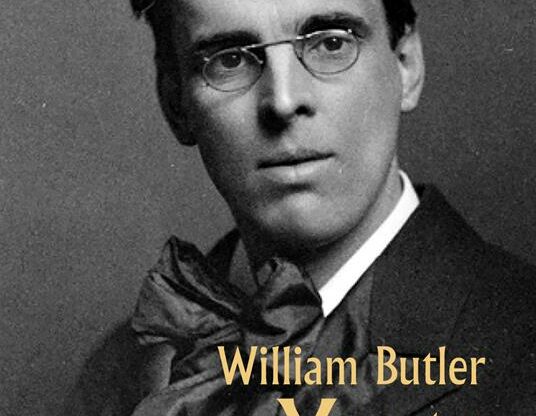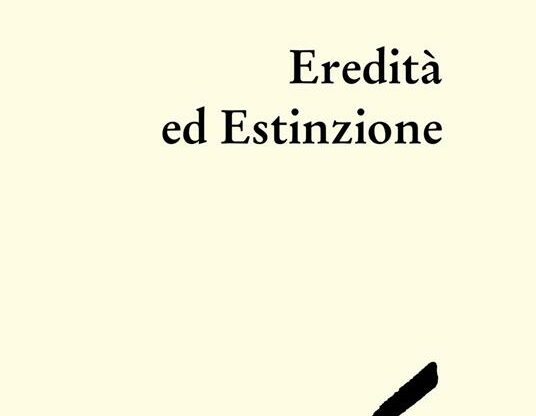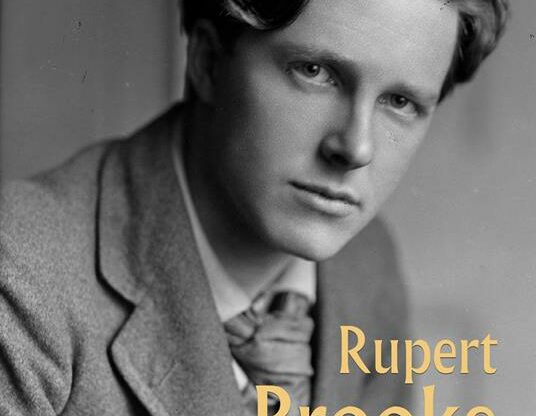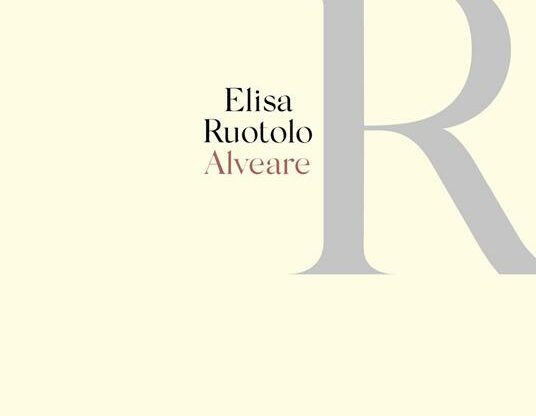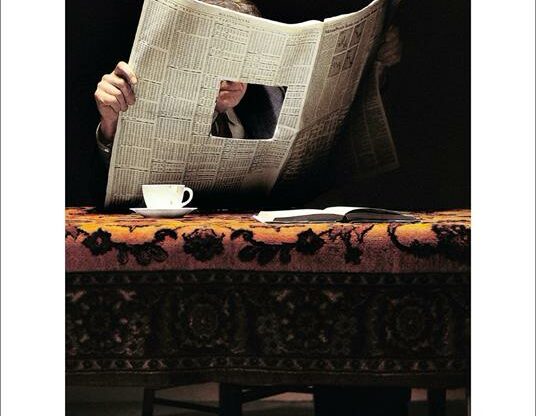Del vedere – arte e mondo in Zaccuri e Baravelli
Di Rossella Pretto
Capita, talvolta, di dover attendere indefinitamente.
Solo questo, perché le reti con cui si fa pesca nel mondo si colmino.
Tocca lasciar la sciabica strascicare torpida tra le acque e disporsi a sbrigliare il tempo. Fino a che le due ali di pescatori addetti a raccogliere il frutto della notte non si siano avvicinate compiendo – ecco, tutto d’un tratto – il miracolo dell’abbondanza che dà senso al rito, al gesto tout court.
È capitato anche a te che hai apparentemente permesso che il tesoro custodito da un racconto di Alessandro Zaccuri si sprecasse per poi ripescarlo molto oltre.
Leggendo il recentissimo Il mondo non merita la fine del mondo (Rizzoli, 2024, pp. 224, euro 24,90), libro di Maria Vittoria Baravelli (ammaliante come la sua voce roca e sottile, con quella giusta vena di languore che incanta), hai capito che era giunto il momento di parlare anche del romanzo di Zaccuri, La quercia di Brueghel, edito da Aboca Edizioni nella bella collana de “Il bosco degli scrittori! (2021, pp. 168, euro 15). L’hai capito sentendoti porosa alle prime parole che Baravelli scocca per chiedersi che cosa, di un’opera, colpisca.
«L’arte mi ferisce e mi seduce» è la risposta.
Esattamente ciò che hanno fatto con te – sia lei che Zaccuri.
Se l’opera cuce un dialogo intimo con l’osservatore e gli permette non solo di inquadrare una porzione di realtà perché questa acquisti un valore assoluto risultandone non di meno straniata, ma gli permette anche di sospettare quella potenza misteriosa e inattingibile che il linguaggio sfiora non riuscendo mai ad accasarla (se non in una traduzione imperfetta, sghemba, allusiva), allora ferita e seduzione saranno tali che la lettura del mondo ne risulterà amplificata, come se tutti i sensi collaborassero spalancati ad attingere un frammento – minuscola calia d’oro, residuale ma irrinunciabile.
È questo che Baravelli propone, accostando parole e immagini, nel suo discorso denso e affabulante: «Da sempre gli oggetti sono sentinelle che ci aiutano a raccontare quello che abbiamo da dire. Potenziano il nostro senso di esistenza. La dilatano».
Così succede ne La quercia di Brueghel.
Uno scrittore che, sotto pseudonimo, congegna biografie di artisti famosi (cioè si occupa, nel tempo del romanzo, di quella di Pieter Brueghel e dei figli), in un albergo di Bruxelles si imbatte in Matilde, la neuropsichiatra impegnata a studiare il caso di un paziente che soffre di un disturbo della percezione. La cornice profila la storia tra due grandi eventi e due luoghi diversi: l’attentato nella città belga del 2016 e, a Milano, la pandemia del 2020. Nel fuori si annida il pericolo di un reale che bussa alle porte con la sua carica annichilente. Bisognerà allora ritrovare strumenti che facciano da bussola. Nel dentro. E ricreando un setting.
Matilde la cerca attraverso una “cura delle immagini”, potresti dire, ossia sottopone all’occhio del paziente riproduzioni di quadri famosi per tentare di decodificare il suo nuovo (e strano) alfabeto.
Solo Brueghel suscita l’interesse di Massimo. Di lui soltanto Massimo vede dei particolari: gli alberi – alcuni alberi: defilati, sbilenchi, intricati.
È un cifrario.
Materia per scrittori e artisti che presentano al fruitore della loro opera l’enigma di una visione tutta da conquistare, suggeriscono l’esempio guida per la caccia a ciò che esponendosi si nasconde e celandosi si rivela. «Ma non datevi il disturbo di distinguere tra l’alba dei fatti e il crepuscolo dell’invenzione» sussurra Zaccuri (e sempre tornano in mente le menzogne esiodee simili al vero), e continua: «Semmai, ascoltate questa storia come ascoltereste una canzone di cui qualche parola è stata dimenticata, ma si è tramandata la melodia».
Non ricordi Marias, quando scrive che ciò che rimane è solo un canto fatto a mezza bocca?
Sì, anche per altri motivi. Non ultimo quello dell’ambientazione della vicenda in un albergo dove transita un’umanità storta ed esposta, quella de L’uomo sentimentale.
La traccia, ancora una volta, va snidata nel difetto, nell’inciampo, nel graffio che addita la ferita. «Ogni errore rivela qualcosa del quadro complessivo» scrive Zaccuri. E poi: «Avessi seguito il mio istinto e le mie convinzioni, avrei proclamato che l’unica maniera per dimostrarsi fedeli al significato di un’esistenza consiste non nel ricalcarne i contorni […] ma nell’individuare il nucleo, il centro, la ferita da cui tutto ha origine, e poi stravolgere le cronologie, differire gli eventi, travisare le situazioni pur di costringere quella vita a confessare la propria pena».
È ciò che credi anche tu. Perché si parte sempre dalla necessità di confessare.
E forse tutto, o buona parte del discorso, inizia da qui: «Qualcuno doveva aver diffamato Josef K. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato».
Non c’è scampo. L’unica cosa che K può fare è confessare.
Cosa?
Semplicemente confessare.
Nello specifico de La quercia di Brueghel, basta confessare ciò che si vede, perché è in tale atto che l’essere umano si dimostra nella sua imperfezione e singolarità, aderente alla propria natura e capace di comprovarne l’eccedenza.
Ma che cosa attesta Massimo, il neuroatipico che ne L’Adorazione dei Magi nella neve di Brueghel vede solo un frammento d’albero che pare quasi un refuso?
È in quella gratuità del gesto d’artista in grado di prendersi libertà creativa e compositiva che bisogna ricercare la chiave d’accesso alla sua mente. È nella marginalità di un dettaglio che si troverà, forse, l’unica via per andare al di là dell’apparenza.
Brueghel il Vecchio è maestro dei dettagli, pittore cardine della nostra modernità che spesso condanna il centro della storia ai bordi (uno dei quadri per tutti: La caduta di Icaro che Auden, in Muséé des Beaux-Arts, commenta ricordando «About suffering they were never wrong, / The old Masters»).
Il mondo va avanti, ma la sofferenza accade, quasi non vista.
Eppure è lì che si annida la possibilità del vedere: è nella caduta, nella distorsione minima dei sensi di ciascun essere umano.
Però nessuno si salva da solo, giusto?
E allora che cosa suggerisce Zaccuri?
Il paziente, Massimo, si può salvare solo grazie a qualcuno che lo guardi guardare. È la testimonianza dell’esserci e della mano che si tende, la testimonianza di un mondo che c’è perché si è in due a sperimentarlo, a dargli fondamento e giustificazione. Solo così, dietro la realtà che si disarticola, si riesce a intravedere qualcosa che resiste, una tavola su cui si incide o si stende la pennellata della nostra vita, la sostanza che ci racconta. Anche nel desiderio di esserci nel tempo, in un tempo eterno che non finisca.
È l’arte – tornando a Maria Vittoria Baravelli – che eternizza l’attimo. «Non è sicuramente tramite gli oggetti che emerge il sapore della vita, ma la loro ricontestualizzazione ne mette in luce gli aspetti più veri e simili alla psiche umana. È esattamente lì, in quella rivelazione, che ciò che essi trasmettono si fa eterno e infinito. Una sconfinatezza che non ci rappresenta né possiamo abbracciare, ma che si palesa in quanto tangibile proprio attraverso quegli orpelli che l’uomo ha inventato per sopperire alla propria finitezza: l’obiettivo di una macchina fotografica, una cinepresa, un pennello, una matita, una penna».
Forse il gioco dell’arte è quello di mostrare porzioni necessarie ma non sufficienti a contenere la nostra realtà (come dimostra Silvio Perrella nella bella rubrica radiofonica La musica degli occhi di Radio3 Suite, dove indaga i quadri nel loro sconfinare in noi e tra i pensieri), e la ripetizione a cui ci condanna è solo l’apporto che il singolo può dare per illuminare il minuscolo angolo che resta in ombra, sì, ma dando in tal modo concretezza alla storia di ciascuno: «Dà senso anche al tuo pensiero: / dagli ombra.// Dagli ombra che basti, tanta» scrive Paul Celan.
L’arte va abitata.
Come la vita.
Soprattutto oggi che la carne si fa sottile e tende a evaporare. Mentre se abbiamo una speranza di sopravvivere al nulla che ci mangia i calcagni – pensi – è proprio nel fare corpo, non solo anima.
Lo sappiamo: la redenzione si compie tra le cellule di un corpo crocifisso e deposto, tanto spesso rappresentato.
E sempre nostro contemporaneo.