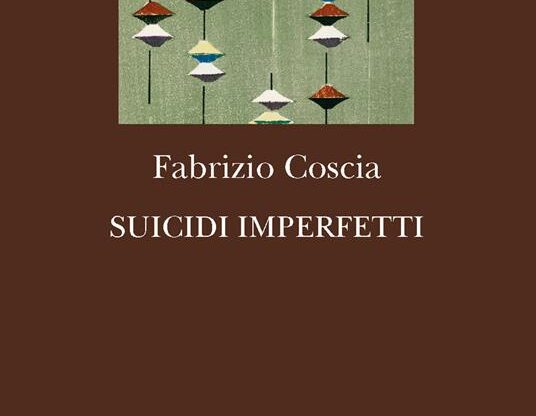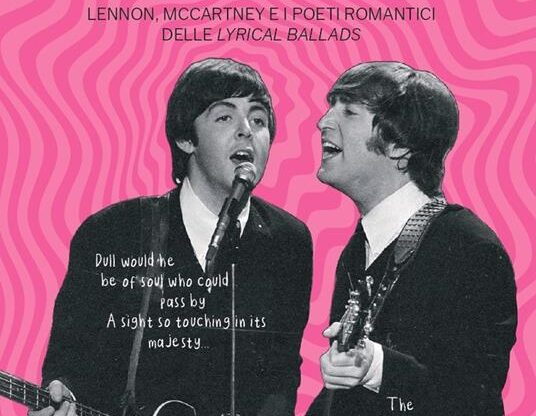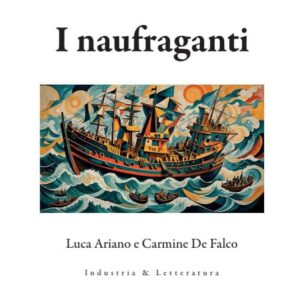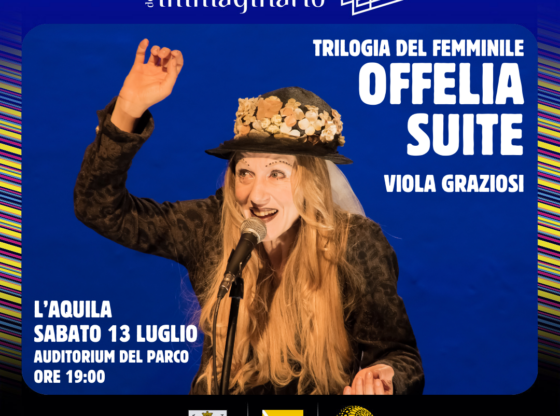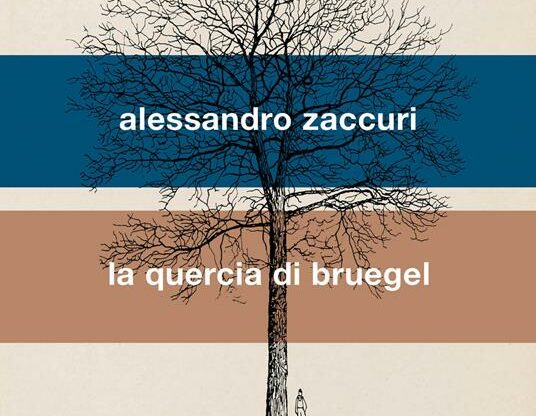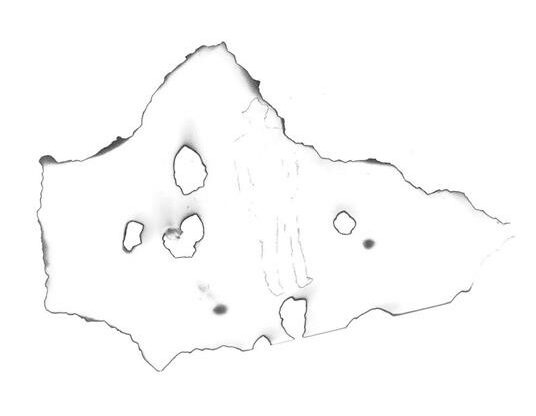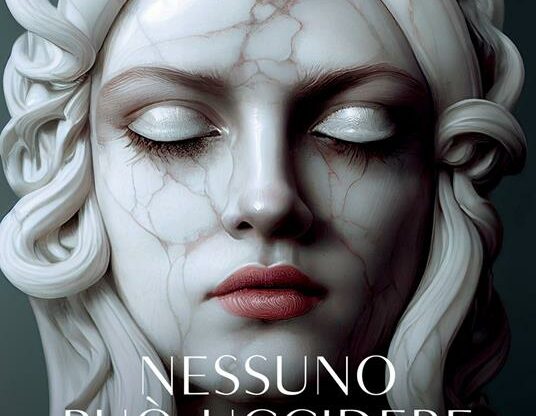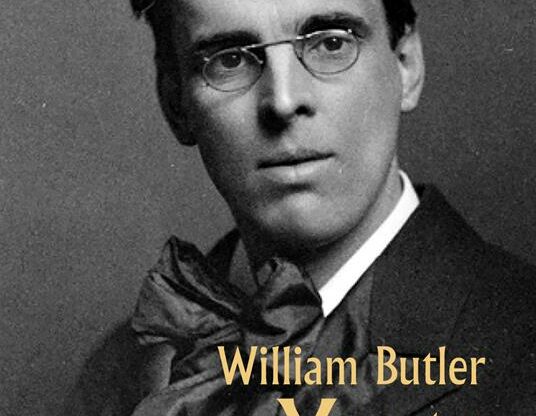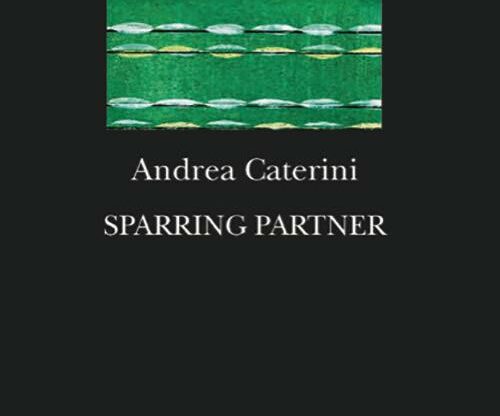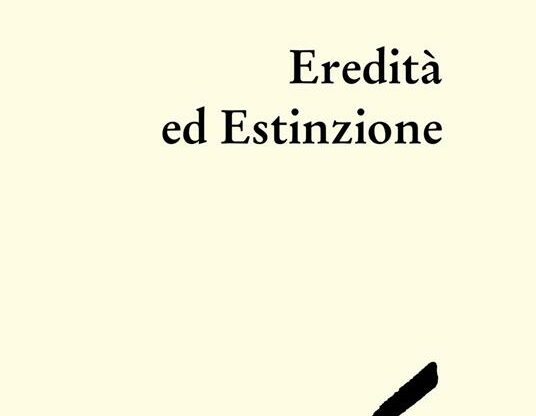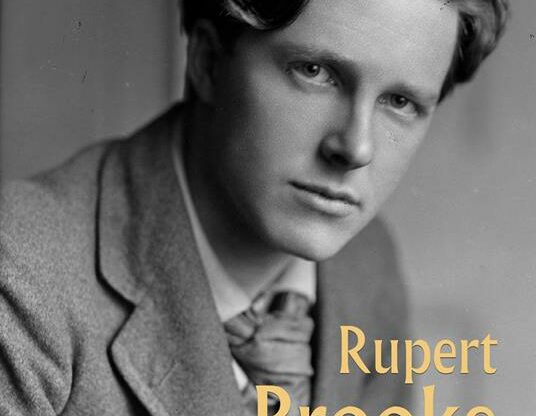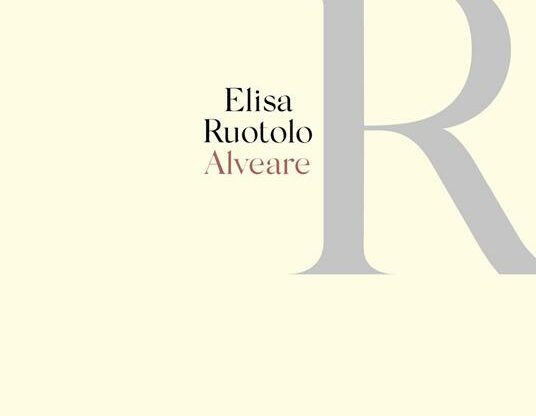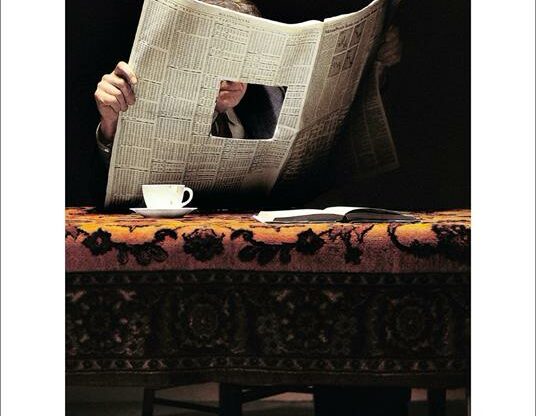Coscia e la perfezione dei suicidi imperfetti
Di Rossella Pretto
Fare senso.
Dargli corpo. Al buio. Nel buio denso che cala sugli occhi, omerico. Tentarlo nell’approssimarsi al nulla. Direte: la bellezza che resta – certo.
Dirai tu: del resto, l’apnea – ça va sans dire. Sospensione, quell’interrogativo. La mano che sfilaccia il tragitto concluso: tappe d’esistenza in ordine sparso. E fine.
Ma resta il galleggiamento. E il tentare. E, daccapo, l’indagine: un raid, insonne e perfetto. Come è perfetta la scrittura di Fabrizio Coscia, la compiutezza nel dire di Suicidi imperfetti (Editoriale Scientifica, 2024, pp. 196, euro 15), la pulizia di ogni gesto bello e sensato, quello del coreografo che compone la necessità dei suoi diciannove danzatori, guide per la via al recinto sacro dove la vita coagula e accade. Dove tutto muore. E l’artista fa da sé. Mostra il fianco e colpisce. Si dà compimento. Il sangue sgorga – non amarena né sangue di piccione – indicando il cortocircuito che lo domina e sorpassa. Perché è a quel confronto che Coscia invita: con il suicidio, l’uscita di scena con gesto violento. Non estemporaneo. Solo la violenza può terminare la vita – che è così forte, così immensamente sconfinata e paradossalmente già sul punto di schianto. Più sfolgora più va in pezzi, è lì lì per franare.
Che cos’è che non arriva a soddisfazione, che manca per accettare l’esistere? Perché tanto dolore, quella pena, l’angoscia, il rovinare di ogni visione, nell’avvicinamento – per gradi, certo – al luogo perturbante dove il velo si alza e… ? e non si trova ragione. Solo sgomento. E voglia, irresistibile di quel nero, il volo acerbo e già tentato. A dire: interrompi la vita. Torna al centro di un pensiero. Fattene promotore, agiscilo. E null’altro. Ma stacci affianco. Costeggialo sempre. Interrogalo. Come Trevisan (che tra questi ritratti è assente, ma non tra i convenuti in dedica). Che cos’è, cos’è quel fare morte, quell’accumularne familiarità? Quello starci appresso, accostato, orecchio a orecchio, bocca a bocca, per afferrarne le parole. Dirle. Perché sia possibile dirle. Qualcuna, almeno. Dalla morte trarre parola, qualcuna, affrancarla appena, anche coi segni ancora addosso della schiavitù – che non se ne libererà. Il linguaggio e la morte. Sì, s’è detto, già detto, andato.
Nell’introduzione, Coscia afferma che quella morte, quel darsi la morte, appone un sigillo di verità all’opera degli artisti di cui sbozza ritratti nitidi, scritti con eleganza acuita da un’adesione che si avverte profondamente meditata. Al fondo, vi è la verità di ogni impegno, della missione, il patto. Senza rischio non c’è necessità né vocazione. Né, maybe, bellezza che residua. È come dire: se mi avvicino al limite estremo di ogni mia caducità, di ogni mio mancare, dirò l’oscuro – come Celan – dirò oscuramente la verità di quel mio essere che è mancare. Ogni vita che Coscia narra, minuzioso a restituire singolarità – mai sopprimendo il tratto che fa comune l’umano tutto – ogni vita è toccata da un inciampo, un caso che la rende sghemba, originale ed eccedente. Si accende ogni nuance. Ecco i ritratti – il genio purissimo, qui più che mai, della penna di Coscia che compone il suo canone privato – da David Foster Wallace, la depressione incalzante, la dipendenza da farmaci (lui che con i cani aveva un’intimità che Coscia conosce bene), a Pavese e l’amore per una ninfa che non resta, quella volontà di punizione, nel bisogno di ciò che fugge, fugge sempre («Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità» Coscia trascrive). C’è l’evidenza dissolvente di Francesca Woodman: che la fotografia non mostra, ma opacizza il reale, è un atto di sparizione, l’esposizione più ardita è la forma estrema di una negazione. Le tracce però restano e indicano. Si passa per Philipp Batz (Mainländer) che da Napoli – quella sua bellezza sublime e ambigua – ha iniziato a postulare la volontà di morte di Dio: «immaginò che siamo frammenti di un Dio, che all’inizio dei tempi si distrusse, avido di non essere. La storia universale è l’oscura agonia di quei frammenti» (nella rilettura di Borges). C’è Marylin con lo spettro della pazzia, il manicomio/prigione, il bisogno di non spandere il ‘fluido’ e farlo continuamente, lo scialo, e poi il senso di esclusione di Sarah Kane, la sua «impotenza a vivere», e l’orrore chiamato dall’Olocausto (in Celan, appunto), in Bespaloff, la fatigue – e lei déraciné -, la guerra, ciò che crolla, crolla tutto, in Virginia Woolf – la paura, il panico di guerra, il rendersi conto che la vita è sogno (non avrebbe detto così) e l’arte è illusione, solo la morte è verità sperimentabile. L’importante è finire, cantava Mina, ma forse alludeva al rapporto sessuale. Il punto è: come si dovrà fare una volta finito? Ecco. Vedersi al termine. Questo è. Integri. Nel tondo dell’immagine che si palesa per intero. Anche nel nero della fodera. Satin, meraviglioso e smagliato. «Chi pratica l’arte […] lo fa ingaggiando una battaglia per la sopravvivenza», quello che si diceva sopra, vedi impegno, missione, patto. Ma c’è di più, una «sopravvivenza in un mondo che gli rimane estraneo, e in cui vive come in perenne esilio». Voilà, questo è il «costo pagato dall’autore» per cui l’arte è «un mezzo per progredire verso la conoscenza di noi stessi e verso l’esperienza della realtà», quella che fa compiuti e stagliati. Niente più menzogna. Tolta quella, appare la possibilità di parlare di sé, attraverso di loro. Questa di Coscia allora diventa «una raccolta di esercizi di ammirazione». O, meglio ancora (perché sono tutte prove), «il racconto biografico di un’ossessione, narrato attraverso le vite degli altri», e una «rivisitazione», come per Zweig. Punto. Con una coda, una specificazione: suicidi imperfetti sono quelli di ognuno, sono anche quelli pensati e vagheggiati. E imperfetti, infine, sono i suicidi reali, perché lasciano un sedimento di vita, una casualità che risplende. La morte retroilluminata che denuncia l’aberrazione dell’esistere. Strampalato, irresistibile, à bout de souffle, come per Jean Seberg, altra convenuta.
Ma che cos’è la verità, che significa? È – si diceva – l’aderenza a un progetto, a un sentire, unico perché destinato e scelto e compiuto in piena consapevolezza. Scelto nella costrizione. E che cos’è il dire del suicidio di Coscia, cos’è il suo ostinato ripercorrere le vie dell’autentico, dell’accaduto per davvero, testimoniandosi nel racconto dell’altro? Perché la vita dell’autore, attore, drammaturgo, musicista, filosofo, deve essere esposta, perché non vi è salvezza, perché non provare la costruzione di un mondo, perché non la consolazione? Perché? Anche conoscendo la risposta, o meglio, la necessità della risposta, la domanda si riformula. Umana. Anche quella che chiede: ma se finora il grande racconto (vero, inventato) ha comunque potuto testimoniare l’uomo intramandolo ai i suoi recessi bui, perché ora no, non più?
Perché non v’è più armonia, perché striderebbe e stride: il male è scatenato, da sempre, ma ora pieno. E ringhia, forte, contro la ricomposizione che è quadro – non si può più ricucire il senso dove non v’è, dove il frantume si spegne e solo ha un attimo per mostrarsi e finire tra «papavero e memoria», in quel «nero latte dell’alba» che Celan ha offerto. E che anche tu hai costeggiato, tempo addietro, nel maremoto dell’adolescenza, quando ancora avevi un padre che ora non hai più.
Cosa rimane di allora? Rimane il sentimento del suo averti creato, averti dato la vita – e tu tentatavi di sradicarla, volevi disfartene e glielo hai detto, hai alzato i polsi, quelli che già da bimba ti eri tagliata – ma tu dici, e sempre hai detto: per sbaglio (già a tre anni potevi volere tanto?) – alzavi i polsi turbolenti e li mostravi, esponevi il taglio, il tentativo – ché era quello. E lui smise allora l’orgoglio, il padre lo smise – una volta così è successo, successe – lo smise e ti abbracciò. E ora che di mani e braccia di padre non ne hai più da tempo sufficiente per dirne l’amore che si scapicolla e torce, ora ricordi di lui la mancanza nello strazio di dirsi orfani. Lo scandalo, essere privi dell’innesco che crea – non sarà stato così anche quando fu decretata la morte di Dio, essere qui e non avere origine… essere qui e stare in eterno, per sempre galleggianti a riconcorrere l’infinito di una condizione sfranta, come Titono, estenuato e in continua agognante ricerca d’alba?
Allora, parlando di Keter, la prima sefirah della Cabala ebraica – in Celan – Coscia ricorda che è «il primordiale desiderio dell’En Sof, ovvero dell’In-finito, di entrare nella vita dell’essere, e dunque di automanifestarsi»: è Dio allo stato potenziale che include tutto e quindi anche il nulla, tutto, prima che si manifesti, e quando si manifesta, all’inizio della Storia, porta il male incarnato nella Shoah, e l’esilio di Dio. È un cortocircuito inguaribile. Tua nonna aveva smesso la filosofia per ricercare un senso che basti. Sarebbe bello. Basterebbe aprire gli occhi e non pensare. Ma non tutti riescono. Rimane il tentativo, anche qui, di infrangere la sudditanza esponendo al contempo le ferite. Andare a deporre in aula e ricordare l’aderenza (leggi autenticità) alla condizione mortale, di più, l’aderenza alla colpa. Colpevoli di esserci in miseria. Fugaci e ammalianti. Proni al destino di sopravvivere. Ma fino a un certo punto. Finché sia possibile dar credito alla «tregua», «sacra» – leggere bisogna il ritratto di Rachel Bespaloff che forse rende tutto fulgente: «Bespaloff tentò fino alla fine di tenere accesa questa luce della speranza, nella notte del Novecento, una luce da contrapporre alla “cecità della storia”. Finché, il 6 aprile 1949, nella casa di South Hadley, tutto si spense – la luce, la voce, la ricerca della verità – e non restò che il buio. Poco prima, Rachel aveva scritto a Gabriel Marcel, in un momento di accorata fiducia: “Eppure, la vita può ancora, in certi minuti essere incredibilmente bella – come un tema che riappare verso la fine con qualche nota in meno, una sincope, un ritardo…”».
La bellezza e la gratitudine, per i misteri grandi che Coscia tratteggia, e pure per lui, la sua scrittura necessaria e molto ammirata, amata da un tempo lungo.
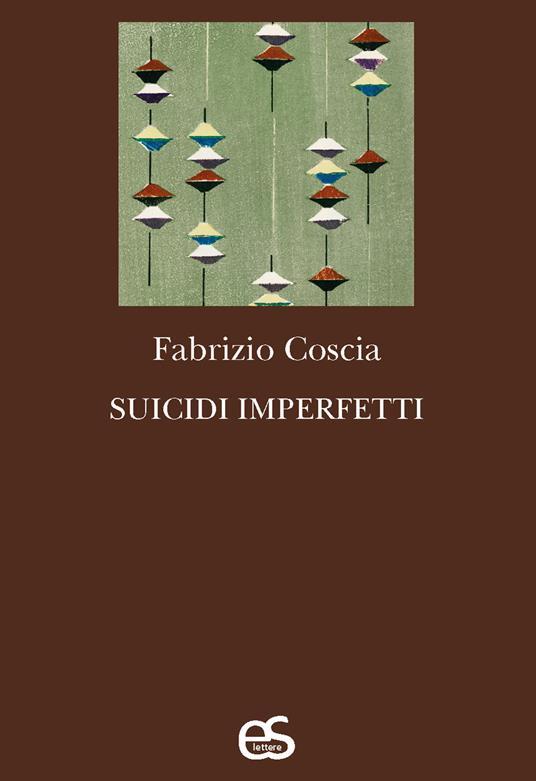 Suicidi imperfetti
Suicidi imperfetti
S-confini
Saggistica
Editoriale Scientifica
2024
196 p., brossura