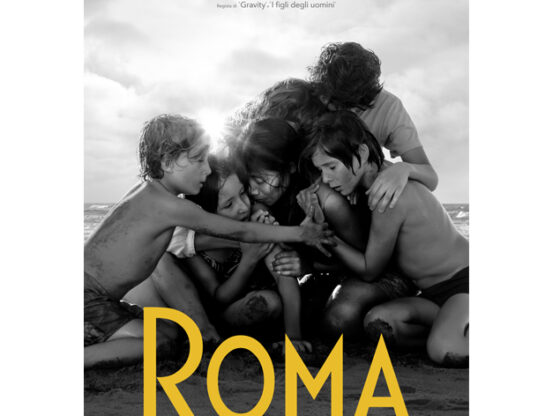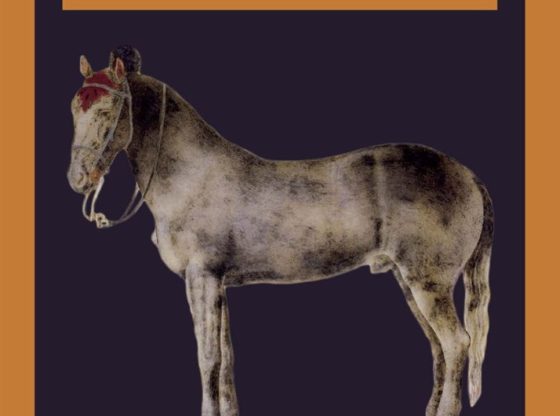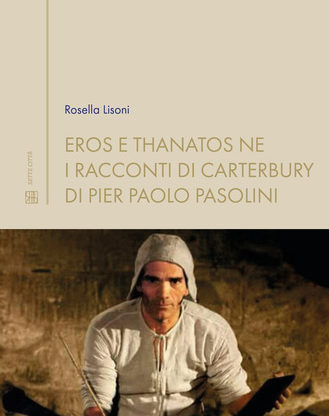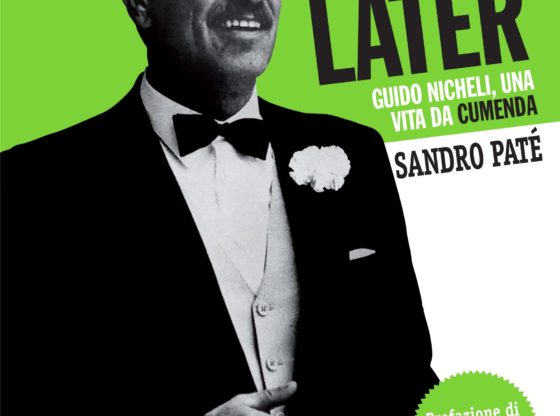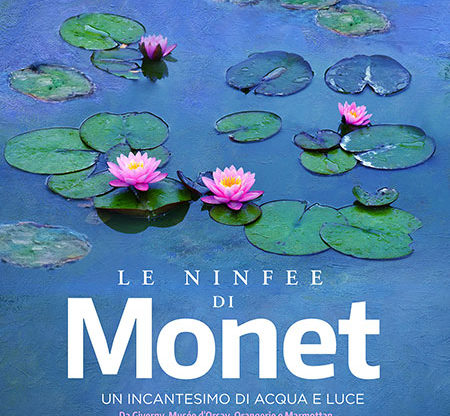L’iconografia giovanile negli anni ’70: da “Il Laureato a Arancia meccanica”
di Brunella Sacchetti
Gioia bevono tutti i viventi
dai seni della natura;
tutti i buoni, tutti i malvagi
seguono la sua traccia di rose!
( da L’Inno alla Gioia, di Friedrich Schiller)
Solo quattro anni intercorrono tra due famosissimi cult movies come “Il Laureato”, 1967, e “Arancia Meccanica”, 1971; eppure sembrerebbe che una lunga epoca storica li separi, un vero e proprio ciclo vitale, durante il quale sono state delineate mutazioni definitive e irreparabili.
Si osservino le “locandine” dei due film…
In quella di “Arancia Meccanica” ci sono studiatissimi rinvii alla Pop Art ( nel film vi sono chiari riferimenti all’opera di Piet Mondrian, Roy Lichtenstein e Constantin Brâncusi, ed inoltre alla “op art”,”optical art”, di Victor Vasarely ): la prevalenza del bianco ( utilizzato grandiosamente anche per i costumi dal premio Oscar Milena Canonero), vero protagonista cromatico del film, le striature, cariche di valenza simbolica, del nero e del rosso, il disegno “a tagli” triangolari che va dalle vocali del titolo allo squarcio da cui si affaccia Alex, fino, ovviamente, all’arma, un coltello, forse più esattamente un punteruolo, che si protende “fuori” dal riquadro, in evidente, e surreale, atto di minaccia rivolto allo spettatore, costituiscono nel loro complesso elementi espliciti delle caratteristiche del film.
L’altra ha, invece, un impianto ben più che tradizionale: un interno un po’ impreciso, sbiadito e grigio (è opinabile sia la stanza di albergo dove avvenivano gli incontri di Mrs. Robinson e Benjamin), un interno nel quale si intravede un televisore e troneggia in primo piano la gamba e la calza della Signora Robinson; Benjamin ha le mani in tasca, il volto vagamente contrito e annoiato e i piedi scalzi….l’amplesso c’era già stato e i due stanno per andarsene; il piede della donna è come imperioso, sembra quasi annunciare un calcio; niente di violento, un piccolo calcio, come a dire: “vai pure…tutto fatto, concluso”. I piedi nudi di Benjamin, all’inverso, fanno pensare ad una fuga, ma non tanto dalla camera d’albergo, ma dal mondo a cui appartiene, e ovviamente, anticipano l’epica fuga finale del film.
Dunque abbiamo, da un lato, un simbolismo post-surrealista, che declara l‘appartenenza della pellicola di Kubrick alla nostra epoca, e cioè ad una stringente contemporaneità, con quella capacità di tale regista a profetizzare un futuro con accenti di certezze apodittiche, sebbene distopiche. Dall’altra, nel film di Mike Nichols, abbiamo un impianto di tipo narrativo, al punto che, dalla locandina, sarebbe possibile quasi ingenerare la trama del film, attraverso le oggettive citazioni dell’universo borghese americano di quegli anni.
Di fatto Benjamin è l’epigono di tale universo borghese, per altro molto celebrato dalla cinematografia americana che va dagli anni del dopoguerra agli anni ‘60/’70: registi come John Ford, Frank Capra, Billy Wilder, nella delineazione dell’ “American way of life”, la strutturano dal punto di vista iconografico per mezzo di attori come James Stewart ( si pensi ai grandi film di Capra come “Un giorno in parlamento”, “La vita è una cosa meravigliosa”…) o l’attore-icona di Ford, il John Wayne di “Un Uomo Tranquillo”, o Jack Lemmon dell’”Appartamento”, indiscusso capolavoro di Wilder; è un autentico e completo immaginario di prototipi di giovani americani con la faccia di bravi ragazzi, già in una certa misura un po’ inquieti, anche se ancora lontani da quella forma di oscura “aegritudo” che caratterizza Benjamin .
Di questi prototipi c’è stato poi un curiosa rivisitazione a metà degli anni novanta: “Eroe per caso” (1992) di Stephen Frears, “Dave – Presidente per un giorno” (1993) di Ivan Reitman, “Mister Hula Hoop” (1994) di Joel Coen, e soprattutto “Forrest Gump” (1994) di Robert Zemeckis, con il suo portato di incredula sospensione tra gli eventi storici di quegli anni; sospensione che è quella di Benjamin disteso sul materassino di plastica ( “Plastica”, …“il futuro è della plastica”, gli suggerisce Mister Robinson…), con il quale Ben ondeggia sulla piscina dell’incipit del film, sospensione che, a sua volta, si rispecchia nel suo stesso sguardo, pensoso e interrogativo. Ma questa condizione limbica è, in verità, quella di tutta la storia del film,che si inserisce tra un’epoca di assolute e acritiche certezze sociali ed un’altra, che invece tenterà di scardinare l’ intero universo.
Benjamin, che nel nome già ci rinvia alla condizione di “prediletto”( Beniamino era nella Bibbia l’ultimo e amato figlio di Giacobbe e Rachele), più che “laureato” era “The graduate”, titolo originale del film, un laureato, cioè, di livello formativo alto, comunque poco più che ventenne, dai livelli socio-economici familiari sicuramente privilegiati; Alex, anche lui giovanissimo ( si ricordi che la madre lo sollecita a tornare a”scuola”…), ha alle spalle, a differenza di Ben, una famiglia operaia modesta, che vive in una casa dai tratti opprimenti, soffocanti.
La Storia di Benjamin si snoda secondo le tipiche vicende della commedia americana: un giovane, alle soglie dell’adultità, sta per definire il suo futuro; di fronte a lui ci sono i genitori che non sospettano alcuna incertezza nel figlio prediletto, ma l’amica di casa, nelle vesti, neanche troppo mascherate, di strega malefica quasi disneyana, lo trascina in una situazione di sesso e trasgressione, che ostacolerà il lieto fine: un “Happy and” che, se “Il laureato” fosse stato una commedia tipica, si sarebbe risolto con i toni di film come “ il padre della sposa” o, al più, come “Indovina chi viene a cena”, ma a Benjamin tocca, invece, compiere il grande insulto: è il figlio “prediletto” per il quale non basta il sacrificio dell’agnello più grasso, serve lo strappo, il “discidium”; Ben sembra dire: “Mi prendo il mio grande amore, indifferente alla bestemmia che mi state lanciando (una bestemmia implicita che sembrerebbe evocare un indiretto incesto), e, mentre mi porto via Elaine, chiudo programmaticamente la chiesa che stava per celebrare un disamore, e la chiudo per mezzo di un enorme crocifisso”.
E crocifissi “blasfemi” punteggiano le pareti e la storia di “Clockwork Orange”. Già nell’omonimo romanzo di Anthony Burgess (1962) la storia non ha nulla dell’impianto narrativo della commedia; gli eventi si susseguono come onde più o meno sovrapponibili, quasi spazi sincronici che non vogliono lasciare spazio al respiro; il film risulta spezzato da sequenze caratterizzate dall’avvicendarsi di episodi di violenza compulsiva, da quella ai danni del clochard, poi ai danni di un’altra banda, i cui componenti vestono da nazisti; quindi si c’è l’irruzione nella casa di uno scrittore la cui moglie viene stuprata (ne morirà, come apprenderemo in seguito) …poi la pellicola si dispone su basi lievemente diverse e si assiste, così, al passaggio da una brutalità corale, alla rappresentazione della storia individualizzata di Alex di fronte alla famiglia, alla banda dei suoi “drughi”, alle istituzioni ( sic!): Alex, in una sorta di bildungsroman capovolto, si incontra con la polizia, il carcere, la cura, il tentativo di suicidio, il rientro in società, e, infine il beffardo epilogo: Alex diventa capo della polizia e, per parafrasare Francesco De Gregori, Alex “cercava Ingiustizia, trovava la legge…”
Cosa succede, dunque, in questi quattro anni che separano i due film in oggetto? Se volessimo usare il Cinema per spiegare il Cinema ( e la sua, e la nostra storia), potremmo prendere dei fotogrammi dalle tante pellicole uscite in quegli anni e negli anni immediatamente successivi e comparirebbero i volti di Robert de Niro in “Taxi driver” (Martin Scoersese,1976), le immagini di “Zambriskie Point”( Michelangelo Antonioni, 1970) e del suo interminabile deserto, gli occhi di Jack Nicholson in “Professione Reporter”( Michelangelo Antonioni, 1975) e “Chinatown” (Roman Polanski, 1974), di Al Pacino blindato nella Banca di “Un pomeriggio di un giorno da cani” ( Sidney Lumet, 1975)… tutti loro, e tanti altri, potrebbero trovare una sistemazione da clienti affezionati nel ”Kurova Milk Bar” di “Arancia meccanica”, accanto ai Drughi, con il bicchiere di latte arricchito di mescalina e cocaina…Un unico lungo film, un decennio di pellicole tese a farci capire chi sono i nostri compagni odierni, giovani in via di un’impossibile passaggio all’età dell’equilibrio.
D’altra parte l’equilibrio della maturità, quello che comporta scelte lucidamente conformi al mondo pregresso, alle generazioni parentali, alla cosiddetta saggezza dei “padri”, quelle scelte e quell’equilibrio erano già apparsi alla letteratura dell’’800 ( e anche dell’ultimo ‘700) come improponibili. Il Don Giovanni mozartiano è già un impunibile e impenitente che affronta e sviluppa situazioni criminose…Lo stesso Barry Lindon è affine; e poi le figure di tanti personaggi verghiani, i protagonisti dostojeskiani, gli ibridi kafkiani e le inarrivabili raffigurazioni di Musil…
Il mondo dell’iconografia letteraria si era da tempo scomposto in un affresco astratto, e per molti illeggibile, dove volti e sguardi ci avevano avvisato che “fortezza, giustizia, prudenza e temperanza”, le famose, o famigerate, virtù cardinali, non risiedono più tra noi; le virtù su cui si era basato il “mos maiorum” per tanti secoli avevano subito urti e scossoni tali da ingenerare quello che viene chiamato, in forma generica, “nihilismo”.
Il “nihilismo”…Sappiamo bene che tale “non-pensiero” è uno dei fantasmi totemici del mondo contemporaneo, sappiamo bene che è riconducibile al nietzschianesimo, che, per altro, si è impegnato soprattutto nel rilevarlo, non tanto nell’ingenerarlo; sappiamo,inoltre, che esso è materia densa, ma, al contempo sfuggente, perché sfuggente è il suo imperativo: la realtà è il “niente”, nihil, e dunque il Kurova bar non esiste, Alex non commette violenze, Benjamin ha la sua faccia da bravo ragazzo e nulla più…tutto è niente…”; ”tutto bene? “: oggi ci salutiamo così, saluto oltremodo nihilista che comporta una risposta fintamente assertiva : Sì, va tutto bene, perché tutto è uguale a niente.
E l’arte? Mentre ne “Il Laureato” le musiche di Simon e Garfunkel, sono ancora uno sfondo armonizzato al film e seguono il dipanarsi della storia e la raccontano, divenendo esse stesse un caposaldo della nostra memoria di quegli anni, in “Arancia Meccanica”, la musica, privata di ogni possibile impegno a capire e spiegare il mondo, si avvia attraverso itinerari surrealisti e postsurrealisti nei quali il “il caro Ludovico Van” diviene coprotagonista, insieme al Rossini del “Guglielmo Tell”, di violenze e stupri, e la sua splendida “Nona sinfonia”(i movimenti della nona sinfonia presenti nel film sono eseguiti su sintetizzatore Moog da Walter Carlos) insieme all’ode shilleriana “Inno alla Gioia”, si alterano, costruendo percorsi che si incrociano con canzoni hollywoodiane come “Singin’ in the Rain”( Freed-BROWN, 1929, 1952, famosa per il film con Gene Kelly “Cantando sotto la pioggia”), accomunate alle grandi sinfonie dall’identico svuotamento semantico, anzi connesse agli eventi peggiori per il protagonista, come quello della “cura” di Alex , finendo, così, a fare da sfondo alle scene più brutali, quasi che l’unica sua vera forma vitale, l’arte, gli si torcesse contro.
Umberto Galimberti, acuto osservatore di dinamiche sociali, rileva che i giovani stanno, nel mondo contemporaneo, male, e male davvero, e Alex, nel suo delinquere, sta sicuramente male: «non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni rendendole esangui».
Sul piano della prassi è accaduto che le pulsioni ribelli sono state svuotate di ogni iniziazione all’impegno, di ogni autentica e precisa possibilità di “fare, cambiare, riconsiderare…”. Attraverso l’uso di ogni mezzo, lecito e illecito, la ribellione sociale viene, infatti, progressivamente trasformata in un vero e proprio capro espiatorio. E, una volta rimossa la dimensione politica, forzatamente fatta coincidere con terrorismo e insubordinazione violenta, l’individualismo trasgressivo, lusingato dai media, potrà definitivamente essere incoronato nei confini imprigionati del suo nuovo e inflessibile regno: il consumo.
Da un lato il ribellismo viene identificato, come dicevamo, con l’insubordinazione politica e si trasforma nel terrorismo degli anni ‘70/’80, dall’altro la disobbedienza pura e semplice viene identificata con problemi di natura neurologica e sanitaria, se non addirittura psichiatrica. Viene annullata, cioè, la spinta propulsiva al cambiamento, che risulta anche connotato di una dimensione patetica, collegata al suo non essere né credibile, né proponibile, nè incisivo; risulatano così marchiate a fuoco da immagini surrealiste le icone della ribellione, buona o cattiva che sia ( Benjamin e/o Alex) e si fa strada il terrorismo senza disegno politico, la degenerazione intellettuale e morale, la diffusione del cinismo e della droga, la politica di unità nazionale, la legislazione speciale, le stragi, i poteri occulti.
La politica è “religio inferior”, sconfitta dalla “ratio tecnologica”.
E al solito Pasolini aveva capito tutto:
“In altre parole la nostra colpa di padri consisterebbe in questo: nel credere che la storia non sia e non possa essere che storia borghese”
(Pier Paolo Pasolini, Lettere luterane. Roma 1991, 5-12.)
L’immagine di copertina è tratta dal sito DaParte.it