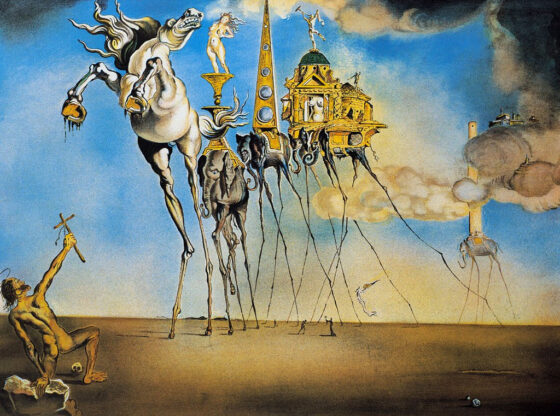Zio Lando
Una nave senza timoniere non può navigare, fu così che mio zio Lando prese il timone della nostra nave dopo la morte del nonno. Mio padre, si diceva, era molto bravo con le carte bollate, le leggi e le amministrazioni, ed era vero, ma di contro non sapeva appendere neppure un quadro. Al contrario di nonno, zio aveva un atteggiamento più brioso, da vero comandante; ogni riparazione la eseguiva tra smorfie e sospiri, neppure fosse Michelangelo alle prese con la cappella Sistina. Aveva però bisogno di assistenti
– Passami il giravite
– Reggi qui
– Sposta lì
– Sposta là
E noi tutti facevamo capannello. Poi, irritato, all’improvviso gridava in romanesco: “Levete! Levete!.
Anche l’orto continuò ad essere coltivato da lui che, pian piano, diventò davvero molto bravo, solo che fanatico com’era si guadagnò il soprannome di “ortofresco” perché ad ogni cesta di raccolto, girava per la casa dicendo “guarda che roba”. Il dialetto romanesco era di casa, da non confondersi con il romanaccio (cioè quello sguaiato e tempestato di parolacce) quello era severamente proibito.
Zio non aveva voluto studiare, desiderava fare il meccanico, che negli anni in cui la Fiat diventava un colosso, vanto dell’industria italiana, quel lavoro era considerato l’avvenire. Frequentò quindi prima le scuole professionali e poi diventò apprendista nell’officina vicino casa. La sua bravura fece sì che venisse assunto presso l’OMI (Ottica Meccanica Italiana) e assegnato al reparto scatole nere. Apriva cioè ed esaminava le scatole nere degli aerei, cercando di risalire alle cause degli incidenti. Era un posto di riguardo e responsabilità che lui portava avanti con grande serietà ed orgoglio. Appassionato di motori, quando portò a casa la prima 600 verde pisello, colore di gran moda, si fece fare da mio padre un vero e proprio servizio fotografico. Noi tutti spettatori, interprete principale, zio al volante, zio nell’atto di scendere dalla macchina, zio appoggiato alla macchina con le braccia conserte. Ma il premio copertina rotocalco fu assegnato alla posa che lo ritraeva appena sceso dall’auto ma non del tutto, cioè una gamba ancora dentro, mentre con la mano faceva l’atto di togliersi gli occhiali da sole. Lì scattò l’applauso anche da parte dei vicini affacciati alle finestre.
Questo zio era una vera macchietta. Quella sua aria da burbero smanioso se la portava sempre dietro, anche se non convinceva nessuno perché era facile alla commozione e le due cose insieme davano un risultato estremamente buffo. Forse il dualismo era la sua prerogativa, dato che nel parlare associava parole dialettali con altre più forbite e pretenziose di un italiano perfetto alquanto improbabile. Il risultato era pressoché osceno, diventava per questo l’oggetto delle nostre risate. Come quella volta sul campo di bocce. Dovete sapere che in giardino avevamo un campo da bocce, costruito nel rispetto delle regole più severe, secondo la passione di tutti gli uomini di casa e non solo. Durante la buona stagione il giardino si animava di tanti personaggi che venivano a giocare una partita. Amici e parenti si presentavano con mogli e figli, gli uomini giocavano, le donne chiacchieravano e ricamavano, noi bambini giocavamo. I divertimenti e gli svaghi, allora, erano molto semplici, non sempre però dettati dalle possibilità economiche. C’era dell’altro, forse una forma di pensiero culturale e sociale che ti faceva quasi sempre preferire la cerchia di persone conosciute e condivise, anche se poi non era sempre così idilliaco. Ma questo fa parte della vita.
Quel campo di bocce confinava con il giardino di un Cavaliere molto riservato e compìto, che però non resisteva al richiamo del gioco. Il Cavaliere, vestito elegantemente, come al solito si posizionava vicino alla recinzione e assisteva con dignità alla partita emettendo soltanto flebili suoni di assenso o dissenso. E nonostante le sollecitazioni dei giocatori non si lasciò mai trascinare in una vera e propria conversazione. Quella volta però il punto era troppo controverso e il Cavaliere, sussultando, espresse il suo parere con voce forte e decisa. Le donne, sorprese, si alzarono di scatto esclamando: “Ma che è er cavaliere c’ha parlato”? In due minuti si creò il teatro, noi spettatori, il Cavaliere dava il suo parere e spiegava quanto in verità amasse quel gioco. Gli uomini, bocce in mano, guardavano il mostro sacro senza parlare. E il silenzio si diffuse. Entrò in scena mio zio, che sperando in una nuova amicizia di rango, si accingeva a sfoderare la frase storica. E mentre la commozione gli stringeva la gola, il dualismo romanesco compì la sua opera, mentre tutti gli spettatori increduli furono testimoni di quel capolavoro letterario: “Si lei cavaliere volesse levarsi qualche volta qualche soddisfazione, venghi pure a giocare co’ noi”. Bocce a terra, giocatori vagamente in fuga, donne a casa. Rimanemmo soltanto noi bambini con gli occhi fissi al di là del giardino. Ma sinceramente fu troppo anche per noi