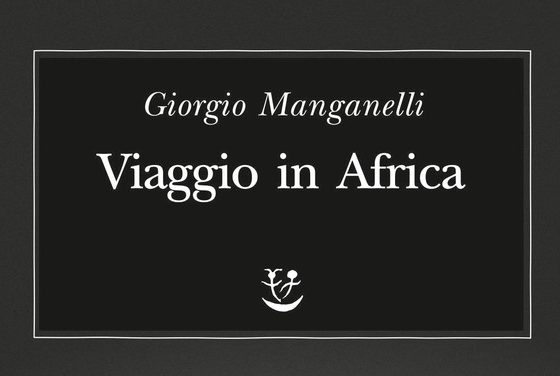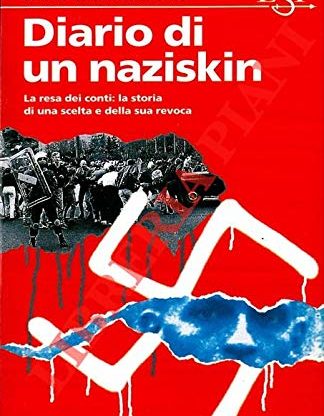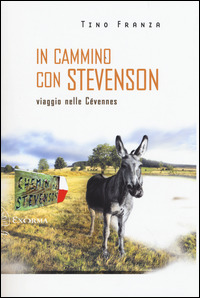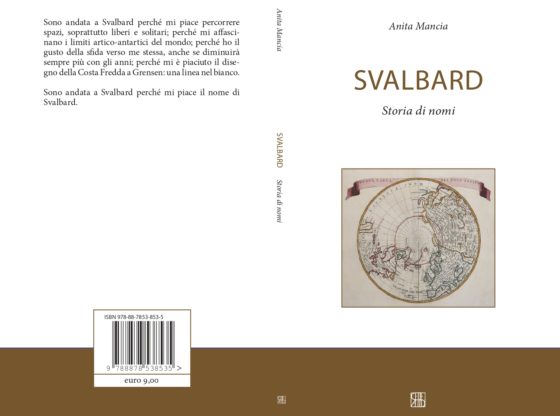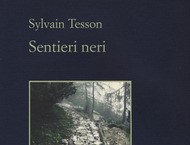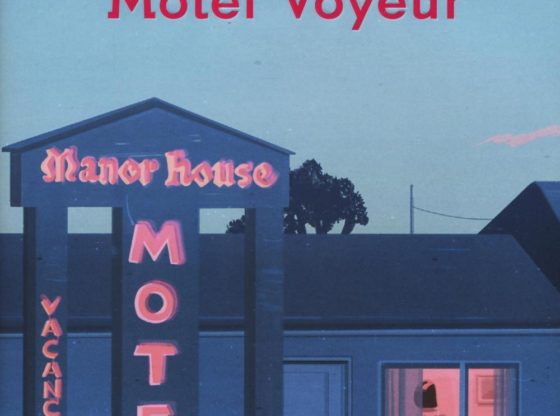Manganelli e il suo viaggio in Africa. La cattiva coscienza dell’occidente
Era il 1970 quando Manganelli, per una serie di casi concatenati l’uno all’altro con la forza di quello che sembra un disegno più grande, si trova a lasciare la “simpatica condizione di scrittore sempre in poltrona […] a scrittore in cammino per il mondo”. Sono queste le parole con cui Viola Papetti (che di Manganelli fu intima amica e interlocutrice) spiega, nella sua bella postfazione, la genesi di questo interessantissimo Viaggio in Africa. Qualcosa di molto diverso da ciò che i più potrebbero aspettarsi da un libro che si presenta con questo titolo. Quello che avrebbe dovuto essere una sorta di elogio all’imprenditoria postcolonialista diventa, pagina dopo pagina, un lucido percorso geografico e culturale, attraverso la cattiva coscienza dell’occidente rispetto ad un continente-mondo.
Manganelli viene coinvolto da Carlo Castaldi, dirigente della multinazionale Bonifica, in quello che doveva essere un viaggio per cantare le magnifiche sorti e progressive di un progetto infrastrutturale: la costruzione di una strada, la Transafricana1, lungo la costa orientale dell’Africa, da Dar es Salam al Cairo. Curioso e inconsapevolmente ironico, nella sua superbia, quell’1, messo come promessa/minaccia a indicare il primo di una serie di interventi viari che avrebbero dovuto rendere turisticamente vendibile quella parte di continente. Inconsapevolmente ironico perché, non solo non vi furono progetti2 o progetti3, ma nemmeno quel progetto1. Certo non per colpa di Manganelli che, peraltro, si vide rifiutata la prima stesura del suo reportage che, oggi, grazie ad Adelphi, possiamo leggere nella sua lucida, spietata lungimiranza.
Manganelli, nel momento in cui intraprende questo suo viaggio, giustamente definito Ur-viaggio, non è e forse non può essere esente da quell’immaginario stereotipato e fatto di clichè cinematografici che accompagna un occidentale per la prima volta alle prese con la realtà dell’Africa. E, non a caso, il suo reportage comincia quasi a ritroso, raccontandoci cosa accade all’europeo che torna da un siffatto viaggio, carico non solo di immagini ma di inevitabilmente mutate interpretazioni. Quell’europeo è lui, Manganelli stesso, che dimostra subito un cambiamento seppure non ancora completamente scevro da un inconscio (forse) senso di superiorità che lo porta, subito, a dichiarare una scissione culturale, quindi ancora una volta occidentale, rispetto all’Africa: “Considerando l’uomo europeo, osserverà come in costui le singolari qualificazioni coincidono con i pesanti condizionamenti; sapendo leggere, all’europeo non è concesso in nessun momento di sottrarsi al capillare imperio della legge, dei regolamenti, ordini e divieti; sempre più debolmente potrà schermirsi dalle dissuasioni e persuasioni commerciali e ideologiche”. Ecco però che, ciò che ancora può apparire come una definizione culturale, già diviene profonda scissione e critica. In queste poche righe era evidente come un reportage di tale portata non potesse rispondere alle esigenze da cui era nato. Gli africani non sanno leggere non è una dichiarazione da arcadica esaltazione del “buon selvaggio” ma, lo si vedrà nel prosieguo del libro, la radice più autentica, di una terra la cui storia è fatta di altro, di altri segni e di altri significanti. E che, per tale motivo, doveva essere addomesticata dall’occidentale incapace e forse impossibilitato dall’uscire dalle sue categorie di pensiero.
Un addomesticamento, chiamiamolo così, che è insito, per altro, nella stessa idea che l’occidente ha della città e del tempo, concetti centrali e fondanti di tutto il libro, da cui non si può prescindere per comprendere, o cercare di farlo, l’incolmabile differenza: “Una città è fatta di case e strade; tenacemente si stende a obliterare ogni traccia di terra; […] col tempo, gli edifici derelitti intristiscono e decadono, per risorgere poi come Rovine. Anche gli scritti, residuati di molt vite, cambiano consistenza e colore: diventano Documenti, si affidano al silenzio di bachehche ed archivi. Così, con ruderi e documenti, nasce la storia come la intende l’Europa, secondo quel che le consente e le impone la sua idea di tempo.” Il tempo, e con esso l’ideologia occidentale al tempo legata, sono intrappolati nella sequenza, nella durata. E ciò rende l’occidente “irreparabilmente estraneo al ritmo naturale”. Questo è uno degli elementi maggiormente stigmatizzati da Manganelli e che rendono più chiaro il motivo per cui questo suo viaggio è stato definito, giustamente, mitopoietico. Ed è uno degli elementi su cui si è giocato, e ancora si gioca, il teatro occidentale in Africa. Manganelli ne è consapevole come è consapevole di essere, egli stesso, occidentale. Però ha l’onestà intellettuale di scrivere parole come: “Al pianeta Europa costruito e posseduto da un popolo di pianificatori stanziali egli opporrà mentalmente questo pianeta accidentalmente umano, abitato dalle estreme generazioni dei propiziatori, degli uomini esperti dei segni del tempo, dei ritmi lenti delle stagioni, capaci di interpretare la propria vita precaria nel colloquio con piogge e animali.” Manganelli lo sa, avverte che a lui e all’occidente l’Africa appare come qualcosa la cui “dimensione gli è storicamente negata”. E questo è il senso di colpa, quel senso di colpa che lo porta ad ammettere come l’Europa sia un deposito di “rovine significanti” mentre l’Africa è un deposito di immagini. E da qui, da questa rassicurante distanza immaginifica, parte la violenza occidentale che, mancando di riferimenti, ha ferito ancor più l’Africa inculcandole una speranza deforme, fatta di oggetti e di linguaggi: “L’Africa ha scoperto quegli oggetti, e già li usa, ma non può averne né quali né quanti le occorrono. In questo modo l’Africa impara a conoscere la propria indigenza.” Parole durissime che denunciano la colpevolezza occidentale. Il viaggio stesso, parlando di paesaggio, introduce un concetto europeo: “Il viaggiatore europeo percorre l’Africa portandosi dietro un sistema di immagini europee, ricordi elaborati culturalmente, schegge di idee […] certi gesti, certi oggetti europei, sono sintomi, si collegano alla condizione europea come una malattia.”
Manganelli è lucidissimo in queste sue pagine, nel suo denunciare come la peggiore ferita, quella incancellabile, sia proprio quella simbolica che all’Africa viene inferta anche solo “dal passaggio di un aereo, o dal contatto con il metallo di una macchina.”
Viaggio in Africa è un libro bellissimo e feroce, un atto di accusa e autoaccusa, un documento quasi algido di un insanabile e, ancora attualissimo, egoismo europeo, che non riesce ad avere uno sguardo altro sull’Altro. E che, forse, non lo può avere fisiologicamente.
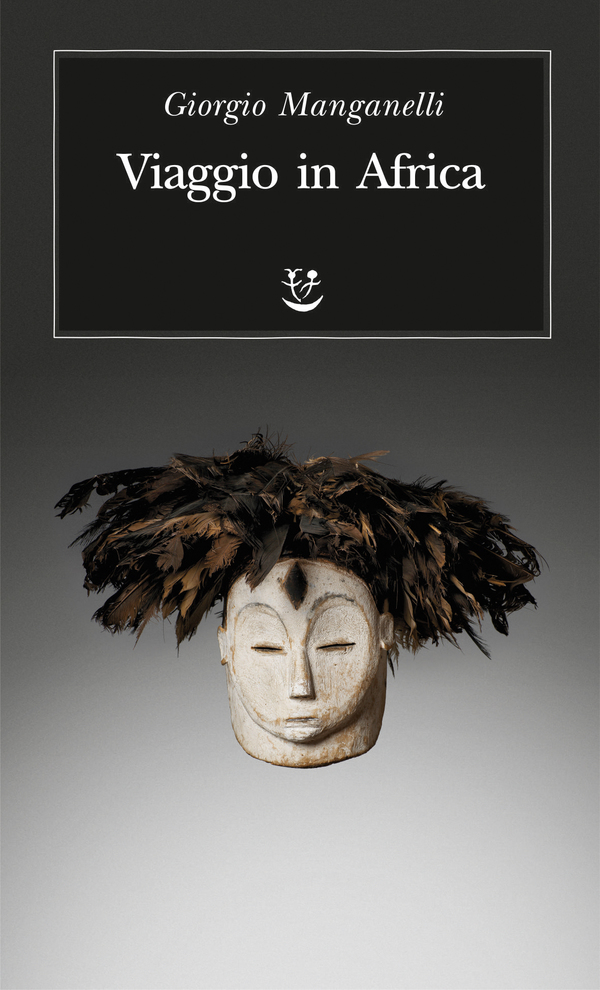 Viaggio in Africa
Viaggio in Africa
Biblioteca minima
Reportage, letteratura di viaggio
Adelphi
2018
71