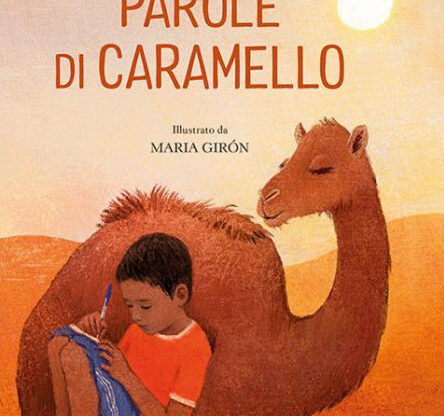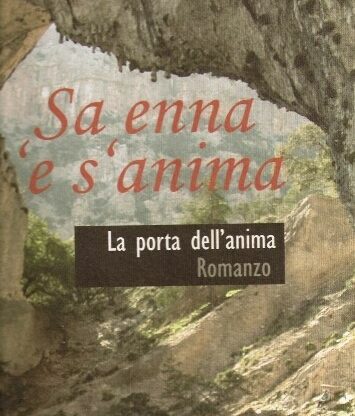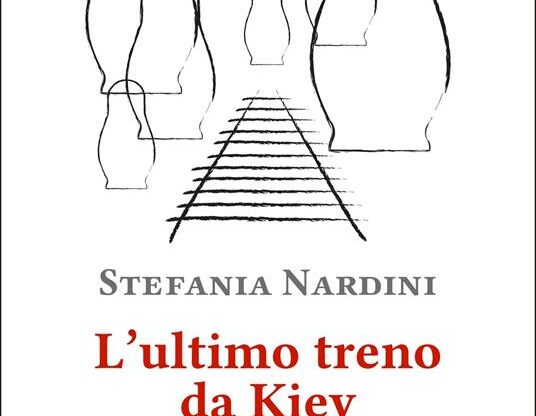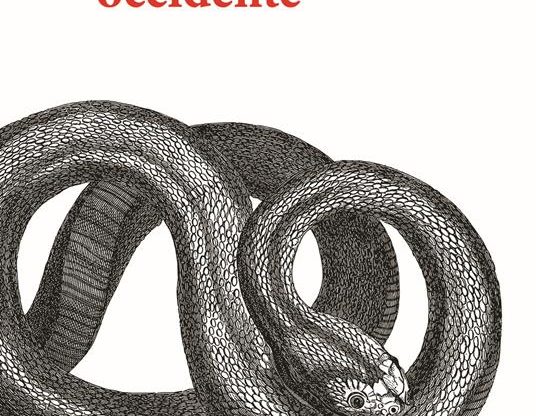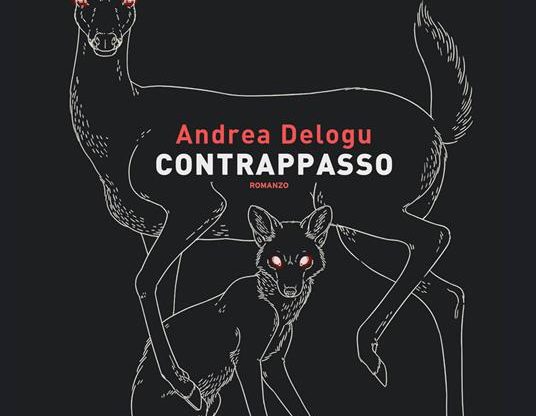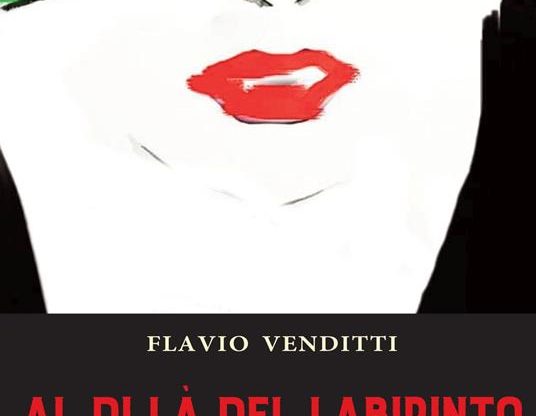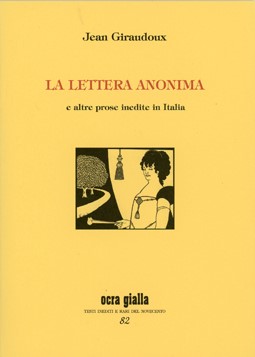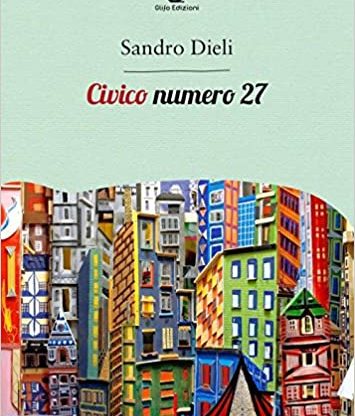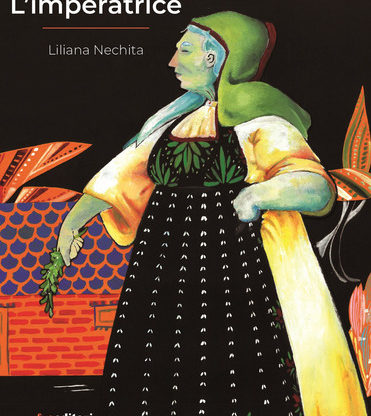Dopo Tutto quello che è un uomo, Szalay torna con un libro di racconti che, in realtà, è un romanzo
Di Geraldine Meyer
David Szalay ci aveva già conquistati con il precedente Tutto quello che è un uomo. Ma con questo Turbolenza ci lascia tramortiti, quasi sospesi, nella stessa aria d’alta quota in cui aleggiano i protagonisti di questi racconti. E già sulla forma racconto una fermata si impone. Una fermata di riflessione e di lettura. Perché questo sorprendente Turbolenza (magnificamente tradotto, come il precedente, da Anna Rusconi) è in realtà un romanzo in forma di racconti. E non solo per la circolarità delle storie (circolarità che il lettore scoprirà fino in fondo solo alla fine) ma per una forte unitarietà che i racconti non spezzano, non riducono a frammenti ma anzi esaltano nel ritmo sincopato della struttura.

Ma quella di Turbolenza non è una struttura circolare chiusa. Proprio dal legame tra i vari personaggi, trova la sua apertura, la sua irriducibile forza nel portare altrove, nello spostare sguardi e prospettive. In un libro che a tratti ricorda l’altrettanto magnifico film Sei gradi di separazione, quello che è il coprotagonista del racconto precedente, diventa il protagonista del racconto successivo, in una sorta di passaggio di testimone, di continua stesura di una partita doppia in cui, forse, il dare e l’avere non si pareggiano mai.
Turbolenza è un libro in cui l’aria, elemento che per eccellenza rappresenta il vuoto, diviene metafora di una fine; la fine di quella comfort zone che, con i piedi ben saldi a terra, ci sembra di poter tenere maggiormente sotto controllo. Qui invece, i vari protagonisti, si incrociano in luoghi di passaggio, in zone che sembrano zone franche ma che, in realtà, chiedono pegno. Forse un pegno ancora più grande. Aeroporti, cabine di aerei, taxi, alberghi. Scatole pressurizzate da cui ci si illude di passare, transitare solamente e che, al contrario, diventano luoghi in cui qualcosa accade e tutto cambia.
Solitudine, morte, malattia, rapporti umani sempre in bilico, azioni e reazioni. Tutto si tiene, ciascuna cosa appare collegata a un’altra in una turbolenza che è la vita stessa, che costringe a cambiare sguardo, cambiando anche colui o colei su cui lo sguardo si posa.
Uomini e donne colti in un momento di passaggio, sul limitare di decisioni prese, decisioni da prendere, svolte improvvise e drammatiche, accettazione della nostra semplice, grandiosa e difficile natura umana. Quella natura che, come spesso ci trattiene a terra, altrettanto spesso ci costringe ad alzare occhi e prospettiva, a muoverci in un elemento estraneo: l’aria. E a rivedere certezze, confini, limiti, paure. Aria come simbolo di ciò che, anche se confusamente, avvertiamo come qualcosa che potrebbe essere per l’ultima volta e che, proprio per questo, ci costringe a un bivio. O a una specie di preghiera. Turbolenza, talvolta, anche come “pensiero magico”, come se, all’improvviso, si aprisse uno squarcio e da quello squarcio potesse arrivare la soluzione. Non in senso di superamento ma nel senso di “slegame” con la paura stessa: “Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: Adesso muoio, sicuro che muoio. Stavo lì con gli occhi chiusi e pensavo: Se muoio io, per favore fa’ che Jamie viva. Fa’ che Jamie viva. Ti prego, fa’ che lui viva, così, per esempio, nel primo racconto.
Racconti-romanzo di uomini e donne ripresi, proprio come fosse una telecamera, nella più normale quotidianità, nella più prosaica tessitura di giorni, sentimenti e gesti. Ma, proprio per questo, immensi. Immensi loro e le loro vite. Immensa la scrittura di Szalay che, con semplici e sobrie pennellate, taglia la tela delle loro e delle nostre esistenze, leva facili approdi e, a ben vedere, ci fa volare ad alta quota senza cinture di sicurezza perché, scrive: “La gente poteva avere tante di quelle vite.”
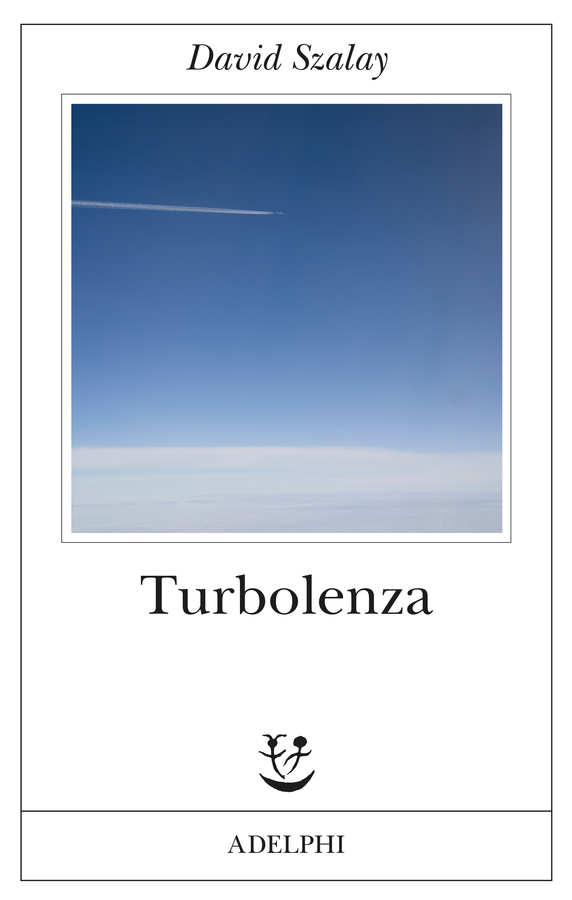 Turbolenza
Turbolenza
Racconti
Adelphi
2019
127